Il Cristianesimo e il Buddismo di fronte alla pace- Articolo di Karl M. Woschitz
 La questione della pace come “utopia di sopravvivenza globale” ha assunto una nuova urgenza, in considerazione dell’aperta e strutturale violenza delle guerre e della “mancanza di pace organizzata”. L’argomento della pace sembra essere diventato una vera e propria dichiarazione di intenti per entrambe le più significative e diffuse religioni, Cristianesimo e Buddismo. Infatti in entrambe la pace è un valore basilare e costituisce una sfida radicale nelle turbolente circostanze mondiali.
La questione della pace come “utopia di sopravvivenza globale” ha assunto una nuova urgenza, in considerazione dell’aperta e strutturale violenza delle guerre e della “mancanza di pace organizzata”. L’argomento della pace sembra essere diventato una vera e propria dichiarazione di intenti per entrambe le più significative e diffuse religioni, Cristianesimo e Buddismo. Infatti in entrambe la pace è un valore basilare e costituisce una sfida radicale nelle turbolente circostanze mondiali.L’assenza di pace accompagna la nostra storia come una lunga ombra scura. Inoltre un rapido sguardo alle religioni dei popoli mostra come, accanto alle divinità legate alla prosperità, a quelle della terra e dei cieli venerate in funzione della loro vicinanza alla vita umana, ci siano sempre state anche le divinità della guerra. Allo stesso tempo, l’utopia di un’età dell’oro dove non esistono né violenza né conflitto è da sempre annoverata tra le speranze e le aspirazioni degli esseri umani.
Una rapida occhiata alla storia del Cristianesimo e del Buddismo mostra quanto, durante la loro storia, queste religioni siano riuscite a produrre condizioni di assenza di pace. Nella tradizione di entrambe si incontrano discrepanze tra i messaggi di base e la loro manifestazione empirica; un’analisi della loro storia sembra suggerire la differenza tra la definizione teologica del “cristiano” e del “buddista” e la loro manifestazione storica, se si considera il loro essere compromessi in aggressioni militari e guerre. In questo senso emerge nuovamente la questione dell’impegno per la pace per il Cristianesimo e il Buddismo anche come compito di contribuire alla pace da un punto di vista sociopolitico. Quanto un modo di pensare repressivo, autoritario, punitivo e dogmatico gioca un ruolo nell’inibire un potenziale di pace?
Non solo il contributo delle religioni è spesso ignorato da molti dei circoli di ricerca pacifista scientifica, ma viene addirittura rifiutato o squalificato perché esse sono considerate antagoniste alla pace dal momento che svolgono generalmente una funzione stabilizzatrice del sistema.
La visione buddista
In quale misura è stato sviluppato l’argomento “pace” (e diritti umani) nella seconda grande scuola buddista, il Mahayana (“grande Veicolo”), che grazie alla sua capacità di accoglienza si propone di aprire il sentiero della redenzione a una gran moltitudine di persone, anzi a tutti gli esseri? […] A tale riguardo bisogna partire da tre concetti fondamentali: l’ottenimento della Buddità, “diritto di nascita” nonché il più alto obiettivo di tutti gli esseri; l’insegnamento della “mutua dipendenza”, ossia l’insegnamento della “relazione” o “relatività” di tutti gli esseri; e l’insegnamento del karma, che riguarda la causalità dell’azione.
L’ottenimento della Buddità
[…] Secondo i più alti insegnamenti del Buddismo tutti gli esseri viventi e le cose inanimate possiedono e hanno sempre posseduto la natura di Budda o l’essenza della Buddità (giapp. Bussho); è così possibile sperimentare questa assunzione di originale perfezione e conquistarla nella vita quotidiana. Secondo il Sutra del Nirvana, ogni essere umano ha in sé il potenziale di diventare un bodhisattva, cioè un “essere illuminato”. La strada è nella pratica sistematica del perfezionamento delle virtù, nello sforzo verso la Buddità attraverso le paramita (letteralmente azioni trascendenti, virtù trascendenti, perfezioni), che annoverano virtù quali la generosità, l’etica, la pazienza, l’energia, la meditazione e la saggezza.
Ma la caratteristica determinante per chi lotta per la Buddità è la compassione (karuna), una sorta di “empatia attiva” e affettuosa considerazione. Si estende a tutti gli esseri viventi ed è basata sull’esperienza dell”unità di tutti gli esseri nell’Illuminazione (bodhi). Per poter intervenire correttamente, karuna deve accompagnarsi con la saggezza (prajna). Un bodhisattva dà inizio per primo a un aiuto attivo, e desidera prendere su di sé le sofferenze di tutti gli esseri e trasferire agli altri i meriti karmici acquisiti con queste azioni.
La virtù della compassione è personificata dal bodhisattva Avalokitesvara (giapp. Kannon), uno dei più importanti bodhisattva del Mahayana. Il suo nome significa “Colui che percepisce i suoni del mondo” o anche “il suono che illumina il mondo”. L’altro aspetto essenziale della Buddità è invece la saggezza, (prajna), impersonata dal bodhisattva Manjushri (giapp. Monju) che significa letteralmente “Colui che è nobile e gentile”.
[…]
La mutua dipendenza
L’idea di mutua dipendenza (definita anche origine dipendente, n.d.r.) tra i fenomeni considera ogni cosa in relazione con l’altra. Nella raccolta del Canone Pali, il Majjhima-nikaya, si dice: «Se questo esiste, quello esiste. Se questo non c’è, allora anche quello non c’è. Poiché questo viene al mondo, quello viene al mondo. Poiché questo sparisce, quello sparisce». Dietro queste affermazioni c’è l’idea che nulla in questo mondo esiste di per sé, ma solo in relazione a qualcos’altro, e ciò implica un rispetto reciproco attivo del potenziale della Buddità inerente in ogni essere vivente. Nel Sutra del Loto (sanscr. Saddharma pundarika sutra, cioè “Sutra del Loto della Buona Legge”), che contiene i concetti essenziali del Mahayana assieme all’insegnamento dell’essenza trascendente del Budda e della possibilità di redenzione universale, c’è il discorso della pratica della compassione del bodhisattva Sadaparibhuta (giapp. Fukyo), che venerava ogni persona in virtù della sua potenziale Buddità. Raggiungere la Buddità significa cancellare la dipendenza e l’illusione egocentrica; dedicarsi agli altri con solidarietà e profondo rispetto.
Si ritiene che questo sutra sia stato esposto dal Budda verso la fine della predicazione dei suoi insegnamenti, ma che sia stato trascritto solo nel 200. Lo studioso cinese Miao-lo (711-782), restando nella tradizione del Sutra del Loto, sviluppò il principio di “inseparabilità di individuo e ambiente”, una relazione simbiotica tra persona e natura.
Il karma
L’idea del karma come causalità dell’azione implica che ognuno porti con sé una responsabilità etica delle proprie azioni: ognuno crea infatti il suo proprio karma attraverso il pensiero, la parola e l’azione. La parola sanscrita “karma” significa infatti “azione” e, in accordo con il pensiero buddista, è la legge universale di causa ed effetto. […] Nell’idea del karma, il mondo interiore e quello esteriore delle persone sono centrali, così come è attribuito grande significato alla memoria più intima dell’individuo, poiché solo questi possono assicurare una coesistenza pacifica ed armoniosa. […]
Un’analisi buddista dello stato della mente umana
Gli insegnamenti che giacciono alla base della fondazione del Buddismo e del Cristianesimo riflettono la predicazione e l’insegnamento del Budda e di Gesù, che vennero raccolti e trascritti dalle rispettive comunità dei discepoli. Nel primo Buddismo, inoltre, alla “parola del Budda” vennero correlate altre tradizioni. Le parti sostanziali della “parola del Budda” sono conservate nel canone Pali, una vera e propria rivoluzione spirituale che inizia con una analisi essenziale della condizione umana e offre a essa un sentiero spirituale terapeutico di salvezza. Il primo sermone, tenuto a Varanasi (Benares), mette in moto “la Ruota dell’insegnamento”; in questo discorso Shakyamuni afferma che tutto è dolore, transitorietà e “non-sé”, poiché le cinque forme dell’esistenza umana (le cinque componenti o cinque aggregati, n.d.t.) – la forma di esistenza corporea, i suoi sentimenti, le sue percezioni, l'”interpretazione” fisica e la coscienza – sono transitorie. La ragione per l’esistenza della sofferenza è allora l’avidità umana (la brama, sanscr. trsna) nei confronti dell’esistenza, che condanna al ciclo di reincarnazioni.
Secondo il pensiero buddista l’individuo è caratterizzato dall’avidità del suo desiderio di “voler essere sé”, dall’aggrapparsi al sé e dal correlare ogni cosa al sé. È la “brama” (trsna), dove sono pienamente espresse simultaneamente l'”ignoranza” del vero (avidya) e la persistenza del transitorio-apparente (maya). Data questa considerazione di futilità del mondo, l’obiettivo della salvezza risiede nel Nirvana. Si potrebbe tentare un parallelo con il Cristianesimo accostando il termine “brama” alla parola “concupiscenza”.
Con l’aiuto del cosiddetto “ottuplice sentiero” – base sostanziale dell’insegnamento buddista – questo ciclo di interminabili reincarnazioni potrebbe essere condotto alla pace, alla conoscenza, al risveglio e all’estinzione (Nirvana). Il punto di partenza di tale insegnamento è un atteggiamento umanistico unito a una profonda esperienza etica e psicologica e a una intensa ricerca spirituale condotta attraverso le più varie forme dell’insegnamento. Tutte le forme di insegnamento sono comunque accomunate da questa originaria ricerca sul modo di superare la sofferenza.
La questione centrale della secessione dal Brahmanesimo e dalla tradizione vedica operata dal Budda è la seguente: «È possibile esercitare dominio senza conquistare o essere conquistati?» (Samyutta-nikaya 4,20).
Il Buddismo e la pace
Assieme alla diagnosi della condizione essenziale di ogni persona fatta attraverso le cosiddette “quattro nobili verità” della sofferenza e delle cause che la generano, il Budda dà inizio a un percorso terapeutico gravido di conseguenze anche per la questione della “pace”. Nell’etica buddista, che oscilla tra i due differenti pilastri delle quattro nobili verità da una parte e del Nirvana come luogo di riposo dall’altra, l’idea della pace è fondamentalmente condotta su un doppio binario: la forma della “non-offesa” (ahimsa) – inizialmente intesa come regola radicale per la comunità monastica, più tardi estesa comunque come proibizione contro ogni uso della forza anche per tutti gli altri – e la forma di un impegno positivo nell’amore verso tutti gli esseri (maitri) e nella compassione (karuna). Come prerequisiti per l’esperienza di salvezza entrambe contengono un potenziale per una gestione pacifica del conflitto che trascende l’interesse individuale della persona impegnata nel processo di auto-perfezionamento.
Può questo potenziale di pace essere tradotto in una pratica politica e sociale, applicabile poi universalmente in linea generale? La nozione di ahimsa come forma di nonviolenza, cioè preferire la sofferenza piuttosto che rispondere alla violenza con la violenza, porta alla questione se possano esistere per il presente nuovi approcci derivati dalla tradizione del primo Buddismo. Sarvodaya è un programma di questo tipo, sviluppato in un contesto buddista e finalizzato allo sviluppo religioso ed etico-sociale dell’individuo.
Inoltre, in quale misura queste idee tradizionali possono essere reinterpretate nuovamente e ampiamente così da essere utili a una comprensione della pace realizzata attraverso una estesa riforma etica e sociale e basata allo stesso tempo su un cambiamento nella coscienza dell’individuo?

Utilizzare il tradizionale concetto di maitri (metta) come rispetto per tutti gli esseri viventi può costituire un buon punto di partenza per partecipare attivamente all’azione compassionevole (karuna) di rimozione della causa della sofferenza. Questa dovrebbe condurre, attraverso mudita – la simpatia – all’imparzialità (upekkha/upeksa), e quindi a una personalità armoniosa.
Attraverso gli scambi transcontinentali l’insegnamento buddista raggiunse la Cina tramite l’estremo orientale della Via della Seta e arrivò fino all’Asia orientale e al Giappone, dove sviluppò nuove prospettive e dimensioni spirituali. Il Buddismo poté dunque adattarsi ai più vari ordini sociali, come la società rurale del Sud est asiatico o la moderna società industriale del Giappone, così da meritarsi la definizione di fenomeno universale della cultura umana.
Nichiren (1222-1282), nel suo movimento di riforma, vede la verità onnicomprensiva nel Sutra del Loto: attraverso il pronunciare il Namu-myoho-renge-kyo, – “è reso omaggio al Sutra del Loto del Dharma meraviglioso” – si ottiene la condizione del massimo stato vitale del risveglio di Shakyamuni, dal quale deriva naturalmente ogni comportamento eticamente corretto. […] Nichiren applica il messaggio religioso del Sutra del Loto al suo tempo e al suo paese e ne trae energia e completa fiducia in se stesso. Anche se altre tradizioni buddiste avevano molto enfatizzato la salvezza individuale, Nichiren andò ben oltre, lottando per una riforma religiosa e sociale a livello dell’intero paese.
Il neo-movimento buddista Soka Gakkai (“Società per la creazione di valore”) è impegnato a proseguire su questo sentiero. Il motto della Soka Gakkai è promuovere la pace, la cultura e l’educazione attraverso il Buddismo, e in questo cammino l’aspetto esterno e mondano procede di pari passo con l’aspetto spirituale. Il movimento trae la sua fondamentale ispirazione da Nichiren e dal Sutra del Loto e si considera fondamentalmente laico e socialmente impegnato.
[…]
Le religioni e la pace nel mondo
La pluralità e diversità di visioni del mondo, la globalizzazione e l’innalzarsi della soglia di violenza sfidano entrambe le religioni a riorientarsi tra tradizione e rinnovamento in modo radicalmente nuovo. Nel frattempo è proprio la questione della pace a diventare un importante catalizzatore nonché indizio di cambiamento religioso. Il tema della pace tra le religioni diventa una missione pressante, nel senso del mantenimento della tolleranza e della ricerca di modelli di collaborazioni costruttive tra diverse posizioni religiose.
Subito dopo la conquista di Costantinopoli da parte degli Ottomani, nel 1453, Nicola Cusano scrisse il testo De pace fidei (per opporsi all’idea di una nuova crociata contro “gli infedeli”, n.d.t.), dove nel secondo capitolo afferma: «Così tu, al quale hai dato vita ed essere, sei quello apparentemente ricercato tra le diverse religioni in modi differenti, sotto diversi nomi, perché resti nascosto e inespressivo nel tuo vero essere» (traduzione diretta della citazione). Alle soglie di una nuova era Cusano tenta quindi di attribuire «tutte le differenze di religione all’unica vera fede» (cap. 3). Un’etica di pace deve riflettere norme di comportamento sovraindividuale, che hanno la più alta rilevanza morale. Etimologicamente la parola ethos originariamente significava “il posto abituale della vita”, cioè la casa, le abitudini, la personalità, i costumi e le tradizioni.
L’essere umano si sviluppa nella storia manifestandosi in qualcosa di predeterminato, nel senso che trova se stesso confrontandosi con un ambiente naturale preesistente al quale reagisce e nel quale si realizza (liberamente). Allo stesso tempo vive in un mondo di altri esseri umani nel quale si riconosce come individuo socialmente integrato. Si trova cioè in un mondo le cui relazioni sono regolate da princìpi di valore con una propria validità e dei propri obblighi, in bilico tra ciò che è e ciò che deve essere. Il problema vero è fare il punto su cosa significhi “dovere”, ovvero quale accento dovrebbe avere questa moralità.
Un’etica di pace deve rispondere a tre domande:
1. qual è la struttura necessaria al mantenimento della pace?
2. quale tipo di impegno deve comportare?
3. quali sono i contenuti della “pace”, lo “standard morale” che deve essere stabilito e legittimato?
Pace e giustizia
Le realtà sociali – e specialmente politiche – sperimentate storicamente sono state ripetutamente marchiate dalla violenza umana. È un fatto – latente o manifesto – che l’uso morale, fisico o psichico della violenza genera una forma di autodifesa individuale (diritto di resistere) o “collettiva” (bellum iustum, la “guerra giusta”) attraverso il postulato della “commensurabilità”. L’ipotesi teoretica di base è quella per la quale la violenza è semplicemente una funzione data – e perciò necessaria – di ogni ordine storico-sociale, indispensabile per difendere un sistema legale “liberale” o per liberare classi sociali oppresse. L’alternativa tra uso della violenza o della nonviolenza diventa quindi un “problema fittizio”. L’impersonale “regno di nessuno” dei burocrati – dal cui funzionamento dipende la soddisfazione dei più vitali ed essenziali bisogni della vita quotidiana all’interno delle moderne società industriali – promuove tendenze espansionistiche che sviluppano nuove forme di violenza. Gli atti di terrorismo diventano perciò le modalità della disperazione nei processi politici. La guerra, considerata come una naturale possibilità di un processo politico, provoca inoltre un incremento degli armamenti considerato come una naturale garanzia di “pace”.
L’assioma è valido: non c’è pace senza giustizia. Ma la giustizia può essere vista da molte angolazioni: come virtù, come base di legalità, come condizione fondamentale di vita sociale, come idea religiosa e come concetto teologico. Tutti questi aspetti si sovrappongono gli uni agli altri. Comunque, al di là delle loro differenti espressioni, resta l’unità di contenuto del «riconoscimento degli altri esattamente nel loro essere differenti» (F. Böckle). Da un punto di vista storico, questo implica una progressiva auto-esplicazione del comune senso morale dell’umanità e della sua entità, il cosiddetto “essere umano”, intesa come una missione da ricercare per un’intera esistenza.
In un’etica cristiana la questione si pone nei termini di come le persone possano essere giuste e come possano agire secondo giustizia. La prima questione si inquadra in una dimensione teologica quando l’apostolo Paolo per primo definisce le persone “assolte dalla vita” se “assolte da Dio”, attraverso la condivisione della salvezza. Qui la grazia divina è percepita in netta superiorità rispetto alla giustizia umana, considerata invece fallibile.
Comunque la misura della giustizia come fondamentale condizione di vita comune è sia la costante volontà di far sì che a ognuno siano attribuiti i propri diritti sia la volontà di amare, dove l’altra persona è vista come qualcosa in più della somma dei propri comportamenti. La giustizia come principio di ordine deve essere una giustizia “compensativa” tra i sottoinsiemi di un sistema sociale (equilibrio di interessi, contratto, scambio); deve essere una giustizia “distributiva” dell’intero tra sue parti assicurando a ciascuna un’equa porzione di benessere comune, e infine deve essere “legalmente” giusta nel comportamento dell’individuo verso la sua comunità (sistema legale, doveri verso il pubblico benessere). Oltre a questi aspetti si potrebbe parlare di una giustizia sociale che permetta lo spazio per lo sviluppo della persona.
In una “società responsabile” sono questi gli sforzi principali e prevalenti per stabilire e mantenere la giustizia sociale e per realizzare un’interazione partecipativa e vitale; per sancire il rifiuto del razzismo e delle tendenze discriminatorie, il rispetto per la dignità umana, i diritti umani e le libertà fondamentali compresa la libertà di religione.
Nella dichiarazione dei diritti umani, la “libertà dalla paura” è indicata come una delle questioni più importanti. L’angoscia esistenziale gioca un ampio e spesso decisivo ruolo sia nell’ambito individuale che in quello collettivo, e il suo superamento è uno dei più grandi sogni – un’utopia – dell’umanità sin dai suoi primordi.
Fattore promotore della pace è l’approfondimento della cooperazione internazionale tra gruppi etnici e stati vicini, a livello culturale, umanitario ed educativo, mediante scambi finalizzati a conoscersi reciprocamente sia a livello sociale che attraverso il dialogo religioso. A livello internazionale la questione “sviluppo” è il nuovo elemento essenziale della questione pace, che deve fronteggiare soprattutto il dramma del crescente impoverimento dei paesi del cosiddetto “terzo mondo”.
Pace e tolleranza
Malgrado alcune distorsioni, la tolleranza è diventata un principio di condotta necessario proprio in tempi di molteplici rischi dell’esistenza sociale. È un’espressione di generale solidarietà umana all’interno del processo di globalizzazione e dei problemi di una società pluralistica che sostiene il diritto alla vita e la volontà di evolversi di coloro che hanno un’opinione differente – specialmente delle minoranze e dei gruppi a margine. L’escalation di violenza e di intollerante fanatismo razzista o di stampo religioso può essere superata solo se le religioni e le filosofie di vita si rispettano le une con le altre ed esprimono stima reciproca. La tolleranza, come atteggiamento basilare della politica sociale, non può essere stabilita istituzionalmente, ma è una missione urgente dell’esistenza religiosa, motivata dalla convinzione di assoluta dignità e libertà dell’individuo così come dal riconoscimento della libertà e dell’individualità degli altri.
La tolleranza non reclama in alcun modo la resa “dei propri ideali”. Ne afferma l’esistenza ma non li rende assoluti, perché desidera permettere all’altro la sua alterità e proteggerla da minacce. In conformità con il Vangelo (Luca, 6:36): «Voi invece amate i vostri nemici, fate del bene, date in prestito senza sperar niente; allora la vostra ricompensa sarà grande; e voi sarete figli dell’Altissimo, perché è buono con gli ingrati e coi cattivi. Siate dunque misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro». Naturalmente la tolleranza non può essere illimitata: se l’altro danneggia gravemente se stesso e l’umana coesistenza attraverso il suo comportamento, in questo caso proteste, rimproveri e biasimo sono appropriati e anzi richiesti.
Pace, umanità, amore
[…] Entrambe le religioni sono dunque chiamate a contribuire a una “umanizzazione dell’umanità” e al superamento di un potere disumano. Ciò significa la conferma della volontà di sopravvivenza, che include il mutuo rispetto, la volontà di impedire che gli esseri umani siano degradati meramente a “mezzi”. Concretamente riguarda la volontà di ridurre i fattori negativi e i potenziali di sofferenza, di incrementare il benessere e la prosperità per tutti, di assicurare il diritto alla vita per ciascuno, di umanizzare il mondo del lavoro, di estendere la difesa sociale e l’assistenza sanitaria, di abolire la tortura e la pena di morte.
Dal momento che l’etica umana è parte dell’essere umano, entrambe le religioni sono chiamate a interagire per proteggere ciò che è umano, cioè agire in accordo morale al fine di creare le condizioni perché possano esistere quelle basilari forme di umanità riconosciute come elementari e indispensabili (rinnovabili per ogni generazione).
Dal punto di vista del Cristianesimo, un’autentica liberazione e umanizzazione dell’umanità ha a che fare con il riconciliarsi a Dio della sofferenza e dell’imperfezione umana. Allo stesso tempo il credente comprende la necessità di prendersi cura di tutti quelli che soffrono e sono in condizioni di infelicità se non di pericolo per la loro stessa vita. L’amore come integrale compimento dell’essere umano di conseguenza impegna la specie umana, in accordo con la comprensione di un’umanità cristiana dove non c’è valore per coloro che trascurano il “comandamento” dell’amore. Essere una persona non significa semplicemente essere tale solo per sé, quanto piuttosto trovare se stessi e realizzarsi nel “con-essere”, cioè nell’essere per gli altri e nell’interesse degli altri (cfr. Matteo 10:39). Questa sorta di sguardo aperto al dialogo verso un “tu” (cfr. Martin Buber; Ferdinand Ebner) rompe l’idea di una mera autonomia del sé come soggetto morale. In accordo con l’insegnamento cristiano, c’è una connessione diretta tra carità e amor di Dio. Dio si dispiega attraverso il principio dell’amore, così l’amore cristiano è un amore che risponde a questa proposta di amore. «Vi dò un comandamento nuovo, che vi amiate a vicenda: amatevi l’un l’altro come io ho amato voi» (Giovanni 13:34).
Oltre trenta anni fa è nata la “Conferenza mondiale delle religioni per la pace”, per contribuire alla realizzazione della pace nel mondo. Si voleva dar vita a un confronto sui gravi problemi e sugli impegni necessari ad assicurare una pace permanente. I punti fondamentali di discussione furono i seguenti:
La giustizia è un valore centrale indispensabile per la pace.
L’uso della violenza e della guerra non devono essere visti come un mezzo politico, bensì come un fallimento della politica. Gli atti della Commissione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) di Helsinki del 1975 indicano un sentiero verso la riduzione della tensione politica attraverso “strumenti per costruire fiducia”. Dovrebbero essere promossi e sviluppati concetti di educazione alla pace, risvegliando una consapevolezza internazionale a tale riguardo, anche attraverso la prospettiva di una formazione sovrareligiosa per la giustizia e la cooperazione.
Da un punto di vista individuale questo ha a che fare con alcune questioni: quali criteri di impegno assoluto e quali valori dovrebbero essere assunti come punti di partenza? Per cosa ha senso lottare? Cosa arricchisce, rende felice, arreca benefici ed è stimolante per le persone?
Si possono stabilire diversi gruppi di valori, affermati, rispettati o auspicati dall’umanità: valori religiosi, estetici, morali, artistici, economici e altri. Tali valori risvegliano gli interessi degli esseri umani, stimolano sfide e motivazioni, influenzano il loro pensiero e le loro azioni. L’umanità considera invece come disvalore ciò che percepisce come minaccioso e pericoloso, che rifiuta e respinge. Attraverso tali riconoscimenti e repulsioni le persone formano le basi della loro esistenza morale e del loro comportamento costruendo mentalità, convinzioni, atteggiamenti e azioni. Giustizia, verità, libertà, benevolenza, vita, sono i valori di riferimento, da praticare più e più volte. La loro importanza risiede nel fatto che sono elementi formativi per l’area intersoggettiva e personale e comportano un accresciuto senso di responsabilità.
La lotta per la pace vista dalla Cristianità
[…] È molto importante che l’etica teologica non reinterpreti erroneamente l’iniziativa di pace di Gesù (Matteo 5,38:41; 45:45: «”Voi sapete che è stato detto: occhio per occhio, dente per dente”. Ma io vi dico di non resistere al malvagio; anzi se uno ti percuote nella guancia destra, porgigli anche l’altra. Se uno vuole litigare con te per toglierti la tunica, cedigli anche il mantello. […] Ma io vi dico: amate i vostri nemici, pregate per coloro che vi perseguitano», n.d.r.) e non si metta al servizio della violenza. Solo nella realtà di un’etica cristiana pienamente compresa il messaggio evangelico di un Dio di amore, che rispetta la libertà delle persone, diventa per la coscienza moderna un’alternativa reale all’attuale legittimazione della violenza.
La proclamazione divina di Gesù e i suoi riferimenti a un regno di Dio esortano al cambiamento del comportamento umano (metanoia). La proclamazione dell’amore di Dio (Matteo 20,1:15) che supera ogni umana misura si riflette nella richiesta di redenzione (benedizione) e nel destinatario delle preghiere: Abba, o “amato padre”. Davanti a questo Dio redentore, la posizione di figlio – un cuore solo, fiducioso e indiviso (Matteo 6:25, 28:30; 10:29-31) (Matteo 6:24 par.) – è di per sé l’unica adeguata (Marco 10:15). Gesù realizza la volontà di Dio nell’unificazione dell’amore di Dio e della carità (Marco 12:28-34) e si rivolge all’interiorità delle persone, che non viene raggiunta da alcuna “legge”. La preghiera al Signore non solo chiede perdono per i peccati accumulati, ma anche protezione dalle nuove colpe. Sperimentare pienamente l’amore di Dio significa perdonarsi l’un l’altro, fino all’estrema conseguenza di amare il proprio nemico. Solo così può rompersi il circolo vizioso dell’odio in ogni dimensione dell’esistenza.
[…] Nelle sue riflessioni teologiche Paolo comprende la morte di Gesù (1 Cor 15:3) come la manifestazione ineguagliabile dell’amore di Dio che si espande all’umanità e come la devozione compassionevole di Cristo per noi (Rom 5:6-8; Gal 2:20). In tale contesto religioso ogni credente battezzato è dunque una “nuova creazione” (2 Cor 5:17). L’indicazione di questa via di redenzione implica comunque l’obbligo del suo adempimento esistenziale (Rom 6:1ff; 8:1ff). Abbracciare lo spirito di “gioia” e “pace” e altri suggerimenti morali (Gal 5:13ff) non è possibile senza un amore attivo (“la legge di Cristo” Gal 6:2) (1 Cor 8:10-13). Per il cristiano il comportamento morale si deve fondare quindi su basi cristiane. […]
Conclusioni
 Poiché ogni catastrofe della storia avviene anzitutto in ciò che è morale e mentale, prima di manifestarsi in conflitti bellici e lotte per il potere, la formazione della coscienza morale è una delle nostre più urgenti missioni. […] La pace, disse Immanuel Kant, sarebbe assicurata se il comandamento “non mentire” diventasse un principio. La sincerità è dunque un importantissimo elemento di pace. L’unicità dello scritto di Kant (Per la pace perpetua, 1795) consiste nel connettere ciò che “è”, cioè la storia e la politica, con ciò che “dovrebbe”, la morale. La pace consiste dunque nel rimuovere ogni possibile causa di guerra e può solo – considerando le “arti diaboliche” – trattarsi di pace nel mondo. Il potere intellettuale che guida la nostra epoca sembra essere quello della scienza. Le invenzioni fanno il giro del mondo, le armi atomiche possono cadere tra gli artigli di ideologie tiranniche e dittatoriali. Anche il linguaggio è diviso tra termini violenti e parole come pace, libertà e giustizia.
Poiché ogni catastrofe della storia avviene anzitutto in ciò che è morale e mentale, prima di manifestarsi in conflitti bellici e lotte per il potere, la formazione della coscienza morale è una delle nostre più urgenti missioni. […] La pace, disse Immanuel Kant, sarebbe assicurata se il comandamento “non mentire” diventasse un principio. La sincerità è dunque un importantissimo elemento di pace. L’unicità dello scritto di Kant (Per la pace perpetua, 1795) consiste nel connettere ciò che “è”, cioè la storia e la politica, con ciò che “dovrebbe”, la morale. La pace consiste dunque nel rimuovere ogni possibile causa di guerra e può solo – considerando le “arti diaboliche” – trattarsi di pace nel mondo. Il potere intellettuale che guida la nostra epoca sembra essere quello della scienza. Le invenzioni fanno il giro del mondo, le armi atomiche possono cadere tra gli artigli di ideologie tiranniche e dittatoriali. Anche il linguaggio è diviso tra termini violenti e parole come pace, libertà e giustizia.In una nota autobiografica, lo scrittore tedesco Reinhold Schneider (1903-1958) scrive: «Il santo si erge sempre più decisamente come avversario della violenza. Il problema del potere, la domanda: cosa è imperativo? Cosa è permesso? non mi lasciano un attimo di tranquillità. […] Ma allora io divento sempre più convinto dell’indistruttibile libertà dell’umanità – la sua libertà in Cristo – e della responsabilità cristiana verso il genere umano, verso i suoi pensieri, le azioni, i sogni e i desideri… il mio lavoro non è la costruzione di un sistema, ma un percorso che finisce nello scontro tra un’etica cristiana radicale e il potere mondano e ogni tentativo di deificarlo».
Reinhold Schneider perora la causa di un Cristianesimo radicale mai realizzato prima, che non può fiorire in una delle confessioni ma deve trovare la sua strada nel mondo, così che possa scaturirne la “pace”. Schneider ha ampliato e radicalizzato una tradizione europea di lotta per la pace, che ha i suoi predecessori in Erasmo, Sully, Leibniz, Kant, Hermann Hesse, Leopold Ziegler, Albert Einstein, Rousseau e molti altri.
Anche l’insieme dei valori cui fa riferimento F. Dostoewskij è più radicale di quello agognato da Friedrich Nietzsche, quando sottolinea che il forte non è colui che versa sangue bensì colui il cui sangue è versato.
La morale, comunque, resta affidata alla libertà personale e alla missione di un’intera vita.
Buddismo e Società n.105 – luglio agosto 2004
Dialogo: pensieri, parole e azioni-Intervista a Brunetto Salvarani
 Nato a Carpi (Mo), Brunetto Salvarani è stato insegnante di Religione nella scuola media per tre anni e poi docente di Lettere presso il Liceo Scientifico “M. Fanti” di Carpi, fino al 1995. Dopo la laurea in Lettere moderne ha conseguito il Baccellierato in teologia e la licenza in Teologia dell’Evangelizzazione. Da lungo tempo si occupa di dialogo ecumenico e interreligioso avendo fondato nel 1985 la rivista di studi ebraico-cristiani QOL, di cui è direttore, diretto dal 1987 al 1995 il Centro studi religiosi della Fondazione San Carlo di Modena e fatto parte delle redazioni delle riviste Il Regno e CEM Mondialità. Saggista, scrittore e giornalista pubblicista, collabora con parecchie testate. È stato tra i fondatori, sul piano nazionale, del Tribunale per i diritti del malato, e responsabile regionale per l’Emilia Romagna del Movimento Federativo Democratico.Da diversi anni è fra gli esperti nazionali della Caritas Italia, di Pax Christi Italia, di Rinascita cristiana e del Segretariato Attività Ecumeniche, e fa parte del Comitato “Bibbia Cultura Scuola”, che si propone di favorire la presenza del testo sacro alla tradizione ebraico-cristiana nel curriculum delle nostre istituzioni scolastiche.È membro dell’ATI (Associazione Teologi Italiani), il principale raggruppamento dei teologi del nostro paese, e dell’AETC, l’associazione dei teologi europei.
Nato a Carpi (Mo), Brunetto Salvarani è stato insegnante di Religione nella scuola media per tre anni e poi docente di Lettere presso il Liceo Scientifico “M. Fanti” di Carpi, fino al 1995. Dopo la laurea in Lettere moderne ha conseguito il Baccellierato in teologia e la licenza in Teologia dell’Evangelizzazione. Da lungo tempo si occupa di dialogo ecumenico e interreligioso avendo fondato nel 1985 la rivista di studi ebraico-cristiani QOL, di cui è direttore, diretto dal 1987 al 1995 il Centro studi religiosi della Fondazione San Carlo di Modena e fatto parte delle redazioni delle riviste Il Regno e CEM Mondialità. Saggista, scrittore e giornalista pubblicista, collabora con parecchie testate. È stato tra i fondatori, sul piano nazionale, del Tribunale per i diritti del malato, e responsabile regionale per l’Emilia Romagna del Movimento Federativo Democratico.Da diversi anni è fra gli esperti nazionali della Caritas Italia, di Pax Christi Italia, di Rinascita cristiana e del Segretariato Attività Ecumeniche, e fa parte del Comitato “Bibbia Cultura Scuola”, che si propone di favorire la presenza del testo sacro alla tradizione ebraico-cristiana nel curriculum delle nostre istituzioni scolastiche.È membro dell’ATI (Associazione Teologi Italiani), il principale raggruppamento dei teologi del nostro paese, e dell’AETC, l’associazione dei teologi europei. Attualmente è vicepresidente dell’Associazione italiana degli Amici di Nevé Shalom/Waahat al-Salaam, il “Villaggio della pace” fondato in Israele da padre Bruno Hussar, nonché coordinatore scientifico dal 1996 degli “Incontri cristiano-musulmani” di Modena per conto delle ACLI nazionali.
Nel novembre 2001 è stato ideatore di un Appello ecumenico per una Giornata nazionale del dialogo cristiano-islamico (per informazioni si può visitare il sito http:www.ildialogo.org), che si è tenuta in un centinaio di località, da cui è nato il volume, a cura di P. Naso e B. Salvarani, La rivincita del dialogo. Cristiani e musulmani in Italia dopo l’11 settembre (EMI, Bologna 2002).
Autore estremamente prolifico, suoi ultimi lavori sono: Per amore di Babilonia. Religioni in dialogo alla fine della cristianità (Diabasis, Reggio Emilia 2000), Le strisce dei lager. I fumetti e la Shoà, con Raffaele Mantegazza (Unicopli, Milano 2000) e – assieme a Fabio Ballabio – Religioni in Italia. Il nuovo pluralismo religioso (EMI, Bologna 2001). Più di recente ha pubblicato A scuola con la Bibbia. Dal libro assente al libro ritrovato (EMI, Bologna 2001, con prefazione di mons. Gianfranco Ravasi). È uscito nel giugno 2003 il Vocabolario minimo del dialogo interreligioso. Per un’educazione all’incontro tra le fedi (EDB, Bologna 2003), ed è appena comparso in libreria In principio era il racconto. Verso una teologia narrativa (EMI, Bologna 2004).
In procinto di partire per Israele per la Comunità Nevé Shalom/Wahat al-Salam – della cui associazione italiana è vice presidente – Brunetto Salvarani ci accoglie nel suo ufficio dell’assessorato alle Politiche giovanili del comune di Carpi, che sta lasciando dopo nove anni di lavoro. Teologo cattolico impegnato in prima linea nel dialogo interreligioso, saggista prolifico, politico dedito a rinnovare nei giovani il senso della comunità e della memoria, educatore, uomo di cultura, Salvarani ha un approccio decisamente poliedrico al mondo spirituale e alla realtà concreta.
Nell’aprile di quest’anno ha presentato presso il nostro centro culturale di Milano il suo libro Vocabolario minimo del dialogo interreligioso, nel quale parla dei presupposti necessari a un autentico confronto tra le fedi, in una sorta di educazione al dialogo. Da qui è nata l’idea di un’intervista.
Come cattolico, cosa la ha portata a occuparsi del dialogo tra le religioni? Da dove comincia il suo percorso?
La mia storia è quella di una classe ’56 che si trova a vivere il mondo delle parrocchie del post concilio e scopre che il Concilio Vaticano II, in un paese cattolico come l’Italia, ha aperto dei percorsi nuovi.
Parliamo dei capisaldi del Concilio. Noi non lo studiamo a scuola, e chi abbandona il sentiero cattolico non ha più occasione di approfondire questo tema.
In sintesi, il Concilio Vaticano II lancia alcune parole chiave che danno il senso di un’enorme distanza, non solo cronologica, dall’ultimo concilio vero e proprio, il Concilio di Trento (1545-1563). Ci sono più di quattro secoli di distanza, e c’è veramente l’idea di un nuovo modello di chiesa. La prima parola chiave, “popolo di Dio”, riguarda il tema ecclesiale (espresso nel documento Lumen Gentium) e promuove un modello di chiesa non più come gerarchia ma come popolo di Dio di cui fanno parte tutti, clero e laici. Un popolo di Dio che è fatto di gente con storie diverse, carismi diversi e uniti insieme. Viene così recuperata la concezione del Nuovo Testamento, degli Atti degli Apostoli, quando i cristiani vivevano con un cuor solo e un’anima sola.
Il secondo tema è quello scritturistico, espresso nel documento Dei Verbum, in cui c’è l’idea che la parola di Dio, la Bibbia, è qualcosa che fonda la comunità, che fonda l’appartenenza cristiana. La parola di Dio non è un elemento che appartiene peculiarmente alla gerarchia, com’era stato nella storia della chiesa cattolica, ma è un punto essenziale, il motore fondamentale della vita cristiana. Ciò apre l’idea che la comunità si fonda sulla lettura della scrittura, sulla meditazione.
Un terzo elemento, che si trova nella Sacrosanctum Concilium, è quello della liturgia. Qui c’è la frase famosa che dice che la liturgia (cioè l’eucaristia, il centro della liturgia cristiana) è fons e culmen, quindi da un lato è fonte, radice, e dall’altro è culmen, punto di arrivo. Il valore strategico della eucaristia diventa centrale, ed è quello che assieme alla parola di Dio muove la cristianità.
Un elemento ulteriore, che si trova nella Gaudium et Spes, è il discorso del rapporto chiesa-mondo, un tema cruciale che, soprattutto in quegli anni, si pensava un po’ ottimisticamente dovesse concludersi con un dialogo aperto e rispettoso. La Gaudium et Spes inizia con le parole: «Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore». Qui viene chiamata in causa la partecipazione diretta della chiesa, in particolare della chiesa locale. La chiesa non è un mondo separato, ma è invece profondamente partecipe di tutti i problemi della realtà.
C’è quindi una scommessa sulla possibilità di dialogo con il mondo contemporaneo, un mondo in cui c’era l’esplodere della scienza, la paura dell’atomica, una guerra fredda ancora molto intensa, il terzo mondo, tutti scenari da cui la chiesa cattolica non poteva chiamarsi fuori.
E l’ultimo tema, quello che forse ci interessa di più per la riflessione che stiamo facendo insieme, è espresso nella dichiarazione Nostra Aetate, un breve documento che parla della necessità del dialogo. Nel 1965, quando venne promulgata, c’era Paolo VI ed è il punto di partenza, in ambito cattolico, della strategia del dialogo ecumenico e interreligioso.
Questi cinque petali, per usare una metafora cara alla tradizione buddista, formano alla fine un fiore che si chiama ancora Chiesa cattolica ma che rispetto alla Chiesa tridentina (quella del Concilio di Trento) è, almeno potenzialmente, radicalmente diversa. Emana un profumo diverso.
Quando ha cominciato ad aprirsi a un confronto con le altre religioni?
A un certo punto ho scoperto che certi confini mi stavano un po’ stretti, che facevo fatica a restare nella dinamica tradizionale della parrocchia, delle comunità giovanili, e ho avuto bisogno di aprirmi ulteriormente. Io metto come data il 1974, il referendum sul divorzio, che ha puntato il dito sul tema della laicità dell’essere cristiani, sui rapporti nuovi con lo stato, con le altre confessioni religiose, con il marxismo.
In quel periodo mi sono messo alla ricerca di qualcosa di più, pur mantenendomi sempre in una dimensione cattolica. Non ho mai avuto dubbi di passaggi ad altre fedi religiose né dubbi di abbandono. Perplessità sì, molte ricerche sì. Però sempre all’interno di una tradizione.
E ho cominciato a scoprire l’altro, cioè gli altri percorsi religiosi, e questo è un elemento che trovo decisivo nella mia biografia. Gli studi di teologia mi hanno fatto scoprire la dimensione dell’alterità. All’inizio l’altro è stato l’ebreo, l’Ebraismo, che ho scoperto studiando la Bibbia e che ha voluto dire l’apertura di un mondo straordinario, la scoperta della radice santa della fede cristiana, rispetto alla quale nessun confronto con altri credi potrebbe essere paritario. È la scoperta di tuo papà, di tua mamma, che non avevi conosciuto, anzi, molto peggio, che ti avevano indotto a pensare fossero brutte persone. Una scoperta meravigliosa. Scopri soprattutto una relazione, scopri che vieni da lì. Anche se non ho mai pensato di diventare ebreo.
Ora sto per fare il decimo viaggio in Israele. La prima volta che ci sono andato, nel 1979, mi sono sentito girare la testa, mi sono reso conto della scoperta di un’appartenenza, di una passione. E quindi ho cominciato a occuparmi della comunità Nevé Shalom/Wahat al-Salam, della cui associazione italiana ora sono vicepresidente.
Cos’è la comunità Nevé Shalom/Wahat al-Salam?
Prima di parlare di Nevé Shalom/Wahat al-Salam è necessario parlare del suo fondatore, Bruno Hussar, una delle persone che più hanno contribuito alla Nostra Aetate con la sua eccezionale esperienza di uomo dalle quattro identità: «Sono un prete cattolico – diceva nella sua autobiografia Quando la nube si alzava – sono ebreo, cittadino israeliano, sono nato in Egitto dove ho vissuto diciotto anni. Porto quindi in me quattro identità: sono veramente cristiano e prete, veramente ebreo, veramente israeliano e mi sento pure assai vicino agli arabi, che conosco». Cosmopolita è dire poco. Hussar era un uomo di sogni, un uomo di visioni, e raccontava che in Israele si può sognare, perché lì i sogni si avverano. E lui stesso ha prodotto una serie di sogni, tra cui la Casa di Sant’Isaia – un centro di studi sull’Ebraismo – che è stata la sede di una serie di ricerche e di lavori sul rapporto tra Cristianesimo e Terra, tra Bibbia e Terra.
E ha fondato nel 1972 Nevé Shalom/Wahat al-Salam (che significa in ebraico e arabo “Oasi di pace”, l’oasi che il Signore promette in Isaia 32, 18: «Il mio popolo abiterà un Nevé Shalom»).
Questo è un altro sogno: l’ipotesi che, nonostante il conflitto, e attraverso la gestione del conflitto, si possa arrivare a una condizione di rispetto reciproco e di pace nel senso profondo.
Nevé Shalom/Wahat al-Salam è una comunità in cui convivono musulmani ed ebrei. Ci sono due luoghi cruciali di questo posto, che esiste ancora oggi sebbene Hussar sia morto nel 1996 e nonostante quello che sta succedendo in questi giorni, mesi, anni. Uno di questi è la Scuola per la pace, dove si è passati dalle scuole della guerra, che insegnano le armi, a una scuola che insegna la pace. E qui sono passate molte migliaia di persone appartenenti a diversi gruppi in conflitto. L’altro luogo è Dumia, che significa “silenzio profondo”. Hussar aveva inizialmente pensato a una specie di chiesa a tre ante con spazi per i cristiani, gli ebrei e i musulmani. Ma quando il “quarto”, un capofamiglia agnostico, gli fece notare che per loro lì non c’era spazio, capì che non era ancora il momento per una cosa del genere, ma era il tempo del silenzio. Una realtà che io trovo ancora più profetica, soprattutto se la leggo attraverso il filtro delle parole di Gesù alla samaritana, come è scritto nel Vangelo di Giovanni (4, 21-24): «Credimi, donna, è giunto il momento in cui né su questo monte né in Gerusalemme adorerete il Padre. […] Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità».
Hussar capì che la strada era il silenzio e Dumia è il segno del silenzio, anche perché in questo momento purtroppo gli esseri umani – lui lo ripeteva sempre – non riescono a far la pace, riescono solo a fare la guerra. Soprattutto in Israele le religioni non sono un luogo di pace, ma sono motivi di conflitti. Ecco allora il tentativo, la necessità di doversi fermare e stare in silenzio. È stato un grande privilegio averlo conosciuto.
Quanto è importante dialogare oggi?
Io credo che il dialogo oggi sia una parola indispensabile, una di quelle scelte di fondo decisive non per il Cristianesimo, l’Ebraismo, l’Islam, ma per l’uomo o la donna di fede oggi.
Ad Assisi, tanti anni fa, ebbi la fortuna di presentare tra loro Bruno Hussar e Raimon Panikkar (filosofo, teologo tra i principali esperti di relazioni interculturali), due “giganti” del dialogo. Eravamo davanti a Santa Maria degli Angeli e io chiesi quale sarebbe stato secondo loro il tema del prossimo concilio della Chiesa cattolica.

Nella diversità delle risposte si vede sia la distanza sia la sinergia tra i due: Hussar rispose che il prossimo concilio dovrà ragionare sulla riscoperta della dimensione ebraica di Gesù e sui riflessi di ciò sul piano pastorale, ecclesiale, persino dogmatico. Una sorta di nuovo Concilio di Gerusalemme, dopo quello del 48 d.C. di cui si parla negli Atti degli Apostoli. Panikkar rispose che secondo lui il Concilio Vaticano III sarà quello che metterà a confronto le diverse letture di Gesù che nascono soprattutto nel sud del mondo, in America, in Africa, in Asia, e quindi dovrà incentrarsi sul tema dell’inculturazione.
Il tema dei temi è quindi Gesù di Nazareth, ciò che distingue il Cristianesimo da tutto il resto. Due poli di lettura di Gesù, da un lato ebreo, figlio d’Israele, Rabbi, rivoluzionario ma figlio fedele di una tradizione, dall’altro Gesù che fa i conti con le diverse lingue, le diverse culture, soprattutto in una chiesa che si sta meridionalizzando, come scrive lo studioso Philip Jenkins nel suo ultimo libro La terza chiesa. Il Cristianesimo nel XXI secolo (Fazi editore 2004).
Questa lettura tra mondi diversi ha fatto sì che mi aprissi al dialogo a tutto campo. Ho scoperto l’Islam, stavolta non tanto per curiosità intellettuale ma per conoscere il mondo islamico italiano ed europeo con cui cominciavo ad aver a che fare direttamente. Poi mi sono avvicinato al Buddismo, e ho anche scritto con Fabio Ballabio un piccolo libro sul Buddismo in Italia.
Ho capito che non ci possono essere delle specializzazioni, nel senso che il dialogo è un imprinting, un modulo per rapportarsi all’altro, qualsiasi scelta politica, religiosa, culturale, sociale, egli o ella abbia fatto. Il problema è quello di porsi in un atteggiamento di dialogo con tutti e con tutto, e questo tutto nella tradizione cristiana è il creato, la natura, il mondo animale. C’è un disegno divino anche per loro: «Sappiamo bene infatti che tutta la creazione geme e soffre fino a oggi nelle doglie del parto» (Lettera ai Romani, 8, 19-22).
Il dialogo è un atteggiamento mentale, culturale e teologico, una scelta di fondo, una scelta strategica a partire dal Concilio Vaticano II. Giovanni Paolo II lo riprende continuamente. Nell’enciclica Ut unum sint del 1995 parla soprattutto del dialogo ecumenico, ma sostiene che il dialogo è il modo nuovo di essere chiesa.
L’essenza del dialogo sta nella relazione tra identità e differenza. Come porsi in un dialogo interreligioso, in un momento in cui sembra tutto religione, tutto mistico?
Questa è un’occasione e un problema insieme. Quando ho incominciato a studiare teologia gli amici mi guardavano più che stupiti, oggi invece tutto è religione, tutto è sacro. Parlo di quella che viene chiamata New o Next Age, che non disprezzo affatto perché esprime un bisogno di religiosità che non è stato interpretato dalle chiese storiche. Però un’operazione di mescolanza, ad esempio di pezzi di Buddismo, pezzi di Cristianesimo, pezzi di mistica ebraica, mi pare sia destinata a rimanere da un lato nel regno della fascinazione e dall’altro nella pura ricerca di tecniche appropriate, ma non dà senso alla vita.
Il rischio è quello del supermarket multireligioso, dove non c’è più nessuna distinzione. Il fatto che alla fine prevalga un senso indistinto di clima religioso è senz’altro meglio dell’ostilità, ma non è molto diverso dall’indifferenza.
L’incontro, il vero dialogo, non può avvenire solo sul piano intellettuale. Qual è il vero nucleo del dialogo?
Credo che il dialogo sia sempre una relazione, un rapporto. Quindi deve essere una relazione con qualcosa o con qualcuno. Può essere anche un rapporto intellettuale, quindi sia con una persona sia con un testo, con una musica, o un rapporto diretto tra persone, animali, ecc. Ed è una relazione anche con te stesso, un dialogo al tuo interno. L’esperienza monastica cristiana vive molto di questo tipo di dialogo con se stessi, anche di lotta con se stessi. Un’esperienza di silenzio che è così difficile ottenere oggi nel caos della nostra vita quotidiana.
Quindi il dialogo per me è soprattutto una relazione, una scelta, una strategia che ha in prima battuta una parola chiave: l’empatia nei confronti dell’alterità. Non ci può essere dialogo se non c’è una disponibilità empatica che – al di là delle definizioni teoriche e psicologiche – vuol dire guardare negli occhi qualcuno e non necessariamente considerarlo più un nemico che un amico. Quello che invece oggi accade. Noi viviamo in un mondo in cui l’altro è quasi sempre potenzialmente un nemico. Questo è il dramma che stiamo vivendo, la barbarie che stiamo vivendo. L’empatia secondo me vuol dire questo sguardo, questa tensione, questa apertura.
E cos’è che falsifica il dialogo?
Potremmo tornare a quello che sostenevaKant, usare l’altro come mezzo e non considerarlo un fine. Usarlo come strumento per fare qualcosa.
Nel suo libro Vocabolario minimo del dialogo interreligioso parla di diversi livelli di dialogo.
Sì. Può esserci un dialogo a partire dalla conoscenza reciproca semplice, quello molto umano che nasce dalla convivenza. C’è un dialogo morale, che vuol dire lavorare assieme in vista di obiettivi comuni, ai quali collaborano uomini e donne di religioni diverse. Poi c’è un dialogo più intellettuale, che nasce dalla teologia, dallo studio insieme, dall’individuare percorsi comuni tra le diverse correnti religiose. Il quarto livello è quello della spiritualità, che può arrivare anche a una preghiera, a una meditazione comune.
Occorrono però persone capaci di lavorare in un campo così delicato. Il dialogo è una cosa seria che rischia, se non lo pratichi con la dovuta attenzione, anche di bruciarti. Tante persone affascinate da questo tipo di possibilità si sono illuse e poi hanno avuto delusioni terribili.
Se ciascuno di noi ha un percorso personale, su cosa si incontrano le religioni? Si può trovare una modalità spirituale comune oppure è meglio lavorare su un’etica globale nuova che accomuni tanti percorsi diversi su alcune tematiche?
Questo è il percorso di Hans Kung per un’etica globale, dove le religioni dovrebbero costituire una sorta di anima comune del mondo. È un tema affascinante, ma è uno dei percorsi possibili.
Una cosa mi preme dire sul Buddismo. Nel quadro di una prospettiva mondiale io trovo che il Cristianesimo e il Buddismo abbiano una sintonia forte, profonda, che non viene sempre sottolineata: la dimensione anti idolatrica. Per me è la cosa che hanno maggiormente in comune.
Il fatto di mettere al centro l’essere umano?
Qualcosa di più. Yeshua ben Yosef (Gesù) e Shakyamuni Gotama Siddharta hanno una profonda sintonia, sono due anime grandi nel pensiero religioso di tutti i tempi. Entrambi lottano contro gli idoli, e contro il fatto che l’essere umano è bravissimo a costruirsi idoli da sé. Mi colpisce che questi due grandi uomini si trovino vicini su questo punto cruciale. Io credo che un rapporto approfondito tra cristiani e buddisti sulla scorta di questa prossimità teologica potrebbe essere molto ricco.
Perché invece, lo dico rischiando la banalità, l’immagine che gli occidentali hanno di solito del Buddismo è quello di una realtà totalmente disincarnata rispetto ai problemi della quotidianità, in particolare della politica, e di una religione talmente sui generis da non essere neppure una religione, bensì un pensiero filosofico. Direi che questo è un po’ il giudizio-pregiudizio diffuso.
Quale relazione c’è oggi tra religione e politica?
Sicuramente bisogna distinguere tra le diverse religioni, nel senso che il Cristianesimo ormai ha acquisito, salvo eccezioni, la dimensione della laicità della politica. La politica è una dimensione laica che non deriva direttamente da una scelta religiosa.
Oggi la politica sta vivendo uno dei momenti più bassi della sua storia, non solo in questo paese. La politica nel senso di democrazia rappresentativa, nel senso di servizio. E invece “servizio” oggi sembra quasi una parola fuori luogo. Con i riflessi che vediamo nelle giovani generazioni e che personalmente mi preoccupano molto.
Noi qui a Carpi abbiamo inventato degli stratagemmi. Uno di questi è la Giornata della comunità, che ha cadenza annuale, dedicata ai ragazzi che in quell’anno compiono diciotto anni e diventano adulti. Li raduniamo insieme e consegniamo loro due documenti: lo statuto del Comune di Carpi e la Costituzione. La chiamiamo Giornata della comunità, perché dietro c’è il desiderio di sviluppare la consapevolezza della dimensione di comunità del nostro paese e delle nostre città. E del fatto che oggi il tema centrale è quello di ricostruire da capo dei rapporti.
Nel dialogo oggi si deve ricominciare da capo, non dare per scontato nulla. Ripartire da zero e senza paura di far qualcosa in più, perché purtroppo ce n’è un bisogno enorme. Anche nella politica io credo che l’obiettivo sia quello di ricostruire un tessuto di rapporti che produca una comunità, una condivisione di storie. In questo senso, come produttrici di grandi racconti più o meno in crisi, le religioni e la politica potrebbero forse aiutarsi a vicenda. Per prendere poi strade diverse. In una condizione di rispetto reciproco e di attenzione verso le differenze potrebbero collaborare per ricostruire quella che il papa e il presidente della Repubblica Ciampi chiamano “riconciliazione delle memorie”, la ricostruzione di una memoria condivisa. Un processo necessario per far sì che anche in ambito politico i contendenti siano percepiti come avversari e non nemici. Avversari politici e non nemici da combattere.
Buddismo e Società n.105 – luglio agosto 2004
Il mondo ha bisogno di pace- Intervista a N. Radhakrishnan
 Il professor N. Radhakrishnan è uno di quei personaggi che coniugano in se stessi la figura dell’intellettuale e quella dell’attivista. Tra i principali conoscitori e interpreti della filosofia gandhiana, i suoi principali campi di attività sono l’allenamento dei giovani alla nonviolenza, lo studio comparativo delle religioni e la ricerca sui problemi della violenza.
Il professor N. Radhakrishnan è uno di quei personaggi che coniugano in se stessi la figura dell’intellettuale e quella dell’attivista. Tra i principali conoscitori e interpreti della filosofia gandhiana, i suoi principali campi di attività sono l’allenamento dei giovani alla nonviolenza, lo studio comparativo delle religioni e la ricerca sui problemi della violenza. Ha scritto e curato più di trenta libri, tra i quali: Gandhi in the Global Village (Gandhi nel villaggio globale); Daisaku Ikeda in Pursuit of a New Humanism (Daisaku Ikeda e lo scopo di un nuovo umanesimo); Ikeda Sensei, The Triumph of Mentor-Disciple Spirit (Ikeda Sensei, il trionfo dello spirito di maestro-discepolo); The Quest for Tolerance and Survival (La richiesta per la tolleranza e la sopravvivenza); A Nation in Transition: India at 50 (Il cinquantenario dell’India: una nazione in transizione); Gandhi’s Challenge to Religious Intolerance (La sfida di Gandhi all’intolleranza religiosa); Gandhi, Youth and Nonviolence (Gandhi, i giovani e la nonviolenza); Shanti Sena; Training in Nonviolence – A Trainer’s Manual (Allenarsi alla nonviolenza – un manuale per l’istruttore); Khan Abdul Ghaffar Khan: Messenger of Harmony (Abdul Ghaffar Khan messaggero di armonia); Sparks of Nonviolence (Scintille di nonviolenza); G. Ramachandran: A Study (G. Ramachandran, uno studio); Complementarity of Gandhi and Nerhu (Complementarietà di Gandhi e Nerhu); Multiple Streams of Peace Movements (Correnti multiple di movimenti per la pace). Dirige anche tre giornali: Journal of peace and Gandhian Studies, Journal of Gandhi Smriti e Nonviolent Revolution.
Ha tenuto e organizzato corsi su Gandhi, i movimenti per la pace, gli eserciti pacifici (Shanti Sena) e i diritti umani in più di trenta università del mondo. Oltre ad aver rappresentato l’India in diversi forum internazionali, è stato a capo di una delegazione di studiosi e artisti indiani presso l’UNESCO in occasione del 125° anniversario della nascita del Mahatma Gandhi.
Attualmente N. Radhakrishan dirige la fondazione Gandhi (Gandhi Smriti) e l’International Centre of Gandhian Studies and Research di Nuova Delhi, con il patrocinio della Gandhi Smriti e Darshan Samiti del governo indiano.
È presidente onorario della Soka Gakkai indiana.
L’infernale traffico di Delhi imbottiglia la vecchia Hindustani Ambassador tra camion, risciò a tre ruote, motociclette sgangherate e limousine tirate a lucido.
Finalmente l’auto imbocca un viale e poi, come un miraggio dopo l’inquinamento e il rumore delle strade, ecco il portone di accesso ai campus della Gandhi Smriti e della Darshan Samiti. Tutti si fermano un attimo, vogliono vedere chi sono i passeggeri, interrompono il lavoro e, con la tipica curiosità indiana, guardano oltre i finestrini: i giardinieri che lavorano per tenere curate le aiuole che circondano i vari edifici; i ragazzi che si occupano della casa museo, il luogo dove Gandhi trascorse gli ultimi giorni della sua vita; i volontari che partecipano alle tantissime attività della Fondazione. La Gandhi Smriti ha sede nella Old Birla House al numero 5 di Tees January Marg, ed è il luogo dove “l’epica esistenza”, come avvertono le guide, del Mahatma Gandhi terminò il 30 gennaio del 1948, che dal 9 settembre del 1947 era qui ospitato. La casa custodisce moltissimi oggetti che ricordano quegli ultimi 144 giorni. Appartenuta all’industriale B. D. Birla, amico di Gandhi, fu acquistata dal governo indiano nel 1971 e venne convertita in National Memorial of the Father of the Nation con l’apertura al pubblico dal 15 agosto 1973. È dunque una sorta di museo, che può essere quotidianamente visitato e dove si può assistere alle proiezioni di film su Gandhi e sul movimento per la libertà, si possono visitare le stanze del Mahatma ma anche mostre fotografiche. Qui si svolgono seminari e simposi e qui si trova anche una piccola ma ricchissima biblioteca che custodisce testi introvabili. Poco oltre la Gandhi Smriti si trova l’International Centre of Gandhian Studies and Research, un vero e proprio campus – con sale per conferenze dove vengono tenuti seminari, convegni, workshop, mostre, programmi di scambio, corsi universitari, forum e altro – in grado di ospitare professori e studenti desiderosi di approfondire il pensiero di Gandhi.
La Gandhi Smriti è il luogo dove lavora il Professor N. Radhakrishnan, attivamente impegnato nella propagazione della pace attraverso l’insegnamento di Gandhi. «E il luogo è indubbiamente adatto» spiega con un sorriso il professore. «Qui tutto parla del Mahatma: abbiamo persino voluto mettere una piccola lapide nel giardino del retro, per segnare esattamente il punto in cui Gandhi fu colpito. Delle impronte di piedi mimano i suoi ultimi passi, dalla casa al giardino».
Quali sono le finalità della Gandhi Smriti, la Fondazione Gandhi?
Al primo posto abbiamo l’esigenza di portare avanti e di diffondere un messaggio di armonia, come era nel pensiero del Mahatma e nelle sue azioni, per esempio per risolvere o attenuare le tensioni sociali, o per smorzare o far scomparire la guerra delle caste che nonostante tutto ancora esiste e infiamma il nostro paese.
Le nostre finalità potrebbero essere spiegate da differenti punti di vista: abbiamo innanzitutto attività legate ai bambini, perché sono il futuro e vengono “costruiti” attraverso l’istruzione: quindi, poiché il nostro futuro è creato dall’educazione, stiamo “seminando” per la creazione di una società migliore. Gandhi aveva una visione molto chiara dell’istruzione, che dunque per noi resta importantissima. Il nostro è un complesso educativo multi-funzionale dove si cercano e si sperimentano modalità educative che siano adeguate ai mezzi di comunicazione usati dai bambini. I bambini comunicano attraverso il gioco, e in particolare attraverso la musica, i racconti, la pittura, le marionette, il ballo.

Un altro punto di vista riguarda chi si occupa dei bambini, i genitori e gli insegnanti, che dovrebbero perciò essere persone motivate e consapevoli, dedite alla creazione di valore. Lo riteniamo un fatto fondamentale: la creazione di valore, qualcosa di cui nessuno parla, sta, secondo me, nel riuscire a preservare il valore intrinseco di ogni società, di ogni civiltà. È dare il giusto peso, la giusta importanza alla differenza. Il valore è il carattere di una società; la società in cui viviamo sta perdendo i suoi valori. È divenuta ormai un villaggio globale. Ma in questo villaggio globale c’è il rischio altissimo che si perda l’individualità, la caratteristica di ognuno, sia a livello individuale che collettivo. Le diversità dovrebbero essere sempre mantenute, anzi di più: dovrebbero essere preservate. Dovremmo mirare a una società diversa, pluralistica, perché globalizzazione non deve e non può significare uniformità. Se tutti ci somigliassimo sarebbe un mondo bruttissimo: il fatto che io abbia un colore, che un’altra persona ne abbia un altro, che qualcuno sia basso, qualcun altro magro e un altro ancora grasso è un fatto bello, prezioso. La varietà è bella. Gandhi parlava proprio di questo: di cultura dell’individuo. Eccolo il difficilissimo compito assegnato a genitori e insegnanti: conservare valori differenti nel contesto globale. Non si vuole essere colonizzati, si vuole essere parte della cultura globale emergente, ma non di una globalizzazione voluta a tutti i costi, a costo quindi anche della perdita dei valori tradizionali, dei settori tradizionali, delle differenze tra i popoli; la globalizzazione dovrebbe servire solo per aumentare il benessere generale. Aiutiamo bambini, insegnanti e genitori invitandoli qui, a seminari o discussioni, o andando da loro con mostre e altro.
Anche il lavoro manuale è molto importante per i bambini…
Esattamente. Gandhi, tra l’altro, considerava molto importante la filatura manuale. Aveva uno strumento, una sorta di arcolaio, che usava per filare il cotone. Diceva che usando le mani si lavora spiritualmente, e cercava di insegnare l’unità attraverso l’espediente del lavoro manuale dell’arcolaio, mettendo in relazione l’abilità delle mani con la mente. Qui stiamo cercando di trasmettere ai bambini alcuni valori associati ai lavori manuali, insieme all’importanza di fare insieme, collettivamente. Quando si canta gioiosamente insieme si sente profondamente di non essere soli. Quando si lavora insieme, si sente di essere in gruppo. Ma quando, per esempio, si parla, qualcuno dorme, qualcun altro si guarda intorno, qualcun altro ancora si annoia, cosa che non accade quando si canta in coro o si lavora manualmente, perché in quei momenti ci si trova insieme.
Lavorate anche fuori Delhi?
Ci occupiamo di tutta l’India. Le nostre attività si indirizzano ai bambini meno privilegiati, che vivono in situazioni poverissime, sono orfani, non hanno casa o sono portatori di handicap. Organizziamo anche centri di assistenza temporanea per persone povere, per lebbrosi, per donne bisognose. Abbiamo il numero più alto di organizzazioni di volontariato del mondo e molte di queste organizzazioni svolgono un lavoro di ottimo livello, in particolare nel campo dell’empowerment dei deboli, una parola che significa dare loro potere, dare potere ai meno privilegiati (il processo definito empowerment indica acquistare padronanza di se stessi e dei propri affari, dirigere personalmente il proprio destino e influenzare la propria vita, n.d.r.). Un’altra area di cui ci occupiamo è fare in modo che le donne si rendano conto dei loro diritti, per esempio, perché questa è una società dominata prevalentemente da uomini. Questo è l’empowerment delle donne.
A proposito dell’empowerment delle donne, com’era Gandhi nei loro confronti?
Gandhi è stato il primo leader moderno che abbia portato un’alta percentuale di donne nell’attività politica. Le donne sono state sue grandi sostenitrici, fin da quando si trovava in Sud Africa. Anche sua moglie gli disse: «Le donne ti capiscono molto meglio degli uomini». Era molto comprensivo riguardo ai problemi delle donne. Una volta affermò: «La forza morale di una nazione non si capirà né dal benessere economico né dalla prosperità economica. Il benessere morale si capirà dall’ampiezza della libertà di cui godranno le donne».
Gandhi aveva molte qualità prettamente femminili, come la gentilezza. Favorì l’istruzione delle donne, organizzò molte istituzioni destinate a loro, le incoraggiò ad andare a scuola e voleva, come ho già detto, che le donne prendessero parte alla vita politica. Disse, però, che avrebbero dovuto comunque prendersi cura delle loro case e dei loro mariti, perché erano anche madri. Secondo Gandhi le donne hanno il compito di portare salute alla società; diceva che avrebbero dovuto guadagnare di più per essere indipendenti, per non dipendere dagli uomini. Voleva creare le condizioni affinché le donne potessero partecipare con pari opportunità alla vita politica ed economica del paese. Voleva l’uguaglianza. Voleva che le donne fossero autosufficienti. Non voleva che fossero dipendenti dagli uomini e chiese loro di non sposare individui che le avrebbero rese inferiori, dipendenti. Fu un grande sostenitore dell’emancipazione femminile. Il risultato è che oggi c’è una legge, allo stadio finale dell’approvazione in Parlamento, che propone di riservare il 33% dei posti di lavoro alle donne.
Gandhi era una persona veramente grande: più di cento anni fa affermava che la verità è molto importante e che la struttura morale di una società non può basarsi sul benessere economico ma sulla libertà delle donne. Era un vero rivoluzionario.
C’è ancora un’influenza di Gandhi negli indiani di oggi?
L’influenza di Gandhi c’è in ogni indiano, in quantità variabile, ma c’è. Io ritengo che senza l’influenza di Gandhi, senza la sua eredità, senza la sua presenza nella storia indiana e, in un modo o in un altro, nella società e in ogni cittadino indiano, noi non avremmo potuto essere la nazione che siamo oggi. L’India è una nazione di grandi paradossi e di enormi contraddizioni. Abbiamo diverse migliaia di gruppi etnici. Parliamo ufficialmente ventisette lingue diverse, e se provate a immaginare con quanta difficoltà comunicate in Europa dove ve ne sono meno della metà, potete capire quanto sia difficile qui da noi. Accanto alle ventisette lingue conosciute ve ne sono altre 400, tra lingue e dialetti, non riconosciute. Ci sono moltissimi gruppi etnici e tante diverse religioni: ebrei, giainisti, buddisti, zoroastriani, indù, cristiani, musulmani. Ci sono decine di Stati all’interno dell’India e ognuno differente in modo drammatico dall’altro: io, per esempio, vengo dall’estremo Sud, dal Kerala; alcuni miei colleghi vengono dal Kashmir, altri da Bombay, tutte situazioni e storie molto diverse. Oltre a essere una società multilingue, l’India è anche un posto dove esiste una grandissima sperequazione economica: il 43% della popolazione vive ancora sotto la soglia di povertà. Molti bambini anche d’inverno vanno in giro per le strade senza i vestiti adatti, mendicando.
Ora: cosa ha fatto Gandhi? In campo religioso, per esempio, ha fortemente voluto uno statuto speciale per le religioni minoritarie. In campo politico ha spinto il paese all’indipendenza. E quando nel 1947 gli inglesi lasciarono il paese e l’India divenne indipendente, vennero dati uguali diritti a tutti i cittadini proprio grazie all’influenza di Gandhi. Senza di essa probabilmente l’India apparterrebbe al vostro gruppo di paesi, sarebbe un satellite (seppur enorme) dell’Europa. Se guardiamo, poi, agli ultimi cinquantadue anni, all’India del dopo-indipendenza, ci si accorgerà che il livello di povertà assoluto è sceso, è diminuito. Certo, lo abbiamo visto, esiste ancora: ma è diminuito e il nostro obiettivo è riuscire a far sì che nei prossimi dieci, quindici anni la povertà relativa venga contenuta ancora. Probabilmente non potrà essere eliminata. E questo per il semplice motivo che siamo troppi, e continuiamo a crescere. Infatti siamo cresciuti in modo esponenziale, anche se l’India di oggi è una nazione in surplus, vale a dire che è una nazione che produce ed esporta – a differenza del 1947 quando andavamo in giro per il mondo con ciotole per l’elemosina chiedendo grano, latte in polvere, chiedendo tutto. Dai 360 milioni che eravamo nel 1947 siamo arrivati, cinquantadue anni più tardi, al miliardo. È lì che abbiamo sbagliato. Se il numero di abitanti fosse minore, l’India non sarebbe mai arrivata a essere quello che è oggi.
Per tornare all’influenza di Gandhi in India, essa dovrebbe essere vista a diversi livelli. Non tutti vestirebbero come Gandhi. Non tutti vivrebbero il tipo di vita semplice che Gandhi conduceva. Eppure tutti dovrebbero seguire la strada della nonviolenza, anche perché ne abbiamo tanta, di violenza: ma bisogna ricordare che siamo ormai oltre un miliardo, come dicevo, più del totale dell’Europa, cioè un quinto della popolazione mondiale. In questo miliardo di persone ci sono tanti giovani che hanno entusiasmo, spirito di avventura e forza, e vogliono il cambiamento. Molti giovani probabilmente pensano che Gandhi rappresenti una filosofia di vecchio stampo, una filosofia che non è in grado di dar loro ciò che vogliono, ciò che cercano. Purtuttavia si rendono conto che la violenza causa la violenza, che l’odio porta maggiore odio, mentre le qualità pacifiche, come la tolleranza, guariscono. Queste sono le qualità di cui necessita la società indiana. E sono qualità che derivano direttamente dal pensiero e dalle azioni di Gandhi.
Dottor Radhakrishnan, lei ha dedicato tre saggi a Daisaku Ikeda, presidente della Soka Gakkai Internazionale. Come mai?
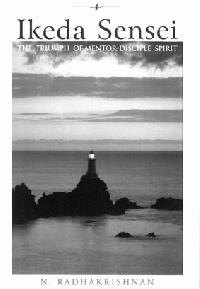
Perché considero il presidente Ikeda il Gandhi moderno. Colui che ha riportato alla ribalta mondiale, in questo mondo tecnologicamente controllato, l’etica, la moralità, supportate da un forte senso religioso. Chi pensa alla religione oggigiorno? La gente non pensa alla religione. Per religione non intendo la religione tout court, ma un forte impegno, una forte fede nella nostra condizione di esseri umani e nella nostra abilità di cogliere, negli altri, l’essenza, con i propri spazi interiori. Non siamo in grado di vedere Dio. Nessuno di noi è in grado di vedere Dio. Per questo la nostra vita ha bisogno di luce, della luce del giorno: è proprio questo che si propone la Soka Gakkai.
Non a caso sulla copertina dell’ultimo libro dedicato a Ikeda ho voluto che fosse riprodotta la fotografia di un faro che illumina, solitario e potente, la costa. Perché la nostra vita può essere considerata come una barca, una nave in alto mare che è scossa, che sobbalza, che veleggia in mezzo a difficoltà, dubbi, scontentezze, frustrazioni, avversità, paure, odi, complessi che la scuotono, la sbattono di qua e di là. Non sappiamo se sopravviveremo o se naufragheremo: è, in un certo senso, come se ci trovassimo sul Titanic, una nave costruita stupendamente, talmente tanto bene da non far venire in mente a nessuno che potrebbe affondare. Anche il Titanic sembrava indistruttibile, la migliore nave del mondo, eppure affondò.
In questo senso ha grandissima importanza il fattore spirituale, ed è parimenti importante nutrire la consapevolezza che abbiamo a disposizione solo una vita e che proprio in questa dobbiamo lottare per un nuovo rinascimento, basato sulla profonda consapevolezza che siamo tutti interdipendenti. Comprendere che siamo tutti interrelati, che non abbiamo un’esistenza indipendente, è una sorta di dovere, di necessità della nostra condizione umana. La tua felicità dipende dalla mia. La tua felicità dipende dalla nostra. Nessuno può essere felice in modo esclusivo quando tutti gli altri sono infelici. Gandhi insegnò e visse in questo modo: nessun altro leader dopo di lui ha agito, vissuto e pensato così se non, secondo me, il presidente Ikeda. E lo dico da non buddista: io sono nato in una famiglia indù e mantengo la mia religione di nascita, pur essendo ormai da qualche tempo, proprio perché ne comprendo profondamente la filosofia e ne sostengo le azioni, presidente onorario della Soka Gakkai indiana.
Ma al di là del mio credo, da persona che opera per la pace e l’educazione riconosco la grandezza e il significato di questo movimento, che sta diffondendo ciò che si chiama felicità. Perché insegna e diffonde un’ispirazione vibrante e vitale: in oltre un centinaio di paesi del mondo la gente sta recitando Nam-myoho-renge-kyo. E sta seguendo la Soka Gakkai, fortemente ispirata da Daisaku Ikeda e che, proprio grazie al pensiero di questo maestro, ha avuto la diffusione che oggi vediamo. Se la scienza e la tecnologia ci hanno reso demoni, perché snaturano il nostro essere umani, il compito della religione, come dicevo, è quello di percepire, in se stessi e negli altri, l’anima, e in questo restare attaccati all’umanità. Noi pensiamo di sapere tutto, ma alla resa dei conti siamo molto fragili e deboli. Insomma ammiro e percepisco profondamente l’ispirazione di quest’uomo. E ci capiamo reciprocamente.
Lei trova che ci sia un legame tra la filosofia di Gandhi e la filosofia del movimento portato avanti da Daisaku Ikeda?
Ci sono un’affinità e una somiglianza molto strette. Se qualcuno mi chiedesse perché sostengo la filosofia della SGI, che cosa vi trovo, che cosa mi colpisce, la mia risposta è molto semplice. Per me Ikeda è il Gandhi vivente. Lui è Gandhi. Per noi Gandhi non è morto e sento che nella personalità di Ikeda vi sia una sorta di successione. Questo è il motivo per cui mi sento molto legato al vostro Sensei. Inoltre ritengo che la sua visione della filosofia di Gandhi, la sua analisi della filosofia gandhiana in termini di sfida sia un’analisi brillante.
Qual è secondo lei il maggior merito del presidente Ikeda?
Il fatto che sia in grado di ispirare così tanti giovani: trovo che sia una qualità assolutamente grandiosa. Gandhi era in grado di scoprire e di nutrire molti talenti: grazie a questa sua qualità il movimento è potuto andare avanti. Anche Ikeda ha un tale dono, la capacità di scovare “bodhisattva”, la volontà di distribuire fiducia, l’esigenza di iniziare alla leadership. Con una così vasta profondità e ampiezza non si era ancora verificato, nell’ambito del Buddismo del Daishonin, un tale fenomeno: e questo è il motivo per cui, per alcune centinaia di anni, questo movimento ha avuto un’influenza per così dire “sobria”. Oggi è diventato qualcosa di diverso, una sorta di nuova rivelazione umana di Dio, una nuova religione in grado di cambiare il mondo.
L’intervista è finita. Fuori c’è ancora il sole che sembra più forte dopo la penombra della stanza; i ragazzi del giardino fermano il lavoro e, con gli occhi che ridono, si fanno intorno a noi che usciamo dalla Gandhi Smriti. Prima di salutarci il professor Radhakrishnan si ferma, sorride, ci batte le mani sulla spalla, ci ringrazia per la chiacchierata. E dice: «Lo dovete raccontare ai vostri amici italiani! Un’associazione indiana di scrittori ha scelto la Rivoluzione umana come libro del secolo!».
Solidarietà: la danza Interattiva del parto prematuro-Articolo di Roberto Tagliaferri
di Roberto Tagliaferri – Docente Teologia Università Cattolica Milano
Intervento alla conferenza ‘La solidarietà: le diverse radici spirituali di un valore umano’ organizzata dal Comitato Giovani Europeo della Soka Gakkai nel novembre 1998. Erano inoltre presenti membri di associazioni di volontariato sia cattoliche che laiche e rappresentati di altre scuole buddiste.
Il titolo, giustamente un po’ enfatico per catturare l’attenzione di un pubblico così eterogeneo, in estrema sintesi tenta di contenere la prospettiva di questo intervento. Si definisce la solidarietà come un tratto fondamentale dell’uomo in divenire, come un’attività ludica concernente molteplici soggetti. La felice intuizione di E. Bloch sull’uomo incompiuto come “parto prematuro” è la predisposizione a scoprire la propria sostanza dal riconoscimento degli altri. La “danza interattiva”, di cui parla invece G. Bateson1, è il gioco relazionale in cui la sympathy, la passione per gli altri, non è opposta al self-love, come appariva invece nel dibattito classico circa la natura egoistica o altruistica dell’uomo. La solidarietà è la possibilità più autentica per il sé di pervenire alla sua identità. Questo è il motivo conduttore del nostro intervento, che tenta di raccordare la prospettiva antropologica con la dimensione religiosa sulla solidarietà. I due ambienti della ricerca così strettamente simpatetici offrono ad un attento esame molte tensioni, che, una volta individuate, possono risultare feconde in questo dialogo interreligioso per non cadere in ingenue concordanze e per non mischiare indebitamente “giochi linguistici” differenti.
Procederemo innanzitutto con una sorta di fenomenologia della differenza, dove si tratterà di evidenziare alcune derive socio-etniche del solidarismo moderno; poi esibiremo il fondo teologico cristiano della solidarietà attraverso il mistero trinitario; quindi segnaleremo i travasi pericolosi della solidarietà da un gioco linguistico a un altro per identificare lo specifico ruolo delle tradizioni religiose in rapporto alla cultura e alla società.
Fenomenologia della differenza
Il soggettivismo che ha inaugurato l’età moderna è entrato profondamente in crisi da quando ci si è resi conto che l’interiorità è sempre esposta all’esterno attraverso il corpo. Solo se siamo in grado di guadagnare quel costitutivo di noi stessi che è la distanza da noi, allora abbiamo aperto lo spazio per l’altro che, a nostra insaputa, già ci abita intimamente. Il corpo è soggetto e oggetto della conoscenza «percepisco dal corpo» (soggetto) e «percepisco il corpo» (oggetto)2. Il corpo è interno all’atto conoscitivo, ma nella forma dell’esteriorità. Il mondo non è natura senza volto, ma opera dell’altro. E. Levinas scrive: «Nel volto quel che si esprime assiste all’espressione, esprime la sua stessa espressione, restando sempre padrone del senso che produce»3. Guardando il volto di un altro io mi accorgo non solo di vedere, ma anche di essere visto, mi accorgo che chi mi sta di fronte è libero di venirmi incontro o di sottrarsi a questo incontro.
La religione cristiana, che come vedremo è costituita dal mistero trinitario, ha faticato assai a guadagnare la sponda del gioco di identità e differenza, preferendo la logica mimetica della corrispondenza tra l’archetipo e la copia. Una testimonianza plastica di questa difficoltà è venuta da Padre A. Wagua (prete kuhna, tribù indios del centro America) in occasione del quinto centenario della scoperta dell’America. «Ho dovuto negare i miei padri. Per diventare prete cattolico ho dovuto lasciare la mia comunità, le sue regole, la solidarietà e accettare valori che mai avrei considerato come tali. Ho dovuto sopportare difficoltà e pregiudizi. Una volta fatto prete mi rimandarono al mio popolo. Non ero più né un prete, né un kuhna . Ho dovuto sottopormi ad un secondo processo di morte. La prima morte, ne ho dedotto , era evitabile. Dove è scritto che per essere cristiani occorre perdere la propria individualità?». Pensiamo quante volte distruggiamo l’altro senza lasciarlo esistere. In nome della verità, quanti mezzi illeciti divengono poi leciti! Pensiamo alla condanna a morte degli eretici. Noi rischiamo di occultare le differenze senza considerare che l’identità è legato al riconoscimento dell’altro.
Padre Wagua continua: «La Chiesa ha sempre seguito i potenti. Un uomo o un popolo sono più o meno fortunati, ma più o meno rispetto a chi? Agli occidentali, ovviamente! Che disprezzano la cultura indios per renderci uguali ed omologati a loro. Loro che negano i nostri idoli per crearne di propri. Cinque secoli di eliminazione di noi, ci hanno resi sospettosi verso di loro, che parlano di inculturazione, (a rigore della quale il mistero di Cristo ha bisogno di tante culture, non di una sola). Prima di essere assistiti ed amati come poveri, vogliamo essere accettati come altri, quali siamo. La carità è accettazione dell’altro perché è tale. Fino a quando la Chiesa non sarà disposta a dialogare con noi come siamo e a fare l’opzione per l’altro, non riuscirà mai ad appartenerci». L’opzione per l’altro significa che la mia verità è nascosta nella differenza, che la mia realizzazione è legata all’accettazione del rischio della sporgenza sull’altro, che la solidarietà non è primieramente un dovere verso il prossimo ma verso se stessi.
Tale acquisizione culturale, che trova nella riflessione contemporanea molti interpreti da M. Heidegger4, a J. Derrida5, da E. Husserl6 a M. Merleau-Ponty7, da E. Levinas8 a P. Ricouer9, da K. O.-Appel10 a J. Habermas11, da L. Wittgenstein12 a G. Bateson13, ha avuto un’evoluzione molto travagliata e ambigua nella prassi sociale.
La morale dell’individuo borghese tratta la solidarietà in termini di altruismo (A. Comte) ed è alle prese con dilemma tra egocentrismo dell’individuo e l’ordine sociale. Il problema è la compatibilità tra i due e viene risolto nel nostro secolo con «paradosso dell’altruismo» per cui l’altruismo sarebbe una funzione dell’egoismo: i sentimenti altruistici sorgono quando l’egoismo viene eccitato simpateticamente dalla limitazioni sofferte dall’egoismo altrui. Tre le varianti: biologica con l’altruismo genetico, psicologica con le astuzie per ottenere gratificazione, autostima e per minimizzare i sensi di colpa, calcolatoria dove l’altruismo è pseudo-altruismo in quanto ottimizza i vantaggi dalla concessioni altrui14.
La società basata sull’individuo non è tuttavia incompatibile con una morale solidaristica come appare in certa sociologia “normativista” alla Habermas15; può spingere fino a porre l’altruismo come norma sovraindividuale originaria (E. Durkheim). La problematica si complica quando la modernità sperimenta la crisi della morale. Il post-moderno è alle prese con la fine della morale universalistica proprio perché il supremo valore dell’individuo non permette valori assoluti. Con la fine della responsabilità rimane una reattiva ludica, una fisiologia dell’immediatezza. La solidarietà, priva di fondamento, diventa ingiustificabile come qualsiasi altro agire (M. Weber). Adorno scriveva: «C’è qualcosa di assurdo e di incredibile nella violazione del principio di scambio, spesso anche i bambini squadrano diffidenti il donatore, come se il regalo non fosse che un trucco per vendere loro spazzole e sapone.
In compenso si esercita la charity, la beneficienza amministrata, che tampona programmaticamente le ferite visibili della società. Nel suo esercizio organizzato l’impulso umano non ha più il minimo posto: anzi la donazione è necessariamente congiunta all’umiliazione, attraverso la distribuzione, il calcolo esatto dei bisogni, in cui il beneficiato viene trattato con un oggetto»16. La solidarietà si muove tra gli incerti confini dell’aiuto e dell’invadenza. Per ritrovare la connotazione di dono asimmetrico senza umiliazione deve diventare folle, utopica, unilaterale, senza contro-dono17. Ma questa sfida simbolica rischia di diventare sfida tragica perché non cerca più alcun senso nell’ordine dell’agire comunicativo della società, e diventa profezia, dove non solo il ricevente ma anche l’offerente non sa quello che fa. La solidarietà nell’ordine simbolico del dono è follia dell’amore fuori da qualsiasi giustizia distributiva, è come una fumata di tabacco, è come «cercare mezzodì alle quattordici» (Ch. Baudelaire). Ecco perché Nietzsche nello Zarathustra la riserva all’Übermensch. La post-modernità con la crisi della morale per l’affermarsi delle morali sembra decretare la fine della solidarietà perché ne scopre le ambiguità. Il rischio è che l’aiuto all’altro diventi affermazione di sé, che il beneficiato senta minacciata la propria autostima, interpreti la propria condizione di bisogno come colpa, provi risentimento verso chi l’aiuta, o colga nel gesto d’aiuto un’espropriazione del proprio diritto a soffrire («costui non sa nulla di tutta quell’intima sequenza e intreccio che per me o per te si chiama infelicità»18).
Nella crisi della solidarietà asimmetrica che confligge con la simmetria persona-persona, si apre tuttavia nel post-moderno un altro territorio della solidarietà dove domina il gioco di identità e differenza e la logica folle del dono. Il paradosso che ne viene è singolare: non possiamo fare a meno degli altri per la nostra identità, non possiamo strumentalizzarli e nello stesso tempo quando ci poniamo ad un livello di gratuità sembra impossibile la comunicazione.
Derrida segnala con eccezionale lucidità questi “paradossi strutturali”: «per non aver presa sull’altro, la sorpresa del dono puro dovrebbe avere la generosità di non donare niente che sorprenda e che appaia come dono, niente che si presenti come presente, niente che sia; essa dovrebbe essere dunque abbastanza sorprendente e fatta, dall’inizio alla fine, di una sorpresa su cui non esiste nemmeno il problema di ritornare, di una sorpresa dunque abbastanza sorprendente per farsi dimenticare senza indugio. E poiché questo oblio si spinge al di là di ogni presente, ne va qui del dono come del resto senza memoria, senza permanenza e senza consistenza, senza sostanza né sussistenza; ne va qui di quel resto che è, senza esserlo (sans l’etre), al di là dell’essere, epekeina tes ousias. Il segreto di ciò di cui non si può parlare, ma che non si può più tacere»19. Questo spazio utopico del dono, questa impossibilità d’essere che si arrischia sul non-essere, questo oblio che si sporge sull’immemorabile, questo tempo senza presente allude ad un diverso gioco linguistico rispetto all’etica che le tradizioni religiose hanno configurato come esperienza della trascendenza, della chora, della kenosi, del nirvana.
La solidarietà nel mistero cristiano della trinità
Il Cristianesimo si fonda sull’esperienza di un Dio trinitario, che approfondisce il tema della solidarietà nei termini di identità e differenza. Dio Padre in Gesù Cristo si è reso solidale con l’uomo fino alla morte di croce (Fil. 2, 6-11). L’abbassamento (kenosi) del Figlio non si riferisce tanto al patire ingiusto di Gesù quanto all’assunzione della condizione umana. La croce è l’interpretazione corretta dell’incarnazione di Dio, della sua condiscendenza. In Gesù l’uomo è parte integrante del mistero trinitario, dove Dio si autolimita nella differenza dell’altro, dove il gioco dell’identità divina consiste nel volgersi all’altro. B. Forte scrive in merito: «Il Dio trinitario “fa spazio” in se stesso alla Sua creatura: l’assoluta gratuità dell’amore, che motiva il Padre a porre l’atto creatore, lo spinge ad auto-limitarsi perché la creatura esista nella libertà. Questa autolimitazione non è che il rispetto che il Creatore ha per l’alterità della creatura, per il suo esistere nella libertà davanti all’offerta della vita, e si congiunge al rischio del possibile rifiuto che l’essere finito può opporre all’infinito Amore.
L’auto-limitazione del Padre è al tempo stesso evento dell’umiltà del Figlio: il prezzo dell’amore divino sarà la consegna dolorosa della croce… Lo spirito è la condizione trascendente di possibilità infinita, che non annulla la possibilità della distanza dolorosa del Venerdì Santo. Analogamente lo Spirito è nei rapporti col creato la garanzia che il mondo esiste come altro da Dio, senza essere per questo separato da Dio: mistero di un amore umile, che accompagna l’altro nella fedeltà, ma lo rispetta in tutta la dignità e l’autonomia della sua alterità»20.
L’autolimitazione di Dio nella kenosi del Figlio disegna nella storia quella possibilità del dono, per noi così difficilmente pensabile e descrivibile. Il dono è infatti «un altro nome dell’impossibile»21, non cade nel nostro orizzonte frutto delle nostre possibilità e intenzioni, accade imprevisto e lo incontriamo senza conoscerlo appieno; lo nominiamo, lo desideriamo ma si sottrae alla nostra presa. È un unilaterale, grazioso, fortuito, incondizionato venire incontro che non umilia perché la sua qualità è di esibirsi come spazio per la libertà dell’uomo. Senza il dono di Dio, che è autolimitarsi per far spazio all’altro, non ci sarebbe la libertà dell’uomo. Senza il dono di Dio, che è autolimitarsi per far spazio all’altro, non ci sarebbe la libertà dell’uomo. La libertà è in assoluto come un assoluto il dono di Dio. Chi ha ricevuto in dono la libertà non dovrebbe soffrire di nessun complesso d inferiorità perché nella kenosi di Gesù si tiene insieme una proporzione fra due atti assoluti e la sproporzione dell’incommensurabiltà del dono.
La solidarietà tra Dio e uomo assume una connotazione talmente anomala, che sembra impossibile una trascrizione etica. Sembra proprio che il gioco linguistico dell’esperienza religiosa del dono di Dio per la libertà dell’uomo sia intraducibile nel gioco linguistico etico, dove sembra inevitabile la logica sacrificale del do ut des. Derrida scrive: «Un mendicante appare sempre come minaccioso, recriminante, accusatore, vendicativo, nell’assoluto della sua stessa domanda. Questa viene e ritorna dall’altro. Bisogna pagare, in altre parole “donare” per sdebitarsi nei confronti dello spirito, del fantasma o del dio, di tutto ciò che ritorna. Bisogna in ogni caso conquistarsi le sue grazie e fare la pace con lui. Di qui l’istituzione dell’elemosina»22. Derrida sostiene che il dovere dell’elemosina nelle religioni non sfugge al calcolo ed è quindi lontana dal dono. Anche l’offerta generosa per sorprendere l’altro è una trappola.
Il destinatario è imprigionato, avvelenato, senza difesa, violentato. Un’elargizione proporzionata rimane un rimborso a credito non un dono. Il nesso tra morale delle buone intenzioni e dono è impraticabile. «Il dono, se ce n’è, non appartiene alla ragion pratica. Esso dovrebbe restare estraneo, alla morale, alla volontà (…), alla legge e al “bisogna” di questa ragion pratica. Dovrebbe oltrepassare il dovere stesso: dovere al di là del dovere. Se si dona perché bisogna donare, non si dona più. Ciò non significa necessariamente che ogni legge, e ogni “bisogna” siano così esclusi dal dono ( se ce n’è), ma bisogna pensare allora una legge o un “bisogna” non determinabili da qualche ragion pratica (…). Si può donare solo nella misura dell’incalcolabile e dunque solo un’ipotesi di moneta falsa renderebbe possibile il dono» 23.
È su questo paradosso della solidarietà come moneta falsa che le tradizioni religiose potrebbero dare un contributo all’umanità, senza rinunciare al loro specifico.
Solidarietà e dialogo interreligioso
La mia perplessità ad accettare questo colloquio interreligioso non viene da alcun pregiudizio sulla bontà delle religioni non cristiane, ma dalla constatazione che il dialogo fra le religioni non avviene sul terreno del Sacro che compete specificatamente ad esse, ma prevalentemente sul terreno etico, che appartiene all’umanità intera. È come se si avesse bisogno di un territorio neutrale per incontrarsi indipendentemente da ciò che è specifico. Potrebbe anche essere una strategia intermedia di avvicinamento, se non si corresse il pericolo di trasformare il religioso in etica. È certo che l’esperienza religiosa ha una ricaduta etica, ma non si può rendere omologici i due giochi linguistici.
Diventa addirittura pericoloso perseguire la strategia della reversibilità dall’etico al religioso come la verità della fede fosse garantita dall’efficacia storica dei progetti di umanizzazione. Si rischia di limitare l’assoluta alterità di Dio, che non si lascia catturare dai nostri orizzonti di senso. In tutte le tradizioni religiose Dio si rivela come l’altro rispetto a noi e nel momento in cui si mostra subito si sottrae alla nostra presa. Nella stagione attuale sembrano crollare i muri di separazione che rendevano le religioni pregiudizialmente ostili tra di loro. È recente l’intervento di Giovanni Paolo II sulla condanna dell’antisemitismo perpetrato nei secoli dai cristiani. Sta tuttavia prendendo piede un atteggiamento di dialogo, che sembra mettere tra parentesi l’intenzionalità misterica delle religioni per trovare una piattaforma comune nell’impegno etico a favore dell’umanità. Sta bene che gli uomini di fede si interessino dei problemi del mondo, ma con due avvertenze.
La prima è di non presentarsi con soluzioni assolute come se fossero ricevute dall’alto con quella presunzione integrista che riesce ancora una volta a separare gli uomini tra di loro. La seconda è di esercitare una coscienza critica nei confronti di qualsivoglia soluzione mondana per preservare quella eccedenza del dono di Grazia. Rispettando questa tensione tra umiltà per la mancanza di soluzioni in proprio definitive e consapevolezza che Dio non abbandona gli uomini, che è nella solidarietà a cui siamo chiamati? Il versante della solidarietà sul paradigma del dono sembra non appartenere a questo mondo, o meglio esiste, si realizza ma quasi nessuno se ne accorge proprio per la qualità “folle” e impercettibile del dono. Nel giudizio universale del Vangelo di Matteo quando il Re accoglierà i beati per le loro opere buone, essi diranno stupiti: «Quando abbiamo fatto questo?». Nel dono non basta che l’elargitore non ne abbia coscienza, né memoria, è necessario che lo dimentichi immediatamente con un oblìo così radicale da oltrepassare la categoria psicanalitica dell’oblìo24.
L’uomo religioso sa che vi è questa dimensione del dono, ma non sa e non può identificarlo precisamente in una prassi o in un progetto specifici. Lotta perché si affermi la coscienza del dono in mezzo agli uomini, ma non lo adultera con nessun agire strategico. Accetta progetti mirati, lotta per le giuste cause, ma non è mai del tutto sicuro di aver trovato il bandolo della matassa, è incerto sull’identificazione del nemico e della vittima e anche quando sembra non esserci ragionevole dubbio sa che la colpa o il diritto non sono mai da una sola parte. È soprattutto attento ai propri meccanismi di autodifesa, di autolegittimazione, sospetta dei “giochi di faccia” per salvare solo se stesso, cerca di imparare la compassione, verificando la propria debolezza. Come il Figlio dell’uomo, che imparò l’obbedienza dalla cose che patì (Eb), si porge al prossimo come il guaritore ferito, che è in grado di alleviare le altrui debolezze essendo egli stesso passato attraverso la vulnerabilità umana. Questo è il senso cristiano della condiscendenza, dell’incarnazione di Dio, della Kenosi, che non ha nessuno da salvare, solo da scendere fin nel profondo dello Sheol per condividere. Ecco forse la solidarietà: non avere nessuno da salvare ma solo da capire.
DuemilaUno nr. 69 di luglio-agosto 1998
Note
1) G. Bateson, Mente e Natura. Un’unità necessaria, Milano Adelphi, 1984, p. 179.
2) Cf. M. Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione, Milano, Il Saggiatore, 1980.
3) E. Levinas, Le tracce dell’altro (scorciatoie), Napoli, Libreria Tullio Pironti, 1985, p. 16.
4) M. Heidegger, Essere e tempo. L’essenza del fondamento, Torino, UTET, 1969.
5) J. Derrida, La scrittura e la differenza, Einaudi, Torino.
6) E. Husserl, Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica, II, Torino, Einaudi, 1976, pp. 501-502.
7) M. Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione/em>, Milano, Il Saggiatore, 1980.
8) E. Levinas, Totalità e infinito. Saggio sull’esteriorità, Milano, Jaca Book, 1980.
9) P. Ricoeur. Sé come un altro/em>, Milano, Jaca Book, 1993.
10) K. – O. Appel, Comunità e comunicazione, Torino, Rosemberg & Sellier, 1977;
11) J. Habermas, Teoria dell’agire comunicativo, 2 vol. Bologna, Il Mulino, 1986.
12) L. Wittengstein, Ricerche filosofiche, Torino, Einaudi, 1974.
13) G. Bateson, Mente e Natura. Un’unità necessaria, Milano, Adelphi, 1984.
14) S. Manghi, Il buon seme. La responsabilità dell’altruismo nel tempo della morale perduta, “Iride”, 1977.
15) J. Habermas, Solidarietà tra estranei. Interventi su “fatti e norme”, Milano, Guerini e Associati, 1977.
16) T. W. Adorno, Minima moralia, Torino Einaudi, 1974 p. 32.
17) J. Derrida, Donare il tempo. La moneta falsa., Milano, Raffaello Cortina Editore. 1996.
18) F. Nietzsche, La gaia scienza, Milano, Adelphi, p. 232.
19) J. Derrida, Donare il tempo, pp. 147-148.
20) B. Forte, Trinità per atei, Milano, Raffaello Cortina Editore, 1996, pp. 68-69.
21) J. Derrida, Donare il tempo, p. 31.
22) Ivi, P. 138
23) Ivi, pp. 156-158.
24) Ivi, P. 18.
La sfida e il prezzo della solidarietà-di Jerry O’ Connell
Qualche sera fa ero a Genova a parlare a un gruppo di cinquecento persone sull’Algeria. È un paese non molto distante da noi, con 28 milioni di abitanti. Negli ultimi sei anni 80.000 persone sono state uccise Significa un morto ogni 350 persone. Negli ultimi sei anni 36 persone al giorno uccise: una ogni 45 minuti. Questi conflitti producono un numero enorme di rifugiati. L’80% di loro è composto di donne e bambini. Molte delle donne rischiano lo stupro, molti bambini rischiano un trauma che gli distruggerà non solo il presente ma anche il futuro. La grande maggioranza dei rifugiati sono ospitati dai paesi poveri.
Diversi anni fa sono stato in Sud Africa durante la guerra in Mozambico e sono andato nelle Homelands abitate da persone di colore molto, molto povere, vicino alla frontiera con il Mozambico. Il Sud Africa ha costruito un recinto elettrico, alto tre o quattro metri per evitare che le persone fuggissero dalla guerra rifugiandosi in Sud Africa. Ma la gente passava, scavando sotto il muro: 250.000 persone sono scappate in Sud Africa. Chi ha dato loro ospitalità? Proprio questa povera gente delle Homelands. E quando venivano i soldati sudafricani per catturare i rifugiati e rimandarli in Mozambico, la gente si divideva le famiglie, una prendeva un bambino, una prendeva l’altro, per proteggerli. Ho visto più generosità tra questi popoli che nel ricco Giappone, nella ricca Australia, nei ricchi Stati Uniti e nella ricca Europa occidentale che chiudono le frontiere a chi chiede asilo.
Sentiamo gridi dalle carceri, di persone nel braccio della morte. Più della metà dei paesi nel mondo, oggi, ha abolito la pena di morte. So che nel Buddismo c’è un grande rispetto per la vita. L’anno scorso ero con il Dalai Lama a Palermo e lui ha espresso il suo appoggio totale contro la pena di morte. Sappiamo che l’anno scorso la Cina ha giustiziato 4379 persone. Cosa significa? Una persona ogni due ore. Martedì prossimo, negli Stati Uniti un uomo di 61 anni, Robert Williams, ha il suo appuntamento con la morte. Il 22 marzo del 1995 a poche ore dall’ora stabilita per la sua morte decisero di sospendere l’esecuzione. Martedì, se manca la misericordia umana, sarà giustiziato. Quando interveniamo per l’abolizione della pena di morte lo facciamo perché sappiamo che nessuno stato ha il diritto di togliere la vita. Questa è un’altra forma di solidarietà.
Parliamo inoltre di guerre e di conflitti: forse non sapete la quantità di civili inermi che oggi finiscono sotto terra. Nella prima guerra mondiale il 5% dei morti erano civili, nella seconda guerra mondiale i morti tra i civili erano il 50%, oggi giorno i civili morti nei conflitti sono superano l’80%. Ho parlato prima dell’Algeria. Vorrei raccontarvi due storie avvenute in quel paese. Una è successa nel ’95 e una nel ’96.
Nel febbraio ’95 quattro bambini tra sei e tredici anni stavano dormendo. Sono arrivati degli uomini di notte per uccidere loro padre che era poliziotto. I gruppi armati di opposizione sedicenti islamici perseguitano chiunque sia delle forze armate. Hanno ucciso il padre, hanno preso la madre, l’hanno legata e uccisa, poi hanno ucciso il vicino di casa. I bambini sono rimasti soli.
Una madre raccontava come nel maggio del ’96 le forze militari di sicurezza erano venute per uccidere i quattro figli che erano in casa, perché un loro parente era nel gruppo di opposizione. Prima hanno sparato alla testa ai quattro zii, poi hanno ucciso anche il marito di 84 anni e poi per dare una buona lezione hanno anche ucciso il cane. Hanno lasciato la madre ad affrontare il mondo, senza il marito e i suoi 4 figli. Questa è la guerra, questi sono i conflitti. Di fronte a tali fatti non possiamo non dare una risposta di solidarietà.
Noi tutti sappiamo che sono scomparsi in Bosnia e in Croazia 22.000 persone, in Algeria 2.000, ma anche in altri paesi la gente scompare nel nulla alla fine del XX secolo. In molti pochi casi si apre un’indagine per sapere cosa è successo. Qualche anno fa sono andato in una Ambasciata a Roma, per parlare con l’Ambasciatore e sapere cosa era successo a una certa personalità in un paese. L’ambasciatore mi guardo con un po’ di stupore, aveva due assistenti con lui, e mi disse: «Ma è successo tre governi fa, venti anni fa, e lei oggi mi viene a chiedere cosa gli è successo? È chiaro, è morto». Gli ho chiesto: «Mi sta dicendo questo da parte del suo governo?» Parlando ho saputo che lui aveva conosciuto quell’uomo. Mi chiese: «Perché chiedi di lui se anche altri sono stati uccisi nello stesso periodo?» Solo allora abbiamo saputo cosa era successo: per venti anni la famiglia non aveva saputo niente. La gente ha il diritto di andare a mettere un fiore sulla tomba dei loro cari. In molti paesi del mondo anche questo diritto è negato. Dobbiamo ascoltare gli appelli delle persone che sono impotenti.
Il grande Gandhi disse una volta che aveva tre battaglie nella sua vita: la prima era contro se stesso, contro la sua pigrizia, contro i suoi propri pregiudizi, contro il suo proprio egoismo; la seconda battaglia era contro il suo popolo perché anche loro avevano dei pregiudizi, la pigrizia, anche il non vedere, il non ascoltare, il non rispondere; e la terza battaglia era contro il potere oppressore che era a quel tempo il potere dell’impero britannico. Per me queste tre battaglie sono di ciascuno di noi. Siete buddisti e sapete che nel nostro mondo il nazionalismo, il razzismo, il settarismo sono ostacolo all’umanità e ostacolo alla solidarietà.
Quando ero con il Dalai Lama ho chiesto pubblicamente al governo cinese a nome di Amnesty di rivelare dove fosse il piccolo Panchen Lama Gendun Choekyi Nyima che nel maggio del ’95 è stato rapito dal governo cinese. Il bambino è a Pechino ma nessuno lo vede. È una grande vergogna per la Cina che ha firmato la Convenzione per i diritti dei bambini: una grande potenza che rapisce un bambino.
Penso che la solidarietà vada oltre la religione perché non si può essere solidali solo con i propri correligiosi. Va oltre la nazionalità, va oltre la famiglia, va oltre la razza. Questa è la solidarietà, questo è che ci fa essere uomini e donne, che ci fa essere in grado di andare al di là delle differenze per capire che tutti gli esseri umani sono uguali in dignità e diritti, che dobbiamo trattarci gli uni e gli altri con uno spirito di fratellanza. Questa è la solidarietà a cui siamo chiamati: non chiudere gli occhi al mondo, ai bisogni di persone vicine e distanti e non chiudere il cuore al loro appello nel momento del bisogno.
La forza del Buddismo: vivere meglio insieme nel mondo di oggi-di Mariangela Falà
o gran Dalai Lama, alla sommità del dentro. È dal di
dentro che ti assomiglio, io, polvere, idea
levitazione, sogno, grido, rinuncia all’idea, sospeso in
tutte le forme e non sperando altro che il vento.
Fateci una Mente senza abitudini, una mente fissata
veramente nella Mente o una Mente con delle abitudini
più pure, le tue, se sono buone per la libertà».
(Revolution surréaliste, n.3 aprile 1925)Questo testo giovanile opera del gruppo surrealista di Breton, Aragon, Artaud ed Eluard mostra chiaramente ancor oggi ciò che può far avvicinare gli occidentali all’insegnamento del Buddha: non un cambiamento di credenze né l’abbandono di un rituale per un altro, ma una reale metamorfosi dello spirito, quello che fu allora il grido profondo del movimento surrealista: «È dentro che ti assomiglio». La ricerca di abitudini più pure e di una qualità più alta della mente sono ancora le spinte più evidenti che avvicinano gli occidentali alla via del Buddha, una religione “umana”, nata dalla riflessione umana per rispondere ai bisogni umani. Ma ve ne sono anche altre.
Oggi, dopo tre quarti di secolo di progressivo “stanziarsi” dell’insegnamento del Buddha in occidente e del suo diventare lievito per una “nuova coscienza”, le motivazioni al rapporto con il Dharma buddhista sono diventate ancora più sfaccettate e apiù ampio spettro sia sociale che culturale. Tra quelle che più sovente si ritrovano tra i praticanti delle diverse tradizioni ricordiamo lo spirito di ricerca non dogmatico, ma critico proprio del Buddha1, la metodologia sperimentale che lo anima e che si basa sul vieni a vedere, a sperimentare in prima persona, le prospettive e gli insegnamenti in armonia con le scienze contemporanee come la psicologia, le scienze cognitive, l’epistemologia, la centralità dell’esistenza umana che pervade tutto, la capacità del Dharma di fornire spiegazioni ed esercizi per la trasformazione del proprio io e la realizzazione della propria natura basati su un’etica universale fondata su una disciplina di tipo “medico” piuttosto che “giuridico” ovvero senza un Dio giudicante su ciò che sia bene o male, ma in cui la responsabilità individuale è completa. Questo ed altro ancora sono le spinte che sempre più prepotentemente affiorano in chi è alla ricerca e si trova a confrontarsi con il millenario insegnamento del Buddha.
Il carattere di scienza sacra, non dogmatica e non dottrinale, di questo insegnamento si concilia male con l’appellativo in-ismo che in occidente gli è stato dato all’inizio del secolo scorso (1825).
Il Buddhadharma, l’insegnamento del Buddha, il Buddhasasana, la via del Buddha, è una grande tradizione religiosa nel senso etimologico proprio alla parola religione come ciò che orizzontalmente unisce gli uomini tra loro e con i loro antenati e che verticalmente li riunisce al proprio principio atemporale, alla loro natura trascendente e immanente. Il Dharma non è un enunciato proposto come unica verità assoluta, ma l’espressione di un modo di essere, di ciò che siamo e di ciò che viviamo, una scienza dell’esperienza o dello spirito. E in quanto scienza dello spirito o della vita, propone la liberazione dalle illusioni e la realizzazione della nostra vera natura per cui la sua vita ha una portata umana universale e transculturale scevra da idee di conquista o di conversione come si può arguire dalle parole di Tenzin Gyatso, il XIV Dalai Lama, premio Nobel per la Pace nel 1989: «Io non desidero convertire gli altri al Buddhismo, ma farli partecipi del modo in cui, come buddhisti, possiamo portare il nostro contributo all’umanità in base alla nostra concezione del mondo».
È difficile in occidente che uno sia buddhista per abitudine o per nascita. Di frequente proviene dalla tradizione cristiana, vissuta talvolta in modo superficiale e convenzionale e aderendo al Buddhadharma non vuole ripetere tale atteggiamento. Di conseguenza, rivolgendosi a questo messaggio nuovo, le persone vi si dedicano con maggiore slancio, con una motivazione maggiore e sincera.
Nella sua essenza e nei suoi fondamenti il Dharma non dipende dalla situazione socio culturale in cui si diffonde, ma in ogni caso ha sempre profondamente trasformato le civiltà in cui si è stabilito rispettando comunque le culture preesistenti. Per esempio l’impero pacifico dell’imperatore Maurya Asoka (273-232 a C.), che seguiva la via del Buddha, è restato celebre come apogeo della cultura indiana antica.
Il Dharma quindi penetra nelle culture dall’interno e le trasforma profondamente acquisendo un aspetto esteriore in armonia con esse in modo da essere facilmente comprensibile a tutti. Questo modo di inculturazione specifica gli ha assicurato una diffusione enorme senza conquiste o guerre di religione, quasi per infusione o lenta osmosi con le diverse culture e società.
L’impegno nel Buddhadharma è un impegno di trasformazione di se stessi e quindi del nostro modo di vivere nel mondo, un lavoro di contemplazione delle cause del nostro malessere esistenziale, della disarmonia che viviamo, una contemplazione abituale e sistematica dei nostri meccanismi di attrazione e repulsione, del nostro attaccamento all’illusione dell’ego, che anima tutte le passioni e crea la disarmonia.
Il Dharma è la religione dell’upayakausalya, dell’abilità nei mezzi salvifici ed esso stesso, in ultima analisi, è un upaya, un mezzo, una zattera per attraversare il fiume della vita, che aspetta soltanto di essere usata per quello che occorre e non per portarsela sulla testa come un fardello una volta attraversato il fiume (M I, 134-135). «Discepoli, persino in merito a questa visione, così pura così chiara, se vi ci aggrappate, se la vezzeggiate, se la tesaurizzate, se vi ci attaccate, non comprendete che l’insegnamento è simile a una zattera utile per attraversare il fiume e non come oggetto posseduto» (S IV, 232).
Oggi ci troviamo qui specificamente per parlare di semi per crescere in un mondo di pace, semi che trovano il loro humus nel suolo della nostra esperienza interiore, nel senso di una solidarietà vissuta come momento religioso nel senso più ampio. La nostra esperienza ci mostra che attaccamento, avversione e ignoranza, le tre radici (mula) negative del nostro comportamento, che affettano il samsara, il mondo ripetitivo in cui ci troviamo ad esistere, hanno raggiunto oggi una massa critica e possono innescare un processo distruttivo non solo vasto, ma anche irreversibile.
Come non essere – dunque – ancora più interessati che in passato alla purificazione, alla meditazione, al lavoro su di sé per poter proporre quella trasformazione non superficiale ma profondamente radicata, che sola può portare frutti efficaci e duraturi? Oggi è diventato più difficile nascondersi la verità dell’ignoranza e dell’attaccamento come cause della disarmonia, del malessere e della conseguente sofferenza. Oggi è diventato più difficile illudersi. D’altra parte, anche per ciò che concerne i mezzi per superare la sofferenza, mi pare che si possa prendere atto di un’utile novità, la scienza del Buddha, abbastanza nuova per noi occidentali anche se antica nelle sue radici, a cui possiamo attingere pur tra le tante difficoltà di adattamento e le inevitabili asperità che il suo trasloco dall’oriente fino a noi ha comportato e può comportare.
È una grande occasione che bisogna sfruttare integrando lo studio e la pratica. Il Buddha infatti osserva che coloro che si limitano a studiare il Dharma al fine di criticare e confutare altri senza in alcun modo accedere ad esso come esperienza di liberazione, si fanno soltanto male, come chi afferra un serpente per la coda invece che per la testa o non ne conseguono i frutti come dei mandriano che contano le bestie altrui (Dhammapada, 26).
Lo studio soltanto intellettuale delle diverse dottrine o scuole può talvolta offrire il destro al rischio di cadere in un eclettismo tanto vago quanto inutile per cui è necessario scendere sul terreno, non rimanere sulla spiaggia dove tutto sembra fragile ma gettarsi in acqua e nuotare. Se rettamente intesa e usata questa occasione di incontro con la o le spiritualità buddhiste è terreno fertile per la nostra crescita in un senso di unità nella diversità delle esperienze.
Sarebbe infatti disastroso, oltre che sorprendentemente irragionevole, importare dall’Asia, insieme con il Buddhismo anche i suoi secolari conflitti. Se il dogmatismo, il settarismo e l’ideologismo sono di per sé in generale grandi problemi, essi diventano in particolare un’eccezionale contraddizione in casa buddhista. Infatti rappresentano l’esatto contrario di ciò che il Buddha raccomanda e corrispondono in pieno a ciò che il Buddha designa come la presa errata del serpente o come la zattera trasformata in oggetto di attaccamento. Ci sembra che il Dharma in occidente si trovi davanti a un’occasione irripetibile per mettere in pratica l’insegnamento della zattera: ossia priorità assoluta alla pratica del Dharma e superamento di ideologismo e settarismo nella coltivazione del rispetto e dell’apertura come valori fondamentali. Un altro punto di riflessione è il fatto che non di rado il Buddhadharma viene presentato come una pratica intimista e in ultima analisi individualistica. Nella tradizione buddhista in realtà non c’è una dicotomia tra il lavoro su di se e il lavoro con gli altri. Il carattere della pratica è altamente unificante e unitario. Il cammino è fatto di tre dimensioni organicamente intrecciate: saggezza, contemplazione ed etica, così come viene mostrato nell’Atthangika Magga, il Nobile Ottuplice Sentiero, che costituisce la Quarta Nobile Verità, la terapia del malessere e della sofferenza in cui versiamo.
L’etica o disciplina è fondata sull’amore e sulla compassione, è la coltivazione dell’attitudine non violenta, che previene dall’intelligenza immediata del cuore: la contemplazione o attenzione consapevole è la qualità di lucidità aperta o di presenza coltivata attraverso la pratica di meditazione e la saggezza, l’intelligenza è la comprensione della natura di sé e delle cose. A livello più profondo è la comprensione che trascende le abituali illusioni concettuali. Ma attenzione, nessuna di queste tre dimensioni può essere veramente quella che è senza le altre due. Le conseguenze di tale visione sono di grande rilevanza. Significa che per arrivare alla saggezza occorre basarsi sull’etica, che a sua volta è fondata sulla contemplazione. Questo significa che la sensibilità morale, fondamentale per una nuova sensibilità sociale, è radicata nella pratica. Perciò dire che l’impegno del Dharma è impegno primariamente contemplativo significa dire nello stesso tempo che l’impegno del Dharma è un impegno primariamente etico. Meditazione ed etica sono una cosa sola e quindi in questa ottica cade la divaricazione dualistica tra altruismo e intimismo. Un importante maestro buddhista del nostro tempo, Chogyam Trungpa, ha detto: «Gli esseri umani distruggono l’ecologia e nello stesso tempo si distruggono l’uno l’altro… guarire la nostra società va di pari passo con la guarigione della nostra connessione personale elementare con il mondo fenomenico». La cura in questa scala è una profonda rieducazione, che ha come scopo l’aspirazione a un senso profondo di interconnessione e interdipendenza di tutti i fenomeni della vita, del valore della vita.
Il concetto di una esistenza indipendente degli esseri e delle cose è stata da sempre rifiutata dalla unanimità delle scuole buddiste. Nulla esiste in modo separato, in sé e per sé, ma tutto è collegato a tutto, come i fili della Rete di Indra. L’interdipendenza di tutte le cose è definita in sanscrito pratityasamutpada ed è una delle dottrine peculiari del Buddha, insegnata nell’Avatamsaka Sutra e in molti altri luoghi del Canone. Un maestro contemporaneo zen Thich Nhat Hanh, in una raccolta recente dei suoi testi, per parlare di questa dottrina prende come esempio una pagina di un libro. Senza neanche considerare la stampa o l’inchiostro utilizzati per scriverci sopra, il foglio di carta è composto di elementi non-carta.
Se ritorniamo alla fonte della carta, le fibre di cellulosa, ritorniamo al legno, al bosco in cui quell’albero, che è servito per produrre il foglio, è nato, al taglialegna che lo ha tagliato, al padre e alla madre del taglialegna e così di seguito. Alla fine constatiamo che in realtà quel foglio di carta è vuoto. Non ha un sé esistente in modo separato da tutte quelle cause e condizioni che lo hanno prodotto, da tutti quegli elementi non-carta. Il foglio di carta è vuoto di un sé indipendente, autonomo. «Vuoto – dice Thich Nhat Hanh – nel senso che il foglio è pieno di tutto, di tutto il cosmo». Ciò che vale per un foglio vale certo per l’individuo. Siamo fatti di elementi non-individuo, dentro il mondo e parte di esso, un dente della ruota della vita. In tale visione essere con gli altri diventa una realtà già in noi stessi. La solidarietà è già dentro di noi. Nella pratica di meditazione non ci si può sentire separati dal resto del mondo. La meditazione porta inevitabilmente a un cammino di pace dello spirito, che è indispensabile per un’azione giusta e questa pace è al centro della nostra ricerca. Sappiamo spesso che un momento di riflessione aiuta a risolvere un problema che sembrava senza soluzione. Qualche minuto di silenzio comune apporta miglior coesione che delle ore di agitazione. Ma nella preparazione a uno spettacolo non ci si può accontentare di meditare. Bisogna passare alla rappresentazione, all’espressione della vitalità.
Una delle cose che la meditazione ci apprende, quando lentamente discendiamo all’interno di noi stessi, è che il senso di pace è già dentro di noi e con questo senso di pace possiamo rivolgerci all’esterno, con l’attitudine di amore e compassione propria dell’insegnamento buddista e, se vogliamo, di tutte le forme sacre del religioso. Non credo infatti che ci sia una tradizione religiosa che non rassicura su questo tema: l’amore, la compassione, il rispetto per gli altri sono elementi fondamentali per ogni religione e per ogni convivenza civile. Esser solidali è il corollario di questa affermazione anche nel mondo consumistico in cui viviamo e che spesso perde di vista i valori autenticamente religiosi. Anche dal punto di vista laico la solidarietà è importante: bada individuo non vivi solo, se fai tutto solo per te non andrai lontano, credi di fare i tuoi interessi, in realtà li danneggi. Non si tratta di buonismo, si tratta, se vogliamo, di una visione pratica e utilitaristica del problema. Ma, allora, la religione, o meglio, le varie tradizioni spirituali che cosa possono dire di più? C’è una solidarietà sacra, una santità, un’azione che si manifesta con comportamenti non solo convenienti ma perfettamente gratuiti? Forse qualche lume in questo senso possono darcelo delle figure di santi, che, non dimentichiamo, esistono anche oggi, come madre Teresa di Calcutta, con i suoi lebbrosi o i monaci thailandesi che si prendono carico deo malati di AIDS scacciati da tutti o i monaci zen degli slums newyorchesi. Queste forme di solidarietà non “convengono” a tutti, sono sul campo e immettono dentro il problema drammaticamente in prima persona.
E l’impegno è forte e non da tutti. Ma esiste anche un altro livello diremo esterno, di morale laica, che fondamentalmente tutti potremo seguire e praticare; è quello di fare ciò che banalmente definiamo il “nostro dovere”, sembra semplice, ma non è poi così comune, come lavorare in modo coretto, pagare le tasse richieste che servono anche per far costruire gli ospedali e inviare aiuti, fare tutto questo non rimanendo insensibili di fronte alle grandi sperequazioni che la nostra società ha prodotto e cercando soluzioni possibili e sostenibili in cui primario sia l’uomo e non l’oggetto. Si tratta di costruire un’utopia, e l’utopia è un colore in un mondo in bianco e nero. Portare pace lavorando sulla propria trasformazione interiore è difficile ma personalmente ritengo sia l’unica via per arrivare a trasformare una società in modo duraturo, anche se occorre molto tempo e la disillusione è sempre in agguato. È una via che spesso da molti fautori di grandi e veloci sommovimenti è stata considerata irrealistica, ma forse converrebbe perseverare anche se noi non ne gusteremo direttamente i frutti. Ha detto il Dalai Lama: «Se cercate di diminuire le vostre motivazioni egoiche e di sviluppare più amore, più compasione per gli altri in realtà sarete per voi di maggior beneficio che facendo latrimenti. Talvolta dico che l’egoista saggio deve praticare in questo modo. L’egoista stolto pensa sempre a se stesso e i risultati sono negativi. Se un egoista sagio pensa agli altri, aiuta gli altri per quello che può, ottiene buoni risultati per entrambi. La mia religione è semplice, non c’è necessità per filosofie complicate né per templi ricchi e grandi chiese. La nostra mente, il nostro cuore è il nostro tempio e la filosofia è amore».
È già un passo, ma c’è anche un passo che va oltre ed è la santità, la spiritualità. Per la santità ci vuole più coraggio, bisogna andare oltre al dire di essere buoni: esserlo semplicemente. E ci vuole lavoro su di sé, profondo e intimamente vissuto per sentirsi non solo con l’altro ma per sentirsi l’altro, senza dualità né differenze. Ecco la differenza. È poco? È tutto.
Note
1) Si può ricordare il famoso discorso che il Buddha fece ai Kalama che gli chiedevano a quale maestro dare ragione o quale seguire visto che sembrava sempre che l’ultimo a parlare fosse il migliore. Il Buddha rispose che non bisogna basarsi sul sentito dire, sulle speculazioni, sulla tradizione ecc, ma che bisognava andare a sperimentare in prima persona per poter vedere se quell’insegnamento o quell’altro avevano dei frutti positivi.
Dov'è Abele, tuo fratello? Il percorso della solidarietà-di Claudio Betti e Alberto Quattrucci
di Claudio Betti e Alberto Quattrucci – Comunità di Sant’Egidio
Intervento alla conferenza ‘La solidarietà: le diverse radici spirituali di un valore umano’ organizzata dal Comitato Giovani Europeo della Soka Gakkai nel novembre 1998. Erano inoltre presenti membri di associazioni di volontariato sia cattoliche che laiche e rappresentati di altre scuole buddiste.
Alle origini del mondo, all’inizio della vicenda umana e delle pagine della Scrittura, dopo il primo omicidio della storia, quello operato da Caino nei confronti di Abele, risuona quella domanda del Signore che attraversa da allora ogni generazione: «Dov’è Abele, tuo fratello?». Ma questa domanda continua ad essere rivolta agli uomini e alle donne di ogni tempo: «Dov’è Abele, tuo fratello?», dov’è il tuo fratello che soffre?, dov’è il tuo fratello che sta male?, dov’è il tuo fratello che parla una lingua diversa dalla tua?, dov’è il tuo fratello povero?
È una domanda che interroga uomini e donne che hanno dimenticato l’altro, tutti concentrati e preoccupati solo per se stessi. È una domanda che interroga società intere, i popoli del benessere nei confronti di quelli del terzo mondo «Dov’è Abele, tuo fratello?».
La risposta più normale, e anche la più diffusa, resta quella di Caino, non il più cattivo, ma colui che cura “naturalmente” solo i propri interessi – e in chi cura esclusivamente i propri interessi c’è sempre un inizio di omicidio dell’altro – e la risposta di Caino è: «Sono forse il guardiano di mio fratello?».
Il rapporto con il “fratello” sembra attraversare tutto il libro della Genesi. Il tentativo dell’uomo di curare i propri interessi, che diviene quello di comprarsi la primogenitura, trasforma il fratello in un estraneo, anzi in un nemico da temere. È il caso di Giacobbe nei confronti di Esaù. In questa vicenda si capisce bene come la “fratellanza” non sia un dato naturale, acquisito una volta per tutte; al contrario è una realtà dinamica, che ha bisogno di essere ricompresa e riconquistata. È significativo che Giacobbe, che vede in Esaù il nemico, lo riconosce come fratello solo dopo aver incontrato il Signore, nella lotta notturna a Peneul. Solo allora l’incontro con Esaù torna a essere – o forse diviene per la prima volta – l’incontro con il “fratello”; solo dopo aver incontrato il Signore c’è la piena riconciliazione con il fratello, anzi nel fratello si incontra il Signore stesso. Così Giacobbe si rivolge ad Esaù: «… Io sono venuto alla tua presenza, come si viene alla presenza di Dio».
Ma la pienezza di questo rapporto con l’altro fratello, rapporto essenziale per la propria salvezza – per continuare nel libro della Genesi – la pienezza sta nella storia di Giuseppe. Si ripete la vicenda di Caino, «Dov’è Abele, tuo fratello?», e i fratelli vendono Giuseppe agli Ismaeliti, rispondono anche loro «Sono forse il guardiano di mio fratello?». Ma, venuta la carestia, la salvezza per loro sta nell’incontro con Giuseppe. È lui che si fa riconoscere: «Io sono Giuseppe, il vostro fratello…» e aggiunge: «Dio mi ha mandato qui prima di voi per salvare in voi la vita di molta gente». Nella storia di Giuseppe è stata letta la prefigurazione di Gesù. La nostra esperienza inizia negli anni del post-concilio e si fonda su un ascolto attento e gioioso della Parola di Dio. A partire da questo ascolto è nata, e nasce ogni giorno, la scelta di rispondere al Signore «Sono il guardiano di mio fratello!», e insieme viene la scoperta di un numero crescente di fratelli, ignorati o sconosciuti, vicino e lontani. La stessa chiamata dei primi discepoli, quegli uomini incontrati da Gesù sul mare di Galilea, è: «vi farò pescatori di uomini», cioè guardiani dei vostri fratelli.
Pur nei nostri limiti e nella nostra debolezza, l’ascolto della Scrittura resta il cardine stesso della fraternità tra noi e con i più poveri. Gli uomini e le donne di Sant’Egidio, in grande maggioranza laici, restano nella loro condizione ordinaria di vita – il lavoro civile, la casa, la famiglia, i figli – sin dall’inizio e tuttora, ogni sera, dopo aver speso una parte della loro giornata con i fratelli più deboli, sono raccolti nella celebrazione della Parola di Dio che a Roma viene predicata a Sant’Egidio – un antico monastero carmelitano del 1600 – da cui la Comunità prende il nome.
L’esperienza della Comunità di Sant’Egidio nei suoi trent’anni di storia si è giocata molta sulla solidarietà e sulla pace.
Siamo un gruppo di donne e di uomini, cristiani, liberi, laici, che ha cercato di vivere responsabilmente una fraternità nel proprio mondo, anzi da Roma, dove è iniziata la nostra esperienza, ha iniziato a vivere una fraternità in tante parti del mondo.
Il clima in cui è nata la Comunità di Sant’Egidio era il ‘68, quando si aveva la sensazione di poter cambiare tutto, particolarmente nel mondo giovanile. Ciò si esprimeva forse più nell’aspetto “contestazione” che nell’aspetto “costruzione”. Contestazione della politica, della Chiesa, del sistema educativo, della cultura occidentale, e via dicendo. Eppure la vicenda della contestazione conteneva una forte domanda di autenticità. Tale domanda dopo il ‘68 ha preso strade molto diverse. Ma per noi, allora studenti di un liceo romano, la spinta contestativa del ‘68 s’incontrò con un fatto importante: la scoperta del Vangelo. Direi che il Vangelo ci ha salvato dalle derive più tragiche o da quelle integralisticamente ideologiche del ‘68. Ho in mente i primi incontri, i primi passi, le prime esperienze; ricordo questo senso forte dell’incontro col Vangelo inteso come una parola autentica, non mistificata.
Poi il Vaticano II, che ha tracciato una nuova strada per la Chiesa nel mondo contemporaneo, strada che si presenta ancora come quella che i cristiani percorrono verso il prossimo millennio: è la via della fedeltà al Vangelo e, allo stesso tempo, quella della simpatia per l’uomo e la donna contemporanei.
L’inizio ben noto della Gaudium et spes dà il tono di questa simpatia: “Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini di oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e – così concludeva il Vaticano II – nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore”.
Il Vangelo ci è sembrato una parola di simpatia verso l’uomo e la donna contemporanei: da tale parola promanava un atteggiamento di rispetto, ma allo stesso tempo anche di vicinanza partecipe delle sue esperienze e delle sue angosce: «Sono il guardiano di mio fratello!».
La solidarietà è stata vissuta a Sant’Egidio come questa condivisione delle gioie e delle speranze, delle tristezze e delle angosce di tutti, ma particolarmente dei poveri. La solidarietà si accompagnava alla simpatia per le speranze e per le tristezze dell’altro. La solidarietà si reggeva, anche nei momenti difficili, sulla parola del Vangelo. Per noi la solidarietà non è stata sostituirsi alle istituzioni, ma vivere vicino ai poveri, anzi considerarli nostri amici, fratelli, insomma come parenti.
Questo è lo spirito con cui lavorano i membri di Sant’Egidio: con gli emigrati, con gli anziani, con gli handicappati, con i barboni, con gli anziani, con i malati di AIDS. Ogni comunità di Sant’Egidio, per piccola che sia, si caratterizza proprio per l’ascolto del Vangelo e per la solidarietà con i poveri. È la solidarietà nella grande miseria urbana, dove alla fatica di vivere si aggiungono la solitudine e l’isolamento come una malattia in più.
La solidarietà diviene una dimensione del vivere, il riconoscimento insomma che c’è un destino comune tra i meno poveri e i più poveri: l’affermazione nella nostra esistenza di una fraternità che i circuiti sociali vengono a negare. Si è fratelli non per legami di sangue – «Chi sono mia madre e i miei fratelli?» dice Gesù – ma perché accomunati da uno stesso destino e, soprattutto, perché si prende sul serio la domanda del Signore: «Dov’è Abele, tuo fratello?», resa ancora più larga dal Vangelo.
D’altra parte, è importante sottolinearlo, questa cultura della solidarietà è anche un’istanza critica di fronte all’affermazione violenta e diffusa nelle nostre società contemporanee, quella della “competitività” come valore guida. Questa cultura della solidarietà è una riserva d’interesse e di passione per un mondo che è fuori dall’attenzione, considerato diverso, e che in fondo conta e pesa poco.
Conta di più, negli ultimi anni, il valore dell’etnia, del legame forte con quelli simili a sé: il gruppo non è solo qualcosa che caratterizza alcuni conflitti africani, balcanici o caucasici. È la tentazione ragionevole, contagiosa e aberrante – diffusa nel nostro occidente democratico – di difendere a qualunque costo i propri interessi, quelli del proprio benessere relativo, difenderli da possibili invasioni dall’esterno. Qui ci sono le radici di ogni guerra. Non c’è sempre bisogno di affondare le proprie ragioni nei diritti del sangue, di una presunta razza, o del proprio territorio. È sufficiente che si diffonda la sensazione che le risorse siano limitate perché la tentazione etnica assuma i connotati di una difesa naturale ed equilibrata da ogni pericolo esterno.
Si è arrivati a teorizzare la “morte della solidarietà” come un grande progresso: «Oggi – si scrive – si è cessato di ghigliottinare gli antisolidaristi, che pure esistono ancora e ritengono che la solidarietà abbia ricevuto tutto l’incenso di cui è meritevole e molto di più. Perché non cambiare profumo, prima che venga il voltastomaco?». L’individualismo ha trasformato la società civile. Le persone più svantaggiate e più deboli non rappresentano più una forza con cui si debba fare i conti. I ricchi possono diventare più ricchi senza di loro; i governi possono essere rieletti anche senza i loro voti; e il prodotto nazionale lordo può continuare ad aumentare indefinitamente.
Tutta l’Africa subsahariana (se si toglie il Sudafrica) rappresenta meno del due per cento del volume degli scambi commerciali internazionali. Potrebbe essere inghiottita dai suoi due oceani senza ripercussioni di rilievo per i paesi dell’affluenza. Lo stesso vale per immense popolazioni come il Bangladesh. Sono qui le radici della guerra. Per questo la cultura della solidarietà – preziosa per il futuro di ogni società – è una riserva d’interesse e di passione per un mondo – in realtà una maggioranza – che è fuori dall’attenzione e che in fondo conta e pesa poco.
È questa la via quotidiana della costruzione della pace e della convivenza tra gli uomini. Oggi non è più un “optional”: o si costruisce la pace o si prepara la guerra. Dopo l’89 abbiamo visto come il fattore religioso sia divenuto un elemento decisivo nel cementare le identità nazionali e, per questa via, gli stessi conflitti. Si è parlato di una rinascita della guerra di religione (una definizione su cui non concordo, ma che suggerisce come le religioni possano divenire benzina sul fuoco delle guerre). Il caso della ex-Yugoslavia è evidente. Ma la stessa linea di incontro tra la civiltà occidentale, laico-cristiana, e il mondo musulmano, sta diventando una frontiera di incomprensione e talvolta di scontro. Il fondamentalismo religioso, soprattutto dalla fine degli anni settanta, sta rivelando un volto inquietante, con la sua volontà di totalizzare la società e di negare spazio all’altro credente di diversa religione e al non credente.
Giovanni Paolo II lo ha intuito ad Assisi nel 1986, quando ha convocato leaders delle Chiese cristiane e delle grandi religioni mondiali per pregare assieme e non per discutere. Nel quadro dei due blocchi, l’intuizione del Papa era semplice e basilare: le religioni l’una accanto all’altra, senza sincretismo ma pure senza odio, mai più l’una contro l’altra.
Come Comunità di Sant’Egidio abbiamo inteso continuare l’intuizione di Assisi, non senza qualche difficoltà. È importante far emergere la forza di pace che è nel profondo delle religioni: per ogni tradizione religiosa la pace che è nel profondo delle religioni: per ogni tradizione religiosa la pace è un valore sacro e basilare. Seppure – va detto – l’esperienza storica delle religioni abbia conosciuto stagioni in cui questo valore è stato ignorato, profanato, reso periferico. Solo l’andare in profondità della propria tradizione, stimolati dalla presenza degli altri e dai problemi del mondo, può consentire un recupero di quel valore del sacro. Questo recupero diviene allora una potente capacità di disarmo dei cuori e di educazione alla pace. Lo scopo delle religioni, per vie tanto diverse, è quello di purificare e pacificare i cuori: santità e pace, etica e pace, preghiera e pace, sono esperienze che si richiamano vicendevolmente.
Dal 1986, anno dopo anno, la Comunità di Sant’Egidio ha continuato il cammino di Assisi, invitando leaders delle differenti tradizioni religiose a parlarsi e a pregare gli uni accanto agli altri. Penso a quel 1 settembre 1989 a Varsavia, in una città trepidante per la memoria di quella guerra iniziata mezzo secolo prima ma anche per il cambiamento politico in corso. Ricordo il pellegrinaggio ad Auschwitz con cristiani, ebrei e musulmani. Ogni anno ha segnato l’ingrossarsi di un movimento di gente di fede per dialogare e per porre la pace al centro della propria riflessione.
Infatti la grande novità in questo mondo contemporaneo è l’abitare assieme dei diversi mondi religiosi quasi in ogni parte del pianeta. O avviene una maturazione nel rispetto per la libertà e l’identità dell’altro oppure la differenza è occasione di tensioni e di conflitti. Alla fine del Novecento una fede senza una “teologia dell’altro” è impensabile. Su questa strada abbiamo, consapevoli che non facevamo congressi di intellettuali, ma promuovevamo incontri di capi religiosi che rappresentavano – in qualche maniera – i loro fedeli. Penso al primo appello di Roma nel 1987: «La religione non vuole la guerra: che la parola religione sia sempre la pace! Che le donne e gli uomini non trovino mai nei patrimoni delle loro tradizioni religiose ragioni o incitazioni per odiarsi, combattersi, per essere spinti alla guerra e all’oppressione!».
Si è aperto un cammino di riconoscimento religioso dell’alterità, di culto della pace fatto in nome della fede, di dialogo vissuto come una virtù religiosa. Sant’Egidio è stata al centro di un pellegrinaggio di gente di religioni diverse, cristiane, ebrei, musulmani, buddisti, induisti, complesso e semplice allo stesso tempo. In questo cammino non si è mirato a un impensabile unificazione, come hanno sognato alcuni storici delle religioni: ma al senso dell’altro nella sua diversità irriducibile. Non si tratta di una crociata delle religioni contro la secolarizzazione o la modernità. Vuol essere la celebrazione di un aspetto importante della pace, cioè la capacità di vivere allo stesso tempo l’identità convinta e il dialogo fraterno aperto.
Credo che esista una responsabilità delle Chiese cristiane e delle grandi religioni.
È un tema che meriterebbe una trattazione non così rapida: troppo spesso le religioni giustificano la guerra (si veda il caso della ex-Yugoslavia), ma paradossalmente hanno nelle loro tradizioni anche una grande forza di pace.
L’abbiamo incontrata. Il dialogo interreligioso, mettendo a contatto l’uno con l’altro, fa sviluppare queste energie di pace. Ogni anno celebriamo un incontro interreligioso sulla pace, nel cui quadro sono scaturite iniziative di riconciliazione.
Tutti possono fare la pace o almeno lavorare per la pace. Vanno create sinergie con Stati e governi. Ma la prima nostra risorsa sono senz’altro le energie umane di ciascuno, rese fruttuose dall’incontro con il Vangelo. Per il resto, crediamo sia possibile, anche con mezzi poveri, o relativi, servire sogni più grandi di noi. La povertà del discepolo infatti, invitato alla missione senza «né oro, né argento, né moneta di rame, né bisaccia da viaggio, né due tuniche…» è un invito alla fiducia ad alla disponibilità. «Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date». Abbiamo sentito l’invito a misurarci con sfide nuove senza cercare di essere garantiti o protetti. L’apostolato fra i più deboli, non va solo “organizzato” nel migliore dei modo, ma va pensato come un segno.
Penso all’esorcismo frequente della morte, del dolore, della malattia, tratto marcato di questo nostro mondo occidentale. Penso alla paura delle giovani generazioni di riconoscere la finitezza della vita, paura che li espone in maniera drammatica a venti contrari e alle contraddizioni. Penso alle immagini televisive di “plastica”, canali di trasmissione di modelli sempre felici e sempre lontani. Come penso allo scandalo della morte come spettacolo, nuova forma di droga mediatica per scuotere sensi addormentati dal benessere, o intorpiditi dall’ignoranza.
C’è invece il valore eccezionale di una presenza amica vicino alla sofferenza, capace di accompagnare, di guarire, di consolare: «Sono il guardiano di mio fratello!». È quasi un’evangelizzazione del nostro tempo, fatta di gesti e di parole. Con il coraggio di contraddire l’illusione edonistica che suggerisce sia umano solo ciò che appare “sano”.
Penso al mondo barbaro e medioevale di Francesco, mondo di particolarismi e di guerre, di epidemie diffuse. Il giovane assisiate del 1200, nell’incontro con il lebbroso vince se stesso, e «ciò che prima gli risultava amaro, si mutò in dolcezza». Penso alle moderne epidemie come l’AIDS, che falcidiano anzitutto le popolazioni più deboli e che si affacciano anche nei paesi ricchi, quasi come un monito a riconsiderare la vacuità del benessere. Molto si potrebbe dire sui molteplici volti delle nuove povertà; mi basta per ora riflettere sulla qualità del segno che le opere di giustizia e carità assumono in questa fine di ventesimo secolo che sottolinea le disuguaglianze e che vede il Nord intento a erigere barriere sempre più insormontabili con l’oceano di poveri che lo circonda, e che si affaccia al suo interno, con i tanti volti del migrante, del malato, dell’anziano…
Senza un clima di riconciliazione, senza un ambiente capace di riconciliare, si sente il limite delle iniziative dei governi. Ma la pace è complessa, tuttavia non impossibile. Per la sua complessità richiede di non fuggire le armi del dialogo, della diplomazia, della riconciliazione. Nessun popolo, nessuna situazione, può essere abbandonata a un destino di guerra: per questo sono necessari diversi approcci.
Diceva il vecchio e saggio patriarca di Costantinopoli, Athenagoras, che aveva visto andare in frantumi il secolare mondo di coabitazione tra Balcani a Anatolia: «Tutti i popoli sono buoni. Ognuno merita rispetto e ammirazione. Ho visto soffrire gli uomini. Tutti hanno bisogno d’amore. Se sono malvagi, è perché non hanno mai incontrato l’amore vero… So anche che ci sono delle forze oscure, demoniache, che si impadroniscono talvolta degli uomini e dei popoli. Ma l’amore di Cristo è più forte dell’inferno. Grazie al suo amore noi troviamo il coraggio di amare gli uomini…».
DuemilaUno nr. 69 di luglio-agosto 1998
Ho bisogno di un tu per divenire: diventando io dico tu-di Roberto Minganti
di Roberto Minganti – già direttore responsabile della rivista DuemilaUno
Intervento alla conferenza ‘La solidarietà: le diverse radici spirituali di un valore umano’ organizzata dal Comitato Giovani Europeo della Soka Gakkai nel novembre 1998. Erano inoltre presenti membri di associazioni di volontariato sia cattoliche che laiche e rappresentati di altre scuole buddiste.
Nei giorni che precedevano la conferenza, interrogando molte persone mi sono reso conto che termini come Pace, Diritti Umani, Solidarietà, Tolleranza sono spesso usati come equivalenti per indicare qualcos’altro: un sentimento, un quid che pervade ogni termine senza essere poi completamente rappresentato da nessun termine. Hannah Arendt diceva che: «Per il mondo e nel mondo ha stabilità solo ciò che si può comunicare. Ciò che non viene comunicato o non si può comunicare, che non è stato raccontato a nessuno e non ha colpito nessuno, che non è penetrato per nessuna via della coscienza dei tempi e sprofonda senza significato nell’oscuro caos dell’oblio è condannato alla ripetizione. Si ripete perché anche se accaduto realmente non ha trovato nella realtà un luogo dove fermarsi». La difficoltà di trovare un nome mi ha fatto pensare alla reale assenza nel nostro vivere quotidiano di una coscienza diffusa – e soprattutto di una pratica – di questa “cosa” che oggi stiamo chiamando solidarietà. La convinzione alla quale sono giunto, e arrivo subito alla conclusione per poi tornare indietro, è che la solidarietà – intesa nella sua essenza più larga, quella che il Buddismo chiama interrelazione profonda tra tutto e tutti – sia il processo in continuo divenire che sottende la vita universale.
Tutto questo ha a che fare con l’entropia – in senso di disordine, come afferma Johan Galtung – disordine non come confusione ma come grado elevato di complessità: molteplici e diverse componenti che devono mantenere e valorizzare la loro diversità e molteplici e diversi legami di interazione fra loro. Ma può succedere che i legami di interazione non coprano tutte le possibilità, oppure – e questa è l’ipotesi peggiore – che privilegino solo alcuni legami arrivando a dannose forme di polarizzazione. Questo elevato grado di complessità e di entropia devono essere sostenute quindi da una forte base di solidarietà tra tutti gli esseri senzienti e non senzienti: esseri umani, esseri animali, esseri vegetali, esseri minerali (anche le pietre si ribellano – vedi il disastro del Vajont del 1963, di cui si è riparlato in questi giorni).
Vorrei ribattezzare la solidarietà con il termine simbiosi e ribattezzare simbiosi con il termine Vita. Metterei quindi al primo posto la dignità suprema della vita e definirei l’etica della simbiosi come la richiesta più naturale e pressante che la vita stessa fa a tutte le sue espressioni. Nel corso di questa breve riflessione – partendo dalla conclusione che ho appena enunciato – vorrei riportare il contributo dell’insegnamento contenuto nel Sutra del Loto alla formazione di un’etica della simbiosi – analizzando alcuni temi cardine: il rapporto io/altro, la compassione, la figura del bodhisattva e la necessità – per i buddisti – di scendere nella storia.
Cambiare punto di vista
«La terra è un’arancia blu» diceva il poeta Paul Eluard e il prof. Keating, il protagonista dell’Attimo fuggente di Peter Weir, invitava i suoi studenti a salire sui banchi e a vedere il mondo da lì. Diceva ai suoi allievi: imparate a spostarvi e a elevarvi: guardate con gli occhi di questo istante l’altro punto di vista dell’istante passato. Guardate le relazioni tra questi punti di vista, scoprite che attraverso queste relazioni potrete scorgere nuove strade che non possono essere notate da nessun punto di vista preso separatamente. Teilhard de Chardin affermava «che non conta solo l’intrinseca portata del problema considerato, ma, in egual misura, la prospettiva da cui viene preso in esame».
Mettere al primo posto la Vita e rifiutare la supremazia della prospettiva economica: quest’ultima, anche se riflette una serie di preoccupazioni reali, non può diventare un osservatorio privilegiato. «Gli occhi della nazione – scrive Daisaku Ikeda il presidente della Soka Gakkai Internazionale – fanno presto ad asservire la vita umana agli interessi di chi sta al potere, riducendo le persone a numeri o oggetti inanimati. Ma gli occhi della Vita guardano a ogni persona come a una preziosa, unica, irripetibile esistenza». Cambiare punto di vista significa anche evitare quello che padre Balducci chiamava “il vizio del pessimismo occidentale che si sviluppa all’interno di un processo in cui l’idea si contrappone all’idea, il pensiero al pensiero, ma sempre in una sfera distaccata dal reale, dalla condizione concreta dell’umanità per cui il monologo del pensiero astratto non accetta più l’altro come interlocutore».
Non esiste l’Io in quanto tale
Dal nuovo osservatorio, il primo fenomeno da prendere in considerazione è quello che comunemente chiamiamo il rapporto Io/altro.
Non esiste l’Io in quanto tale, ma solo l’io del rapporto fondamentale IO/TU… Ho bisogno di un Tu per divenire: diventando IO dico TU. È un’affermazione di Martin Buber. Il problema dell’altro da sé, così importante per un’etica della simbiosi, è affrontato dal Buddismo nei termini di una impossibilità di definire l’Io senza allo stesso tempo affermare l’altro, e con altro intendo il “totalmente” altro.
L’altro diventa il motore stesso del nostro sviluppo. Nichiren Daishonin spiegava questa interrelazione dal punto di vista individuale dicendo: «Quando ci si guarda in uno specchio e ci si inchina in segno di rispetto, anche la nostra immagine riflessa si inchina verso di noi». E da un punto di vista politico-sociale affermando: «Se ti preoccupi anche solo un po’ della tua sicurezza personale, dovresti prima di tutto pregare per l’ordine e la tranquillità in tutti e quattro i quartieri del paese, non credi?». Per un buddista – immagino – non è così scontato dire IO SONO: andare oltre l’illusione del pensiero dualista significa specchiarsi in quel laghetto dove Narciso si era bloccato fino a morire e trovarvi specchiato insieme alla propria immagine l’universo intero. Ogni individuo è la ricapitolazione della vita di tutti gli altri esseri.
Il re buddista Ashoka in uno dei suoi editti auspicava quasi un nuovo rito verso l’altro: «Non riti superstiziosi, ma gentilezza e rispetto verso i servi e gli inferiori, rispetto verso coloro che meritano rispetto, autocontrollo e dolcezza nel rapporto con le creature viventi. Questi, e azioni virtuose di natura simile, sono in verità i riti che devono essere eseguiti dappertutto».
La visione cosmica dell’umanesimo: microcosmo e macrocosmo
Nel Sutra del Loto è molto chiara questa visione cosmica dell’umanesimo, quella che il maestro cinese T’ien-t’ai aveva sintetizzato nel principio di ichinen sanzen (tremila mondi in un istante di vita): «Dobbiamo realizzare la natura del rapporto tra il microcosmo del nostro corpo e il macrocosmo dell’ambiente: tremila mondi in un momento di vita. Compiendo il cammino si diviene consapevoli dell’essenza della realtà. Il corpo-mente individuale permea la Realtà Universale». Sembra avvertire questa stessa consapevolezza nei versi del poeta indiano Tagore (ipertesto): «Notte e giorno nelle mie vene scorre lo stesso flusso vitale che attraversa il mondo intero intrecciando ritmiche danze… sono orgoglioso che il palpito vitale dei secoli danzi in questo momento nel mio sangue».
Questo umanesimo cosmico non è un patrimonio unico del buddismo, è una coscienza – a quanto mi risulta poco utilizzata – già presente in occidente. Il prof. Giulio Sforza, durante un convegno su Religioni ed educazione ha detto: «A noi è dato di vivere l’esaltante vicenda di una coscienza che si fa più chiara a se stessa dilatandosi in coscienza cosmica ed avvertendo l’universo come suo corpo.… La religiosità intende l’unità del reale». Questa unità del reale, nel Sutra si riscontra subito osservando chi era presente alla predicazione del Budda: non solo monaci o monache, ma un numero – incredibile a credersi come tutte le altre metafore del Sutra – di esseri di ogni genere, posizionati non in ranghi inferiori. Non c’è l’essere umano al centro, ma un’interrelazione paritaria tra tutte le forme di vita. L’atmosfera è serena e tranquilla, permeata da musica, profumi, piogge di fiori.
Fin dai primi capitoli vengono affermati due princìpi cardine del Buddismo: l’origine dipendente dei fenomeni e la loro natura non-sostanziale (shunyata in sanscrito). Il principio unificante è la natura di Budda che pulsa allo stesso modo nell’universo interiore di ogni essere come nel grande universo che contiene tutto. Il Budda dichiara subito che il suo unico desiderio è come fare in modo che tutti raggiungano il più alto livello di esistenza, senza alcuna distinzione con lui stesso.
Essenza e vita quotidiana
Questa concezione della vita universale viene ulteriormente chiarita in quella definita la Cerimonia nell’Aria. Appare una Torre Preziosa tempestata di gioielli, grande quasi come la metà del globo terrestre che accoglie il Budda e tutta l’assemblea. Dal Picco dell’aquila, quindi, l’assemblea viene trasportata in alto e poi di nuovo torna sulla terra. Questo doppio movimento è importante: la torre preziosa emerge dalla terra del mondo fenomenico, si innalza trascendendo i limiti di spazio e tempo e ritorna sulla terra. Ciò vuol dire che il mondo della Buddità non può e non deve essere separato dal reale.
Quella che la Soka Gakkai definisce “rivoluzione umana”, non è altro che la ripetizione continua di questo processo di ascesa dalla vita reale alla Cerimonia nell’Aria e ritorno alla vita reale. Si potrebbe pensare anche all’atto religioso individuale come un ciclo che inizia con l’attivazione dell’universalità dentro di se che prosegue nell’agire sociale come ricerca della stessa universalità negli altri e ritorna arricchito al sé individuale.
La pioggia del Dharma
La legge mistica, o buddità, che permea l’universo è caratterizzata dalla compassione. Nel Sutra del Loto questa viene rappresentata – usando una metafora legata al clima dell’India – come una grande nuvola che sorge sul mondo fino a ricoprirlo interamente.
Questa benefica nuvola è carica di umidità. «L’uguaglianza della predicazione del Budda è come una pioggia dall’unico aroma – afferma Shakyamuni – che però non viene ricevuta da tutti gli esseri viventi nello stesso modo, ma a seconda della loro natura. Così come l’umidità viene ricevuta diversamente dai vari tipi di piante e alberi.…Io elargisco la pioggia del Dharma colmando il mondo intero e questo Dharma dall’unico aroma viene praticato da ciascuno secondo il suo potere individuale».
Più avanti il Budda afferma «di considerare le cose universalmente uguali. La mia mente non preferisce questa o quella, non ama una cosa e odia un’altra.
Il bodhisattva Fukyo
Nel XX capitolo del Sutra del Loto appare un bodhisattva che più di altri incarna la pratica attiva di quella che potremmo chiamare la virtù dell’umanesimo cosmico o anche l’etica della simbiosi. Questo bodhisattva si chiama Fukyo che letteralmente vuol dire «Colui che non disprezza mai». Questo monaco rendeva omaggio a qualunque persona gli capitasse di incontrare: univa le palme delle mani e inchinandosi rispettosamente diceva: «Non oserei mai disprezzarvi perché voi tutti otterrete di sicuro la buddità». La gente, molto spesso, rispondeva al monaco lanciandogli dei sassi.
Lui, dopo essersi messo prudentemente fuori tiro, continuava a riverirli con le stesse parole. Nichiren Daishonin considera il bodhisattva Fukyo (sanscrito Sadhapaributha) come il miglior esempio di pratica buddista: «Cosa significa il profondo rispetto del Bodhisattva Fukyo per la gente? – scriveva – Il vero significato dell’apparizione del Budda Shakyamuni in questo mondo sta nel suo comportamento come essere umano».
Una volta messa da parte la dicotomia sé/altri, tra l’eros, essere per se, e l’agapé, essere per gli altri, cade anche quella tra egoismo e altruismo: l’impresa di Fukyo non è semplicemente altruistica, perché lui, lodando la buddità delle altre persone contemporaneamente lodava la sua, valorizzando gli altri valorizzava se stesso. «Ciò che dai a un altro diventerà il tuo stesso nutrimento – commenta il Daishonin – se accendi una lanterna a un’altra persona, la sua luce illuminerà anche il tuo cammino».
Il valore della differenza
Dopo aver affermato l’inseparabilità dei fenomeni tra loro e l’inseparabilità dei fenomeni dall’essenza universale, viene affermata la “diversità” come valore fondamentale. Non la semplice dichiarazione – che facilmente potrebbe scadere nell’ipocrisia – di amore verso l’umanità, ma la compassione verso quel preciso essere, verso quella singola persona. «Amo l’umanità – grida Lucy l’amichetta di Charlie Brown – sono le persone che non sopporto». Sembra di sentire Dostoevskj quando dice che a molte persone orgogliose piace credere in Dio, specialmente a quelle che disprezzano gli altri… La ragione è ovvia.
Si rivolgono a Dio per evitare di rendere omaggio agli esseri umani». Il problema fondamentale per il prossimo millennio sarà proprio quello di fare i conti con l’unicità di ogni singola persona, e di creare armonia nella diversità. La pioggia compassionevole cade su tutti e su tutto allo stesso modo, non fa differenza ma sostiene e mantiene in vita la differenza. Per differenza non intendo solo il riconoscimento del valore della singola persona in quanto tale, ma il riconoscimento dei valori dell’ordine di riferimento cui quella persona appartiene: il genere (maschile e femminile), la razza, l’etnia, la religiosità, il censo e via dicendo. La domanda che mi pongo è se, in quanto buddista, riesco non solo a rispettare ogni singola persona, ma a valorizzare il contributo che quella persona riesce a dare come portatrice di una differenza di sesso, di razza, di etnia, di cultura, di nazionalità, di classe etc.
Compito delle persone comuni
In una recente intervista al quotidiano Il Manifesto, Susan George, direttrice del Transnational Institute di Amsterdam, parlando del debito dei paesi del terzo mondo, ha detto: «Dovrei essere scoraggiata ma non lo sono. Ho fiducia nella gente comune. L’umanità ha già combattuto ignominie quali la tirannia e la schiavitù». Credo che i bodhisattva del terzo millennio siano le persone comuni che riescono ad assumersi totalmente la responsabilità del loro ambiente – fisico o sociale – a cominciare da quello che hanno più vicino.
Daisaku Ikeda li chiama cittadini del mondo – persone che, in un certo senso, non hanno più dimora – perché hanno scelto l’universo come dimora, persone che fanno i conti con una ideale molteplice appartenenza. In qualche modo sono eroi nel senso in cui li intendeva Hannah Arendt: «La parola eroe originariamente, cioè in Omero, non era niente più che un appellativo dato a ogni uomo libero che partecipava all’impresa di Troia e intorno al quale si poteva raccontare una storia. La connotazione del coraggio, che noi ora sentiamo qualità indispensabile dell’eroe, è già presente in ogni volontà di agire e parlare, di inserirsi nel mondo e diventare una storia di se stessi».
Buddismo e III millennio
La sfida più importante che il Buddismo ha di fronte nel III millennio sarà quella di portare nella società il suo messaggio, non rimanere solo una bella promessa. Johan Galtung auspica una presenza forte del Buddismo nei fatti del mondo: se abbandona il suo motivo iniziale di religione nata per le persone – afferma – rischia di cadere nel ritualismo e i suoi punti forti come la tolleranza e la nonviolenza rischiano di renderlo connivente con il potere politico. Nel passato ci sono già stati segnali di degenerazione: secondo il codice Joei del 1232, tutti coloro che collaboravano con lo shogun di Kamakura avevano diritto alla protezione del governo, altrimenti erano considerati disturbatori della pace. Nel periodo Edo (1600), i gruppi buddisti erano diventate agenzie di controllo al servizio dello stato, un vero e proprio prolungamento del potere Tokugawa. Più recentemente, sempre in Giappone, la maggior parte dei gruppi buddisti sostenne – prima e durante la 2a guerra mondiale – lo sforzo bellico dei nazionalisti al potere.
In quanto buddista e laico credo che il tempo non s’insinua passivamente dietro le mie spalle. Siamo noi a creare il tempo soggettivo (kairos). Il tempo oggettivo (kronos) invece, è affare delle stelle e degli orologi atomici. Come afferma il teologo Carlo Molari: «Pregare per la pace non serve a far intervenire Dio al nostro posto, ma per farci assumere atteggiamenti che ci consentano di realizzare la sua volontà.
La preghiera non serve per cambiare l’opinione di Dio nei nostri confronti o per farlo agire diversamente, ma per modificare il cuore degli esseri umani. Il futuro dell’umanità non cade dal cielo, non è un’irruzione improvvisa per un intervento di Dio… la pace di Dio non può entrare nella storia dell’umanità se questa non compie scelte di pace». Vorrei portare un esempio italiano che ha contribuito alla mia formazione e che ritengo esemplare: quello di Don Milani che spiritualmente avvicino al fondatore della Soka Gakkai, il pedagogista Tsunesaburo Makiguchi. L’azione educativa, religiosa di don Milani diventava politica e sociale nel momento in cui spingeva giovani a trasformare creativamente la loro vita e i conflitti che si trovavano di fronte. La sua battaglia per l’obiezione di coscienza diventava ad esempio l’inizio di una nuova solidarietà sociale che educava i giovani a trovare risposte diverse alla guerra.
Oggi le associazioni laiche buddiste – di ogni scuola e tradizione – potrebbero rappresentare una nuova figura di bodhisattva: il bodhisattva collettivo, capace di operare nel mondo non solo «con la forza spirituale dell’individuo – come afferma il prof. Venturini – ma con l’autorevolezza di un movimento di massa. Operando senza condizioni e senza compensi».
Per chiudere vorrei lasciare un’immagine che viene da una parabola giapponese – secondo me emblematica di questo discorso. Una persona scende nel mondo d’inferno e vede che c’era tantissimo cibo ma le persone soffrivano e pene (appunto dell’inferno) perché non riuscivano a prenderlo: avevano bacchette troppo lunghe, più lunghe delle loro braccia. Era impossibile quindi portarlo alla bocca. Si sposta poi nel mondo di buddità: anche lì c’era tantissimo cibo, l’ambiente era lo stesso del mondo d’inferno, le bacchette erano le stesse, quindi più lunghe delle loro braccia, ma le persone erano invece estremamente felici. Come mai? Avevano trovato un modo per nutrirsi: si imboccavano l’una con l’altra. Il messaggio è chiaro: non esiste una differenza tra un ambiente d’inferno e quello della buddità, la differenza vera sta nel cuore e nella solidarietà delle persone che ci abitano.
DuemilaUno nr. 69 di luglio-agosto 1998
Bibliografia
H Arendt, Rahel Varnhagen. Storia di un’ebrea. Il Saggiatore, Milano, 1988.
H. Arendt, Banalità del Male, Feltrinelli, Milano, 1992
H. Arendt, Vita activa. La condizione umana, Bompiani, Milano, 1991
B. Watson (traduzione italiana di Miglionico, Micheli, Notari), Il Sutra del Loto, Esperia edizioni, Milano, 1998
M. Ceruti, G. Bocchi, E. Morin, Turbare il futuro, Moretti e Vitali ed. Bergamo, 1990
R. Venturini, Coscienza e cambiamento, La Cittadella, Assisi, 1996
J. Galtung, Buddhismo una via per la pace, ed. Gruppo Abele, Torino
N. Daishonin, Gli scritti, Associazione Italiana Soka Gakkai, Firenze
D. Ikeda, La vita mistero prezioso, Bompiani, Milano
D. Ikeda, Il capitolo Hoben, Esperia, Milano
D. Ikeda, Il capitolo Juryo, Esperia, Milano
H. Maturana, F. Varela, La via di mezzo della conoscenza, Feltrinelli, Milano, 1991
F. Savater, Etica come amor proprio, Laterza, bari, 1994
S. Veca, F. Alberoni, L’altruismo e la morale, Garzanti, Milano, 1988
W. Rahula, L’insegnamento del Budda, ed. Paramita, Roma, 1994
R. Tagore, Poesie, Newton Compton, Roma, 1971
