La filosofia di pace di Nichiren Daishonin-Articolo di Masahiro Kobayashi
Gli scritti di Nichiren Daishonin – in particolare il trattato Adottare l’insegnamento corretto per la pace nel paese, che segna la sua comparsa sulla scena mondiale – riflettono il suo grande interesse per la politica. Intervenendo direttamente sulla vita degli esseri umani, la politica ne determina la felicità o l’infelicità, e per questo il Daishonin si dedica con tanto impegno a vigilare sull’operato del governo, ritenendo che lo scopo comune della religione e della politica sia quello di garantire la pace e il benessere di tutte le persone.
Attualmente, la religione che in Giappone vanta il più alto numero di credenti è il Buddismo fondato da Nichiren Daishonin. Il motivo per cui i suoi insegnamenti sono così popolari è che il suo stile di vita offre coraggio e speranza, oltre ad avere una forte attrattiva umanistica.
Le rivendicazioni che Nichiren mise in atto nel corso della sua vita furono spesso intese come una critica alla religione e alla politica del governo del tempo, e del resto le scuole buddiste allora affermate erano altamente critiche nei suoi confronti. Per questo motivo la vita di Nichiren fu contrassegnata da continue persecuzioni. Venne aggredito quattro volte, due volte esiliato, e una volta sfuggì per pochissimo a una condanna a morte. Nonostante ciò, grazie a una indomabile forza vitale e a una determinazione di ferro volta a superare qualsiasi difficoltà, fu in grado di affrontare vittoriosamente ogni sorta di ostacolo. Questa sua incredibile capacità non fece che aumentare il suo fascino.
Oggi il Buddismo di Nichiren si è diffuso in centonovantadue paesi del mondo grazie all’impegno della Soka Gakkai Internazionale e del suo presidente Daisaku Ikeda, dedito a dialogare con personaggi di spicco a livello mondiale per la realizzazione della pace.
La comparsa di Nichiren sulla scena mondiale può essere fatta coincidere con la presentazione del trattato Adottare l’insegnamento corretto per la pace nel paese, da lui inviato al leader politico più importante della sua epoca. In quest’opera il Daishonin avverte dei pericoli imminenti che il Giappone avrebbe dovuto affrontare, e indica i passi necessari per la costruzione di un mondo pacifico. Nel 1260 il Daishonin aveva trentotto anni e il Giappone era appena entrato nel Medioevo, caratterizzato da un sistema di governo feudale. Per inciso, anche Gandhi aveva trentotto anni quando diede inizio al movimento nonviolento satyagraha in Sud Africa.
All’inizio del trattato il Daishonin usa uno stile che evoca la poesia cinese classica: «Negli ultimi anni si sono manifestate insolite perturbazioni nel cielo e strani fenomeni sulla terra. Carestie e pestilenze affliggono ogni angolo dell’impero e si diffondono in tutto il paese. Buoi e cavalli cadono morti per la strada e le loro ossa ricoprono le vie maestre. Più della metà della popolazione è stata falciata dalla morte e non c’è una persona che non pianga almeno un lutto in famiglia» (RSND,1, 6; cfr. SND, 1, 3).
Nel manoscritto originale questo brano – un esempio delle doti poetiche del Daishonin – è composto di dieci righe di quattro caratteri cinesi ciascuna, che creano un ritmo nella lettura. Questa poesia inoltre non è una semplice espressione di solidarietà, ma descrive in termini molto chiari – senza sentimentalismi ed emotività – la triste condizione dell’epoca, denunciando la vera sofferenza delle persone comuni.
Quando viveva a Kamakura, la capitale, Nichiren era stato testimone diretto di questo panorama infernale. Terremoti, forti venti e piogge avevano portato distruzione causando inevitabili epidemie, carestie e incendi che avevano colpito ancora più duramente la popolazione, compromettendo lo svolgimento della vita quotidiana.
Vedendo i cadaveri delle persone ammassati per le strade di Kamakura, il Daishonin percepì acutamente quanto la vita sia preziosa e, mettendo a rischio la sua stessa vita per proteggere quella degli altri, scrisse il trattato Adottare l’insegnamento corretto per la pace nel paese come una denuncia verso le autorità governative di uno stato che ignorava la sua componente più importante – le persone.
Il trattato, scritto in forma di dialogo immaginario, è composto di dieci domande e nove risposte, e si svolge tra un viaggiatore e il padrone di casa che lo ospita. Il viaggiatore apre la conversazione dolendosi dello stato delle cose, e la conclude dichiarando la sua ferma decisione di fare quanto gli è possibile per cambiare la situazione. La lamentela del viaggiatore è la stessa del padrone di casa, che afferma: «Fino a oggi mi sono preoccupato da solo, angustiato nel profondo del cuore, ma ora che voi siete qui possiamo lamentarci insieme» (RSND, 1, 7; cfr. SND, 1, 5). E il viaggiatore risponde: «Non sono io il solo a soffrire: l’intera popolazione è oppressa dal dolore» (Ibidem). È evidente che il viaggiatore e il padrone di casa condividono un’opinione simile sulla situazione.
Sebbene la persona più influente del paese e un prete anonimo possano avere posizioni sociali molto diverse o differenti visioni in fatto di religione, se il desiderio di pace di entrambi resta integro allora è possibile stabilire una base per il dialogo. Il fatto che il Daishonin utilizzi, per presentare la sua tesi, la forma dialogica tra un buddista e un leader politico denota la sua fiducia nel potere del dialogo come mezzo per operare un cambiamento. L’inizio del trattato è costituito proprio da un dialogo sulla pace e sul modo di realizzarla.
Il motivo per cui le argomentazioni del Daishonin sono così avvincenti sta nel fatto che egli mette al centro gli esseri umani, facendo appello ai capi del paese affinché prima di tutto garantiscano stabilità alla vita delle persone comuni. Con il trattato Adottare l’insegnamento corretto per la pace nel paese dimostra che a prescindere dalle dimensioni del problema – locale, nazionale o globale – lo scopo comune di ottenere la pace tra gli esseri umani costituisce una base universale per aprire canali di comunicazione e comprensione.
Inoltre, sulla base di meticolosi studi sulle scritture buddiste, Nichiren predice in questo trattato che si sarebbero verificati conflitti interni ed esterni, distinguendo tra le calamità che erano già avvenute e quelle che si sarebbero ancora dovute manifestare. Le due calamità che ancora non erano apparse erano di natura militare.
Il Daishonin si rendeva conto che una guerra, le cui conseguenze si sarebbero sommate a quelle delle calamità naturali che già affliggevano il paese, avrebbe comportato la distruzione totale per i cittadini inermi e avrebbe condotto il paese alla rovina. Questo avvertimento ai capi del paese può essere inteso come un’inequivocabile presa di posizione del Daishonin contro la guerra.
La poesia in stile cinese classico all’inizio del trattato rappresenta il lamento del viaggiatore, che può essere identificato con il destinatario Hojo Tokiyori, l’ex reggente del Giappone dell’epoca. Essa esprime in modo eloquente la convinzione del Daishonin secondo cui la missione e la responsabilità di assicurare la pace è nelle mani di chi detiene il potere.
L’attenzione alla politica
Vorrei ora tracciare, sulla base degli scritti del Daishonin, un profilo del leader politico ideale. Nichiren ritiene che tale figura debba possedere due caratteristiche fondamentali: essere una persona onesta e di buon carattere, e assegnare la massima priorità alle persone.
Per specificare meglio le caratteristiche del primo aspetto, una persona di questo tipo non deve mentire, deve essere virtuosa e in grado di resistere alle offese, deve sapere ascoltare entrambi i punti di vista in una disputa e non deve mai lasciarsi corrompere anche a costo della propria vita.
Riguardo al secondo punto, in particolare dovrebbe: rendersi più utile di quanto non facciano i suoi subordinati, essere a conoscenza di ciò che affligge il popolo e saper esaminare i fatti, operare concretamente per il bene delle persone. Naturalmente tutti gli esempi sopra citati vanno inseriti nel loro contesto storico e occorre prendere in considerazione le varie sfumature.
Gli scritti di Nichiren riflettono il suo grande interesse per la politica. Secondo il Daishonin, le azioni e la politica del governo influiscono direttamente sulla vita e quindi sulla felicità delle persone. Se il sovrano governa male, è il popolo a soffrirne. Ciò dimostra quanto egli fosse consapevole delpotere che detengono i capi di governo. Il suo sguardo sulla politica restava sempre vigile perché si rendeva perfettamente conto di quali conseguenze le persone avrebbero dovuto affrontare in seguito alle decisioni governative.
Mettendo in relazione la politica con la religione, emerge come la politica serva a eliminare le barriere esterne che impediscono alle persone di diventare felici, mentre la religione abbia la missione di fornire il mezzo per eliminare le barriere interne. Infatti per fare questo è necessaria un’onesta autoanalisi, ed è grazie alla religione che è possibile trovare il modo di raggiungere la pace dentro di sé. Riguardo alle barriere esterne che ostacolano la felicità, le persone sono spesso alla mercé di chi governa. Nel caso di calamità naturali, per esempio, la priorità dovrebbe essere quella di fornire alle persone colpite beni di prima necessità per la sopravvivenza quotidiana. Anche in questo caso si dimostra quale grandissima responsabilità abbia il governo, ed è proprio per l’enorme impatto che il governo ha sulle persone che il Daishonin si è espresso tanto spesso e con forza sull’argomento. Egli riteneva che lo scopo comune della religione e del governo fosse la pace e che su questo punto le due parti dovessero essere in perfetto accordo.
Dalla parte della gente comune
Esaminando la storia del Giappone e delle sue molteplici guerre, Nichiren fa notare addolorato quale disperazione provochi un conflitto armato. Il fatto che egli analizzi il conflitto armato dal punto di vista di chi ha perso la vita e da quello di chi ha perso la guerra caratterizza in modo inequivocabile il suo pensiero. In merito alla battaglia del Giappone contro una delle più potenti forze militari del tempo, l’impero mongolo, scrive: «Così nessuno dei contadini e degli altri abitanti si salvò [dai mongoli]: gli uomini furono uccisi o presi prigionieri, le donne furono radunate e vennero loro trapassate le mani con le corde per legarle alle navi o imprigionarle» (Lettera al prete laico Ichinosawa, RSND, 1, 472; cfr. SND, 8, 144).
Nichiren, a differenza dei leader giapponesi, non guardava all’arrivo dei mongoli da un punto di vista politico, pertanto non parlava del conflitto in termini di vincitori o vinti, aggressori o vittime, invasori o invasi. Viceversa si preoccupava della tragedia che avveniva nella vita delle persone comuni. Dal suo punto di vista le persone sono sempre al primo posto.
L’arma di Nichiren
È anche degno di nota il fatto che lo stesso Nichiren non portava mai armi né le utilizzava. Un suo discepolo, che era un guerriero, una volta gli inviò una spada. In risposta il Daishonin osservò: «Tu hai offerto una spada al Sutra del Loto. Quando la portavi al fianco era una spada del male, ma ora che l’hai offerta al Budda è diventata una spada del bene» (Le spade del bene e del male, RSND, 1, 400; cfr. SND, 4, 198). Poiché le armi servono a togliere la vita, egli le reputava malvagie.
Dopo che il Daishonin fu ordinato prete, per forza di cose non portò mai la spada. Per scelta la sua arma era il Sutra del Loto. «Usa la strategia del Sutra del Loto prima di ogni altra […] L’essenza della strategia e dell’arte della spada derivano dalla Legge mistica. Abbi profondamente fede in questo. Un codardo non potrà mai ottenere risposta a nessuna delle sue preghiere» (La strategia del Sutra del Loto, RSND, 1, 889; cfr. SND, 4, 195). Con l’eloquenza di un buddista determinato, egli dichiara che nessun’arma è più potente di una fede coraggiosa.
In realtà Nichiren fu un devoto – cioè un praticante scrupoloso del Sutra del Loto – che mise in pratica questo insegnamento con la sua stessa vita, superando diverse gravi persecuzioni durante il suo ministero religioso.
Reinterpretò lo spirito del Sutra del Loto, che si basa sull’atto di salvare le persone comuni, trasformandolo in principi da seguire nella vita quotidiana, e si batté per la pace del genere umano.
Sono profondamente convinto del fatto che la filosofia di Nichiren Daishonin di lottare per la pace abbia un valore inestimabile, non solo per il Giappone ma per tutto il mondo moderno.
Buddismo e Società n.134 – maggio giugno 2009
(tradotto dal Journal of Oriental Studies, vol. 18, 2008)
Paura di vivere, paura di morire-Intervista a Riccardo Venturini
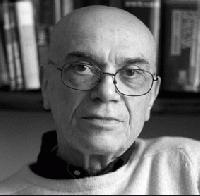
Laureato in Filosofia e in Medicina, Riccardo Venturini è stato professore ordinario di Psicofisiologia clinica nell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. La sua formazione lo ha portato ad assorbire, da un lato, gli insegnamenti dell’idealismo italiano, dell’esistenzialismo francese e del marxismo gramsciano; dall’altro, quelli della psichiatria fenomenologica e della scuola psicanalitica di Parigi. Dedicatosi agli studi psicofisiologici, ha svolto ricerche in campo clinico e sperimentale seguendo la tradizione fisiologica russa di Pavlov, Bykov, Anochin, Sudakov, autori di cui ha anche curato la traduzione italiana di varie opere. Da anni si occupa prevalentemente dello studio degli stati di coscienza e dei livelli di vigilanza, sia nel contesto della psicologia occidentale che in quello delle psicologie tradizionali orientali. Pratica e insegna la meditazione buddista mahayana, le cui tecniche ha appreso sotto la guida di maestri occidentali e orientali. Attualmente è interessato all’interpretazione, nei termini della psicologia transpersonale, delle tecniche di meditazione e di preghiera.
Impegnato nel dialogo interreligioso, è stato garante della Fondazione Maitreya e co-presidente della sezione italiana della World Conference on Religion and Peace. Dirige il Centro di cultura buddhista e coopera con movimenti buddisti giapponesi.
Quando a qualcuno di noi è venuta l’idea di intervistare Riccardo Venturini sul tema della paura e del coraggio c’è stato un coro di sì e una cornice di visi sorridenti intorno al tavolo della riunione, come di chi ha trovato l’idea giusta. Professore di Psicofisiologia, e dunque esperto di processi che stanno all’incrocio tra “corpo” e “psiche”, nonché studioso e praticante il Buddismo mahayana: chi meglio di lui poteva aiutarci a capire il ruolo della paura nella sfera emotiva umana, il modo di trattarla ed eventualmente di utilizzarla?
A coronamento di una fitta corrispondenza elettronica, di telefonate e della lettura di un lavoro del professore già in corso sul tema, siamo riusciti – anche senza aver potuto incontrarci fisicamente – a redigere questa intervista. Con il proposito reciproco di collaborare ancora e più direttamente nel futuro.
Da dove nasce la sua attenzione per il tema della paura?
Nasce dal mio interesse per le aree di frontiera tra il biologico e il mentale, tra la natura e la cultura, che rappresentano altrettante “sfide” per una disciplina come la psicofisiologia clinica, chiamata a esaminarle e gestirle a partire dal vissuto personale.
E una di tali aree è proprio quella della paura: immiserita nelle trattazioni “scientifiche” ordinarie, essa esige invece di essere immaginata, analizzata e problematizzata attraverso l’incontro di riflessioni cliniche, storiche, artistiche, spirituali, linguistiche, etc. Essa costituisce, infatti, una preziosa occasione di approfondimento personale e professionale, consentendo sia di affrontare lo studio della condotta normale o disfunzionale sia di offrire una prospettiva dalla quale è possibile riconsiderare l’insieme dei disturbi della condotta.
Un aspetto dunque quasi “onnipresente”?
Sicuramente la paura è una emozione/sentimento che accompagna molte (o tutte, se ne consideriamo anche gli aspetti latenti) delle operazioni in cui si articola la condotta, trasformandosi spesso da fondamentale indicatore di salvaguardia a fattore di stress e di patologia, poiché la paura della sofferenza e degli aspetti “negativi” della vita, motivando condotte di fuga, diviene spesso occasione di ulteriori e più profonde sofferenze. E non solo a livello individuale: come dice il grande storico J. Delumeau, la paura e il bisogno di sicurezza ci consentono una comprensione della condotta umana, individuale e collettiva, più profonda di quanto non ci permettano altre categorie, come, per esempio, il concetto di libido.
Se la fenomenologia della paura, che assume espressione in numerose “figure”, si presenta molto ampia, altrettanto ampio è il campo di studio di essa, caratterizzato dalla interazione di discipline diverse (dalla psicologia fisiologica all’antropologia, dalla psicopatologia allo studio dei sistemi di pensiero e delle mentalità, alla storia dei costumi, etc.) e dalla compresenza di molteplici modalità e strumenti di approccio (come quelli della psicometria, delle rappresentazioni sociali, della linguistica, dei costrutti personali, etc.): di qui la necessità, per “aprire” il costrutto ai differenti livelli in cui si manifesta, di impiegare la più ampia “utensileria” disponibile.
Lei ha intitolato un suo recente lavoro sul tema della paura con una sintesi molto efficace: “Paura di vivere, paura di morire”. Può approfondire questo punto di vista?
Guardando alla nostra vita nella sua interezza, tutto è cominciato con una scena in cui noi eravamo assenti e tutto quanto ci riguarda si concluderà in una scena che – quando sarà compiuta – non riguarderà più noi. A partire da lì, due grandi paure attraversano la nostra esistenza: la paura di vivere (della precarietà, dei pericoli e delle sofferenze della vita) e la paura di morire (di essere cancellati nell’insignificanza o di venire puniti da un inesorabile giudice trascendente). Tra queste due scene fondamentali, tra questi due eventi capitali ecco configurarsi il ponte del desiderio e dell’amore, con le nostre paure del desiderio e nel desiderio. La storia della cultura è in gran parte la storia dell’elaborazione di strategie per sconfiggere, manipolare, convivere con la paura. Le narrazioni esemplari (o mitiche) che le grandi tradizioni ci offrono sulla vita e sulla morte possiamo quindi leggerle come un racconto sulle nostre paure.
Lei dice: tra la nascita e la morte, c’è il ponte del desiderio e dell’amore, con la paura del desiderio e nel desiderio. Una lettura sugggestiva che verrebbe voglia di approfondire.
Poiché la vita si scopre precaria, incerta, insufficiente o troppo piena di insopportabili sofferenze, si può arrivare ad aver paura di vivere, e, paradossalmente, si può vivere “al risparmio” o perfino rinunciare a vivere perché vivere si rivela pericoloso e angoscioso. All’altro estremo, la paura della morte, simbolo di tutte le vulnerabilità che limitano e minacciano l’individuo e la sua vita. Paura di vivere, paura di morire e, tra esse, paura di amare, esprimono, in sintesi, le fondamentali e universali manifestazioni di questo sentimento.
Come possiamo definire la paura?
Nell’ambiguo statuto riservato alla paura nelle trattazioni psicologiche, si riflettono e si esprimono le incertezze legate al campo semantico del termine. Nella sua forma più generale, seguendo il Webster’s Int. Dictionary of the English Language, possiamo dire che «la paura è uno stato emotivo spiacevole, caratterizzato dalla anticipazione di dolore, sofferenza o forte disagio, accompagnato da un’esaltata attività neurovegetativa».
Nel Traité de psychologie (1923-24) curato da Georges Dumas (forse l’ultimo dei trattati in cui troviamo ancora presente un capitolo abbastanza ampio sulla vita affettiva,

e che include anche il sentimento sociale, religioso e morale), si sottolinea che la definizione della paura come reazione causata dalla rappresentazione di un dolore o di un male possibile fu giustamente criticata da chi rilevava come tale definizione non sia applicabile alle forme innate e istintive della paura, non attribuibili cioè ad alcuna esperienza individuale e riscontrabili anche nei piccoli degli animali.
Dumas osserva ancora che «l’emozione della paura, come l’emozione della gioia e l’emozione della tristezza, si presenta, dal punto di vista soggettivo, sia sotto una forma passiva sia sotto una forma attiva. Nella forma passiva, quando la paura è intensa, il soggetto presenta unitamente alla rappresentazione chiara o confusa, astratta, schematica, ma particolarmente intensa del pericolo, un’anestesia della sensorialità e della sensibilità [generale], una ottusità, una mancanza di coordinazione di tutte le funzioni mentali superiori. Nella forma attiva, quando la paura è intensa, si possono constatare gli stessi fenomeni di ossessione, di anestesia, di ottusità, di mancanza di coordinazione mentale, con in più dei movimenti insensati di fuga e talora così poco oculati che possono condurre l’individuo a perdersi, come nei ben conosciuti casi di panico. Può d’altra parte accadere che queste due forme di emozione si succedano a breve intervallo nello stesso soggetto, come [accade] nelle forme corrispondenti della tristezza e della gioia. Può darsi infine che esse si mescolino e che la tendenza alla fuga, benché presente e forte, sia annullata dalla debolezza e dall’impotenza motoria; ma le due forme possono esistere l’una senza l’altra e il senso comune le ha distinte da tempo, poiché parla di paura che taglia le gambe e di paura che mette le ali [ai piedi]» (vol. I, p. 474).
In un suo recente articolo distingue la paura-emozione dalla paura-sentimento. Ci spiega il significato di questi termini?
Quando cerchiamo di definire la paura constatiamo che il termine copre una doppia (o plurima) realtà emozionale, per cui una prima distinzione che si impone è quella tra la paura-emozione (reazione affettiva violenta e di breve durata, denominata anche panico, spavento, sgomento, terrore) e la paura-sentimento (meno violenta e più durevole, in cui rientra ciò che chiamiamo timore, preoccupazione, angoscia, ansia, apprensione, inquietudine, fino alle sfumature della precauzione e della timidezza). Se la paura-emozione viene collocata nel quartetto affettivo ormai quasi universalmente accettato di piacere, dolore, rabbia e paura, una trattazione della paura-sentimento è ormai quasi introvabile nella manualistica della psicologia che si vuole “scientifica”.
Il linguaggio ci indica tuttavia che i numerosi termini che si riferiscono a questo stato emotivo non sono puri sinonimi, ma rimandano a realtà affettive diverse, in cui la più importante distinzione è appunto quella che ho differenziato con le espressioni paura-emozione e paura-sentimento.
La paura-emozione è dunque uno stato affettivo legato all’incertezza circa la soddisfazione dei bisogni “elementari”, mentre la paura-sentimento è legata sia alle nostre condotte relazionali sia ai bisogni specificamente umani, nel cui contesto troviamo la paura della separatezza, il bisogno di senso, il timore nei confronti del destino ultimo dell’essere umano e, di conseguenza, anche le strategie di rassicurazione di natura spirituale e religiosa.
Come abbiamo visto, il linguaggio e l’esperienza vissuta ben distinguono il livello delle reazioni emotive da quello dei sentimenti: vivaci e transitorie risposte a situazioni-stimolo, le prime; più tenui e duraturi, e legati alla struttura della personalità, i secondi, ricordando anche che si parla di “umore” quando vogliamo indicare la tonalità affettiva di fondo della personalità.
Avere paura è un segno di debolezza?
Dobbiamo intenderci: certo la paura è una emozione/sentimento connessa con la condizione di precarietà e insufficienza proprie della nostra esistenza, ma consideriamo patologica quella paura che paralizza la nostra azione e compromette il nostro equilibrio, non diversamente da quanto accade al dolore che si tramuta in depressione.
La paura può avere una valenza positiva?
Parlando sempre delle forme “sane” di paura, possiamo rispondere positivamente se sappiamo cogliere i segnali che vengono dal nostro corpo e ci indicano situazioni conflittuali, le quali, per essere superate, richiedono proprio l’utilizzazione della paura per operare coraggiose scelte.
Molte delle paure che attanagliavano i nostri avi ora non ci spaventano più. In compenso, ne sono nate altre. Ci sono quindi anche paure collettive legate alle epoche e alla cultura?
Poiché il comportamento individuale si inscrive in quello di gruppo, accanto a quelle individuali vanno sempre considerate le paure collettive, di un gruppo specifico o di tutta una società, a loro volta proprie di una determinata epoca o perduranti nel corso di secoli e di millenni. Oggi lo scenario sociale è dominato dalle grandi paure delle guerre, delle catastrofi nucleari, del terrorismo, dell’inflazione demografica, delle conseguenze dei flussi migratori incontrollati, dell’erosione dei valori e dei legami tradizionali, dei rischi legati alle nuove tecnologie, paure sul cui sfondo si generano e si esprimono le ansie e i timori personali.
Gli aspetti appresi delle paure non risultano infatti interamente comprensibili senza lo studio dei più ampi scenari in cui queste si collocano, essendo proprio essi a dare rilievo storico e culturale alle emozioni individuali. I modi in cui le persone di un dato tempo vivono, pensano, sentono, regolano i rapporti tra loro, con la natura e con l’Assoluto si rivelano dunque non meno importanti delle storie individuali. Le distanze tra storia e scienze umane sembra che stiano accorciandosi, ma siamo appena agli inizi di un cambiamento di paradigma che ci auguriamo possa portare alla fondazione di una “psicologia culturale” avente come oggetto lo studio delle “mentalità” e che sia capace di costruire delle “biografie sociali”, valide a soddisfare un bisogno che, se ha trovato una prima espressione in quanto esigenza di portare alla coscienza ciò che è nascosto nell’inconscio dell’individuo, richiede ora di far emergere ciò che è nascosto nella memoria collettiva.
Conoscere se stessi può aiutare a vincere la paura?
L'”oggetto” dello psicologo clinico è la condotta umana concreta dell’individuo impegnato a soddisfare i propri bisogni e realizzare le proprie potenzialità ossia, con una parola sola, a raggiungere la propria autorealizzazione. A questo traguardo non si arriva con facilità o per mezzo di scorciatoie, ma è necessario, per raggiungerlo in modo significativo (cioè coltivato, “adorno” di conoscenza e di affinata sensibilità), sostare nei “purgatori” della scuola, della psicologia, della medicina…, ove purgatorio non è (solo) qualcosa di negativo, ma luogo di purificazione e tappa importante (lungo una via di maturazione e di salvezza). Nessuno degli strumenti che l’esperienza

e la cultura offrono alla nostra consapevolezza va infatti trascurato, perché è nella consapevolezza che possiamo progressivamente ridurre (e forse eliminare) quell'”ignoranza” della nostra vera natura, che ci fa vivere costantemente col timore di quel che si può perdere e di quel che può accadere, attualizzando la ben nota catena di minaccia, paura, avversione e attaccamento. Al contrario, essere consapevoli è «vedere dall’interno la natura originaria e non divenire confusi», come diceva il VI patriarca dello Zen, non diversamente da Walter Benjamin, per il quale «essere felici significa essere consci di sé senza terrore; rendere coltivabili i territori su cui finora cresce solo la follia; penetrare con l’ascia affilata della ragione, senza guardare né a destra né a sinistra, per non cadere in preda dell’orrore, che attira a sé dal fondo della foresta primordiale».
Da un certo punto di vista, potremmo dire che le religioni nascono per vincere la paura.
Certamente, ma in modi differenti. Attraverso le religioni l’umanità ha cercato di gestire e vincere le angosce immediate o quelle remote e le tradizioni hanno spesso offerto una sorta di interruttore generale che consentisse di spegnerle alla radice. Di qui la raccomandazione di non pre-occuparsi, cercando di vivere come il bodhisattva, che nulla teme, o come gli uccelli dell’aria e i gigli dei campi, che si affidano alla Provvidenza.
San Francesco esortava a realizzare, di fronte a paure, disagi e umiliazioni, quella “perfetta letizia” che non è passiva sopportazione ma accoglienza attiva di tutto ciò che accade, nella consapevolezza che esso è “voluto” da una più ampia “Volontà”, in cui, di cui e per cui noi stessi viviamo.
Dobbiamo tuttavia osservare che le religioni si declinano nella storia, in un rapporto dialettico con le culture in cui vivono, dacché, come troviamo scritto in un documento dell’Unesco, «le culture danno alle religioni il loro linguaggio e le religioni offrono il significato ultimo a ciascuna cultura».
Qualcuno, come Victor Hugo, poteva affermare (nel suo testamento): «Io credo, ecco tutto. La massa ha gli occhi deboli. È affar suo. I dogmi e le pratiche sono occhiali che fanno vedere le stelle a chi ha la vista corta. Io vedo Dio a occhio nudo», ma resta il fatto che tra la sponda delle illusioni e della sofferenza e quella del nirvana e della pace le religioni si offrono come indispensabili traghetti, in un processo di progressiva purificazione che va dal ricorso a un Dio immediatamente soccorritore a un Dio salvatore, in quanto donatore di senso.
Secondo la dottrina buddhista, la realtà ultima è rappresentata dalla inesprimibile “vacuità” e, come ci ricorda Nagarjuna, «l’insegnamento del Dharma da parte dei vari Buddha è basato sulle due verità: la verità relativa del mondo e la Verità ultima. Coloro che non discernono la differenza tra queste due verità non discernono la natura profonda dell’insegnamento del Buddha. [Ma] la Verità assoluta non può essere espressa senza appoggiarsi sull’ordine pratico delle cose. Senza intendere la Verità assoluta, il Nirvana non può essere raggiunto».
Ma se le religioni offrono delle strategie di controllo e di superamento della paura, non si può non ricordare che esse (come era già stato ben compreso da molte delle scuole di saggezza del mondo classico) possono divenire a loro volta dei generatori di paure e di malessere quando, invece di indicare e facilitare il percorso lungo il cammino di liberazione, lo ingombrano con ostacoli (costituiti da dogmi, divieti, minacce) che producono intralci a volte insuperabili. Un discorso a parte richiederebbero poi le religioni come istituzioni sociali e cioè strutture gerarchizzate attraverso le quali possono venire esercitati potere, censure, manipolazioni.
Qual è il contributo particolare che può offrire il Buddismo?
Riguardo al controllo della sofferenza e della paura ritengo che sia possibile individuare quattro tipi di strategie, a volte messe in atto in alternativa a volte contemporaneamente.
Molto brevemente, la prima è quella della rimozione (oggi, ad esempio, si tende quasi sempre a dire che si muore per qualche malattia, dunque potenzialmente curabile, e mai di… mortalità). La seconda è quella attiva o attivistica (ci si adopera per risolvere il problema attraverso tutti i sistemi di protezione che sappiamo escogitare); la terza è quella illusoria (che riposa sulle utopie politiche o sull’attesa di una felicità ultraterrena); la quarta è quella dell’assunzione di responsabilità. E qui possiamo collocare il messaggio buddhista.
In esso si compie infatti una sorta di salto mortale, operando prima uno spostamento dal piano della realtà ordinaria (samsara) a quello della Realtà assoluta (infinito, sacro, mistero) e, come tale, “altra” rispetto al mondo fenomenico perché non-duale, non-effimera, priva di determinazioni e quindi identificabile come Vacuità, Nirvana, Realtà ultima; e successivamente, per così dire, un ritorno al mondo finito, in una visione unificante riassunta dalla rivoluzionaria formula mahayana: «Il Nirvana coincide col samsara».
In altri termini, i fenomeni sono visti come ierofanie (rivelazioni del sacro) in senso forte, in quanto costitutivi e non accessori di quella Realtà assoluta non-trascendente e non-separata che nei fenomeni è, vive e si realizza come Assoluta assolutezza non contrapposta dualisticamente al finito («La Vacuità è forma; la forma è Vacuità»). Il sacro, inteso come il non-ordinario o il non-profano, è pertanto visto come la grande forza della Vita inerente al cosmo: esso non è separato dal mondo (il sacro si esprime nel profano!) ed è presente, come natura-di-Buddha (o essenza), nella totalità degli esseri e nella vita stessa del praticante. Il processo di trasformazione dei desideri terreni in desiderio di illuminazione sintonizza la nostra vita individuale col ritmo del cosmo e il piccolo sé col grande Sé, sulla base dell’unità della mente umana e della Vita cosmica per cui, secondo la formula della scuola Tendai, «tremila mondi in un momento della mente; un momento della mente permea la Realtà universale».
Il Buddha e i Bodhisattva o il Gohonzon-mandala di Nichiren, in questa prospettiva, non sono idoli o immagini di divinità rassicuranti e soccorritrici, ma una sorta di mezzi di riflessione speculare: rappresentando lo stato di perfetta realizzazione essi agiscono come catalizzatori del cambiamento interiore e dell’impegno a sviluppare le parte migliori di noi stessi.
La liberazione dalla sofferenza e dalla paura si realizza dunque progressivamente non invocando un aiuto esterno ma con un processo di congiungimento e identificazione con quanto “eccede” o trascende il debole, illusorio, irredimibile io separato. La progressiva interiorizzazione della pratica religiosa trova qui il suo compimento: superata la distanza tra l’io individuale e la realtà ultima, la coscienza – resa transpersonale – diviene luogo di autoriflessione della mistica forza della vita cosmica, punto in cui l’Essere si svela, nel suo intimo, come totale e trasparente pienezza.
Perché tutti siano felici, nessuno escluso-Articolo di Yoichi Kawada
Nell’insegnamento buddista, e in particolare nel Sutra del Loto, la redenzione corrisponde alla liberazione dalla sofferenza. Si possono individuare tre livelli di redenzione: quella dell’umanità, che chiama in causa i temi della pace e dei diritti umani; la salvezza ecologica del pianeta; la redenzione spirituale, che riguarda l’etica personale del singolo essere umano
Questo articolo è stato pubblicato nel fascicolo Inter-religious Dialogues – Christians and Buddhists, vol. 31. NR XI, MMI (2001), Annals of the European Academy of Sciences and Arts
L’organizzazione laica Soka Gakkai si basa sulla dottrina buddista originata sia dalla tradizione del Budda Shakyamuni – tramandata in India attraverso Nagarjuna e Vasubandhu – sia dalla tradizione del Sutra del Loto giunta in Giappone attraverso il cinese T’ien-t’ai e il fondatore della scuola giapponese Tendai Saicho (Dengyo), per arrivare fino a Nichiren.
Lo scopo della SGI è diffondere lo spirito mahayana del Sutra del Loto nella società moderna. In questa sede affronterò principalmente il tema della redenzione nel Buddismo Mahayana e in particolare nel Sutra del Loto per definirne su tale base il ruolo nella società moderna.
Il Buddismo mahayana e l’llluminazione di Shakyamuni
La parola “mahayana”, che ha origine dal sanscrito e significa “grande veicolo”, evidenzia il mutamento di prospettiva del nuovo movimento buddista a base principalmente laica rispetto alle forme tradizionali del primo Buddismo, chiamato in senso peggiorativo “hinayana” o “piccolo veicolo”.
L’inizio del Mahayana risale a un centinaio d’anni dopo la morte del Budda storico, Shakyamuni, all’epoca del Concilio buddista del 383 a.C. Tra i seguaci del Budda era sorta una profonda divergenza che riguardava l’importanza di rimanere fedeli alle tradizioni oppure, in virtù delle mutate condizioni sociali della vita monastica, operare un rinnovamento. Un gruppo di monaci del centro mercantile di Vaishali insisteva sulla necessità di adottare regole meno severe nell’ordine per quanto riguardava – ad esempio – il cibo, le bevande e le forme di pagamento, come l’oro e l’argento. Dopo una prolungata discussione prevalse il punto di vista conservatore e la corrente che a esso si ispirava fu chiamata Theravada, che in pali significa “antica dottrina”, e i suoi credenti theravadin o “seguaci dell’antica dottrina”.
I riformatori non accettarono che le loro idee fossero respinte e tennero un concilio alternativo nel quale, affermando di costituire la maggioranza, si definirono mahasanghika o seguaci della “grande comunità”. Da allora la comunità buddista originaria rimase separata in due scuole, la Theravada e la Mahasanghika, che giunsero a sviluppare due dottrine diverse. Caratteristico della Mahasanghika è un atteggiamento liberale verso le nuove interpretazioni della dottrina.
Il Buddismo tradizionale offriva la redenzione attraverso la “conoscenza”(vidya) in contrapposizione all'”ignoranza” (avidya), strettamente legata al “ciclo dell’incarnazione” (samsara). I mahasanghika sostituirono alla conoscenza la “saggezza” (prajna), e l’antico ideale del santo redento (arhat) con quello del bodhisattva, che ritarda la propria redenzione per condurre innanzitutto le altre persone alla salvezza. Presto il nuovo ideale divenne popolare e nei secoli seguenti da queste due dottrine derivarono ulteriori scuole.
Via via che si diffondevano fra la gente, i nuovi movimenti mahayana iniziarono a crescere e a contrastare l’ortodossia theravada, che si occupava prevalentemente di questioni filosofiche e speculative riguardanti gli insegnamenti del Budda.
Questi movimenti mahayana produssero molti nuovi sutra nel periodo che va dal I sec. a.C. al III sec. d.C.
Nonostante le differenze fra le singole scuole, l’obiettivo generale del Mahayana era la redenzione universale di tutti gli esseri umani. Il Sutra del Loto o Sutra del fiore di loto della Legge meravigliosa (in sanscrito Saddharma-Pundarika-Sutra) è uno dei sutra più antichi e dunque appartiene alla prima fase del movimento mahayana.
Le nuove aspirazioni religiose che trovarono espressione e sostegno nei movimenti mahayana furono caratterizzate da diversi fattori: 1) la speranza nell’avvento di nuovi Budda e bodhisattva dotati di un maggior potere salvifico; 2) l’esortazione a prendersi cura di tutte le persone basata sulla compassione; 3) il desiderio di abolire la differenza fra monaci e credenti laici.
In questo contesto si può riconoscere il tema centrale del Sutra del Loto, costituito dall’esperienza dell’Illuminazione di Shakyamuni e da come i seguaci del suo insegnamento possano a loro volta comprenderla.
Nel capitolo introduttivo del Sutra del Loto si afferma ad esempio: «A beneficio di chi cercava di diventare un ascoltatore della voce, rispondeva esponendo la Legge delle quattro nobili verità, così che potesse trascendere nascita, vecchiaia, malattia e morte e ottenere il nirvana. A beneficio di chi cercava di diventare pratyekabuddha rispondeva esponendo la Legge della dodecupla catena di causalità. A beneficio dei bodhisattva rispondeva esponendo le sei paramita, facendo loro ottenere l’anuttara-samyak-sambodhi [suprema e perfetta Illuminazione] e acquisire la saggezza omnicomprensiva» (Il Sutra del Loto, Esperia, p. 16).
Affermazioni simili si trovano anche in altri capitoli come il terzo o il ventesimo. Secondo il Sutra del Loto lo scopo dell’insegnamento e della pratica buddista è l’ottenimento della perfetta Illuminazione; ciò sottintende un atteggiamento critico nei confronti della dottrina esistente che permette solo il conseguimento “degli stadi preliminari dell’Illuminazione”. Questa è la prospettiva secondo la quale il Sutra del Loto affronta il tema della perfetta redenzione.
La redenzione nel Buddismo mahayana
Nel terzo capitolo del Sutra del Loto le illusioni vissute dagli esseri umani sono paragonate a una casa che brucia, mentre la redenzione all’affrancamento da esse. «Egli è nato nel triplice mondo, una casa in fiamme, un vecchio edificio in rovina, per salvare gli esseri viventi dall’incendio della nascita, della vecchiaia, della malattia e della morte, dalle ansie, dalla sofferenza, dalla stupidità, dall’incomprensione e dai tre veleni» (ibidem, p. 76).
Il termine triplice mondo indica il nostro mondo, costituito dai tre regni del desiderio, della forma e della non forma, nel quale tutte le persone sono soggette a un gran numero di tormenti che possono essere attribuiti alle quattro sofferenze fondamentali di nascita, vecchiaia, malattia e morte. La casa che brucia rappresenta la condizione esistenziale di sofferenza e le fiamme simboleggiano la passione, intesa nel senso buddista di “attaccamento alla vita” o al “transitorio”. Lo scopo principale dell’insegnamento buddista è liberare le persone dalla sofferenza, ossia condurle al Nirvana. Il Sutra del Loto affronta questo tema centrale del Buddismo considerando la redenzione come liberazione delle persone dalla sofferenza. Possiamo parlare a tale proposito di livelli di redenzione. Il primo è la redenzione dell’umanità, che riguarda il tema della pace e dei diritti umani. Il secondo è la salvezza ecologica del pianeta.
Il terzo livello è la redenzione spirituale in cui si affronta il problema di un’etica della vita e di questioni come la vita e la morte dell’individuo.
Il primo livello, la redenzione dell’umanità, riguarda la dignità della vita umana, che nella tradizione mahayana si estrinseca con l’idea di una natura di Budda che esiste in ogni essere vivente. La natura di Budda, chiamata anche Buddità, è la capacità di diventare un Budda o, come di solito si dice, di “conseguire la Buddità”. Poiché tutti posseggono la natura di Budda, ogni essere umano è considerato egualmente degno di rispetto e in grado di raggiungere la perfetta Illuminazione. La dottrina secondo la quale la Buddità è immanente in tutti gli esseri viventi ha origine dalla tradizione del Thatagata-Garbha o “seme del Budda”, che equivale alla Buddità. Nel Sutra del Nirvana l’insegnamento diventa ancor più universale affermando che tutti gli esseri viventi sono dotati della Buddità: «Io ho predicato la dottrina del sutra di Thatagata-Garbha, che sebbene tutti gli esseri viventi siano dotati della Buddità, essi possono farne esperienza solo attraverso l’approccio alla dottrina buddista, mediante la quale è possibile conseguire la perfetta Illuminazione». Nel Sutra del Loto, che fu scritto prima di questi sutra, la possibilità di raggiungere la Buddità viene spiegata attraverso la relazione del singolo essere umano con il Budda Shakyamuni. Ad esempio, nel secondo capitolo, si spiega perché il Budda appare in questo mondo: «I Budda, gli Onorati dal mondo, appaiono nel mondo per un’unica grande ragione» (ibidem, 38-39).
L’intento principale è “aprire” la saggezza del Budda a tutte le persone, per permettere loro di comprenderla e avere accesso ad essa; così anche alle donne e ai criminali – che prima del Sutra del Loto erano considerati inadeguati – viene garantita la possibilità di manifestare la Buddità e ne viene parimenti riconosciuta la dignità universale della vita. Per questa ragione il Sutra del Loto può essere inteso come una dichiarazione della dignità e dell’eguaglianza di tutti gli esseri umani senza eccezione alcuna.
Dal punto di vista moderno il Sutra del Loto dichiara che tutti gli esseri umani, indipendentemente dalle differenze di razza, nazionalità, cultura, religione e sesso, sono dotati della Buddità, la potenzialità suprema per la felicità, e sono in egual modo capaci di manifestarla. In ciò risiede la ragione del pacifismo buddista che si oppone a ogni forma di guerra e di uccisione degli esseri umani. Questa dichiarazione costituisce a nostro avviso una base per l’affermazione dei diritti umani fondamentali.
Per quanto riguarda il secondo livello di redenzione, la salvezza ecologica della Terra, vi è un principio, appartenente alla tradizione sino-giapponese, che riveste un particolare significato: si tratta della possibilità dell’ottenimento della Buddità anche da parte delle piante, oltre che degli animali e degli esseri umani. Nella tradizione indiana la possibilità di ottenere l’Illuminazione era propria soltanto degli esseri viventi dotati di facoltà cognitive e dunque le piante erano escluse. Ma il filosofo cinese Chi-tsand (549-623) evidenziò che anche le piante possedevano la Buddità poiché erano, come tutti gli altri esseri viventi, «indissolubilmente legate al loro ambiente». Anche Chih-i (538-597) della scuola cinese T’ien-t’ai riteneva che «ciascun colore e profumo incontra la via di mezzo» e parimenti insisteva che c’era la possibilità che le piante possedessero la capacità di manifestare la Buddità. Questo concetto si diffuse in Giappone e divenne un tema importante nella scuola Tendai giapponese. Anche Nichiren (1222-1282), innovatore della scuola Tendai nel XIII secolo, sosteneva che l’idea di “ottenimento della Buddità da parte di tutti gli esseri viventi” dovesse comprendere questa possibilità anche per le piante.
Ciò che conta probabilmente non è tanto che le piante posseggano o meno la Buddità e la possano manifestare, quanto comprendere che umanità e natura sono inseparabili. Se le persone manifestano la Buddità e diventano felici e illuminate, il loro ambiente sarà in grado di esprimere le sue massime potenzialità. Quest’idea della natura e del mondo presuppone che l’individuo viva in armonia con il suo ambiente naturale e quindi debba proteggere la Terra dal punto di vista ecologico.
Il terzo livello in cui vorrei considerare l’argomento fondamentale del Buddismo, la liberazione dalla sofferenza, riguarda le implicazioni spirituali della redenzione nel Buddismo mahayana. Etimologicamente la parola Nirvana deriva da un termine che significa “estinguere”. Il Nirvana è dunque una condizione in cui tutti i desideri, intesi come causa di sofferenza, sono stati estinti. In tale stato si è liberi dalla catena causale che conduce alla rinascita e a ulteriori sofferenze. L’ideale della tradizione theravada è creare le condizioni per non dover nuovamente rinascere in questo mondo.
Ma il primo Buddismo era caratterizzato da due tipi di Nirvana. Il “Nirvana con un limite residuo” (Sopadhishesha Nirvana) poteva essere raggiunto anche prima della morte in quanto consisteva nella libertà da ogni desiderio pur conservando la forma fisica. Per contro il Nirvana senza limitazioni (Nirupadhshesha Nirvana) indica uno stato che si può raggiungere soltanto dopo la morte e implica una perfetta liberazione dai legami mondani, inclusa l’estinzione del desiderio e della forma fisica.
Nel Buddismo mahayana, che poneva l’accento sull’ideale del bodhisattva, l’idea di Nirvana subisce un mutamento sostanziale e diventa una condizione in cui “l’illuminato non rimane nel ciclo di nascita e morte a causa della sua grande saggezza, ma nemmeno entra nel Nirvana a causa della sua grande compassione per gli altri esseri viventi”. Così il ciclo delle rinascite non si riferisce più a una vita piena di afflizioni che deve essere distrutta, ma al contrario la liberazione dalla sofferenza avviene all’interno di tale ciclo nel quale ci si impegna ad agire come bodhisattva animati dalla saggezza e dalla compassione per gli altri. Perciò il Sutra del Loto menziona il voto del bodhisattva: «Queste persone sono grandi bodhisattva che hanno conseguito l’anuttara-samyak-sambodhi. Mossi da compassione per gli esseri viventi, essi hanno fatto voto di nascere laddove possono propagare ampiamente, facendo distinzioni, il Sutra del Loto della Legge meravigliosa» (ibidem, p. 208).
Nel Buddismo la compassione è sinonimo di misericordia e consiste in un atteggiamento spirituale ed emozionale. Il bodhisattva si sforza di immedesimarsi nella condizione delle altre persone e di comprenderne le sofferenze e le gioie come se appartenessero alla sua stessa vita. Così è sempre disponibile nei confronti degli altri e, pieno di profonda preoccupazione per le loro sofferenze, decide di rinascere in questo mondo. Inoltre: «Queste persone hanno rinunciato volontariamente alla ricompensa che hanno meritato per le loro azioni pure e, nell’epoca successiva alla mia estinzione, mosse da compassione per gli esseri viventi, sono nate in questo mondo malvagio per poter propagare ampiamente questo sutra» (ibidem, pp. 208-209).
Questi brani spiegano che coloro che praticano il Sutra del Loto hanno già raggiunto la suprema e perfetta Illuminazione e nonostante ciò, o meglio proprio a causa di ciò, spinti dall’amore e dalla compassione per coloro che soffrono, hanno rinunciato al loro karma immacolato per poter svolgere la propria missione. I bodhisattva mahayana appaiono nel mondo della sofferenza spinti unicamente da questo desiderio interiore, da questo voto, e da ciò si evince che i credenti mahayana aspirano a divenire persone che nel profondo del cuore prendono seriamente il proprio compito di bodhisattva e si impegnano attivamente per svolgerlo.
Oggi ci troviamo ad affrontare problemi morali assai difficili che riguardano il significato e i confini stessi della vita e della morte, questioni sollevate in maniera diretta dal tema delle manipolazioni genetiche. In quest’ambito l’atteggiamento del bodhisattva che ho appena descritto costituisce una base filosofica per dare risposte ragionevoli. Il Buddismo mahayana trasforma un’idea pessimista della vita, che è solo piena di sofferenza e deve essere estinta, in un atteggiamento positivo verso l’esistenza, che richiede a ognuno di agire sulla base del voto interiore del bodhisattva.
La via del bodhisattva e la società moderna
I quattro voti del bodhisattva, caratteristici della tradizione mahayana, sono:
1) per quanto numerosi siano gli esseri viventi, io faccio voto di salvarli tutti;
2) per quanto i desideri siano inesauribili io faccio voto di estinguerli tutti;
3) per quanto immenso sia il Dharma, io faccio voto di acquisirlo tutto;
4) per quanto incommensurabile sia la verità del Budda, io faccio voto di comprenderla.
Il primo voto riguarda sia il desiderio della salvezza di tutte le persone che la conservazione ecologica della Terra. Poiché vi sono innumerevoli esseri viventi, a ciascun individuo viene chiesto di fare il massimo per la loro salvezza. Così un bodhisattva non può rimanere nel Nirvana (in quanto “estinzione”, come veniva inteso dal primo Buddismo), ma riappare sempre in questo mondo pieno di dolore, mosso dal potere della compassione di liberare tutti gli esseri dalla sofferenza.
Il secondo voto sfida il bodhisattva a vincere il suo inesauribile desiderio. Qui non si parla di estinzione del desiderio ma della sua trasformazione qualitativa. In termini concreti significa usare i desideri e le passioni come trampolino per lo sviluppo personale. Questa trasformazione, causata dal fatto che la Buddità richiede di essere attivata dalla pratica, viene espressa da due principi: la trasformazione dei desideri in Illuminazione e la trasformazione delle sofferenze di nascita e morte in Nirvana. Così facendo il bodhisattva approfondisce e rafforza le proprie capacità di compassione, saggezza, perseveranza e fede.
Il terzo voto in termini moderni consiste nell’impresa di conoscere approfonditamente tutto il patrimonio spirituale dell’umanità. Per condurre gli altri alla redenzione non si dovrebbero studiare soltanto gli insegnamenti buddisti ma anche le dottrine delle altre religioni, culture e scienze. Solo grazie a tali sforzi incessanti il Buddismo può evitare la paralisi del formalismo e la perdita della capacità concreta di affrontare i veri problemi della propria epoca.
Dal desiderio di redenzione di tutta l’umanità, che è reso possibile affrontando i desideri e acquisendo una serie di conoscenze fondamentali, emerge la quarta sfida del bodhisattva: risvegliare la saggezza del Budda. Questo quarto voto indica il riconoscimento della suprema verità che può essere conseguita percorrendo la via del bodhisattva.
A questo punto vorrei ricordare le qualità morali e spirituali di un grande uomo del nostro tempo: il Mahatma Gandhi, che sembra esemplificare esattamente questo spirito del Budda, liberando persino Shakyamuni dalla cornice dogmatica del Buddismo. Sarei addirittura propenso a considerarlo il vero successore del Budda.
Secondo la dottrina del Sutra del Loto, il Budda eterno appare sempre come un bodhisattva. Il corso della vita di Gandhi è simile alla pratica inesauribile del Bodhisattva Mai Sprezzante (Sadaparibhuta) nel capitolo ventesimo del Sutra del Loto. Questo bodhisattva, considerato una delle molte manifestazioni precedenti di Shakyamuni, salutava ogni persona che incontrava con queste parole di riverenza: «Nutro per voi un profondo rispetto; non oserei mai trattarvi con disprezzo o arroganza. Perché? Perché voi tutti state praticando la via del bodhisattva e conseguirete certamente la Buddità» (ibidem, p. 355).
Questo bodhisattva praticava esattamente il messaggio fondamentale del Sutra del Loto: l’affermazione che la Buddità è intrinseca in tutte le persone e che perciò nel futuro tutte avrebbero percorso la via del bodhisattva e manifestato la propria Buddità. Questo è ciò che avevano in comune Shakyamuni e Gandhi: l’attribuzione della sacralità e della dignità della vita a ognuno e il riconoscimento che questa dignità debba e possa manifestarsi concretamente. Si dice che Gandhi definisse gli Intoccabili come figli di Dio e che li trattasse come bramini.
Il secondo elemento che entrambi hanno in comune è ahimsa, la nonviolenza, cioè la rinuncia all’uso di ogni forma di violenza. Il Bodhisattva Mai Sprezzante fu insultato e persino colpito con pietre e bastoni da molte persone, eppure continuava la sua pratica di riverenza. Questo è lo stesso atteggiamento con cui Gandhi propagò il suo movimento di resistenza nonviolenta. Per Gandhi il mezzo – la nonviolenza – e il fine – comprendere la verità (satyagraha) – erano inseparabili, così come per il Bodhisattva Mai Sprezzante erano inseparabili la pratica di riverire ogni singola persona che incontrava e la sua dedizione al Dharma buddista. Entrambi rifiutavano l’uso di qualsiasi tipo di violenza in nome di un sacro scopo, incoraggiando ogni persona a schierarsi con coraggio a favore della nonviolenza.
In terzo luogo, sia il voto di Shakyamuni che il desiderio di Gandhi riguardavano la redenzione di tutti gli esseri. Del Bodhisattva Mai Sprezzante si dice che sul letto di morte udì un paragrafo del Sutra del Loto e fu in grado di prolungare la durata della sua vita per continuare a predicare il Dharma buddista agli altri. Fino all’ultimo momento la sua esistenza fu dedicata all’adempimento del suo voto di condurre tutte le persone alla redenzione. Gandhi considerava la sua battaglia per la liberazione dell’India una battaglia per tutta l’umanità. L’India, senza fare ricorso ad alcun tipo di violenza, lottò per la propria liberazione contro la Gran Bretagna che a quell’epoca aveva a sua disposizione la maggiore potenza militare del mondo. Fu un esempio per tutta l’umanità futura della possibilità di intraprendere e vincere una battaglia nonviolenta contro qualsiasi potenza militare, anche se in possesso di armi nucleari. Gandhi non si preoccupava soltanto dell’indipendenza del suo popolo, ma anche del benessere di tutta l’umanità.
Nell’ulteriore sviluppo del Buddismo mahayana lo spirito di Shakyamuni, rappresentato nel Sutra del Loto dalla figura del Bodhisattva Mai Sprezzante, si perpetua nei quattro voti del bodhisattva. Nichiren, seguendo la tradizione del Sutra del Loto di T’ien-t’ai e Dengyo, cercò di comprendere la dottrina del Sutra del Loto attraverso l’esperienza concreta e si identificò anche con il Bodhisattva Mai Sprezzante. In sintonia con gli elementi citati, che accomunano il Bodhisattva Mai Sprezzante e Gandhi, vorrei citare alcune frasi di Nichiren. A proposito dell’intrinseca dignità della vita umana indipendente da qualsiasi differenza egli afferma: «Un’unica persona può essere considerata esemplare dell’uguaglianza di tutte le persone» (Gosho Zenshu, p. 568).
Con “un’unica persona” egli si riferisce al Budda Shakyamuni, intendendo che tutti gli esseri umani possono manifestare la propria Buddità immanente e in tal senso sono uguali a lui e parimenti degni di onore. Riguardo alla compassione e alla rinuncia all’uso di qualsiasi forma di violenza Nichiren scrive: «Per quanto riguarda la comprensione del Sutra del Loto, io ho solo una minima parte delle grandi capacità possedute da T’ien-t’ai e Dengyo, ma per la mia capacità di sopportare le persecuzioni e per la mia grande compassione, credo che li farei vergognare» (L’apertura degli occhi, Gli scritti di Nichiren Daishonin, vol. 1, pp. 113-114).
Per via dei suoi insegnamenti rivoluzionari, in nome dei quali si contrappose anche alle religioni istituzionali e al potere politico, Nichiren subì gravi persecuzioni, fra cui aggressioni violente e l’esilio. Ma egli le affrontò mantenendo lo spirito buddista della compassione e continuando a rinunciare alla violenza. Il suo voto di contribuire alla redenzione di tutta l’umanità appare chiaro nel seguente brano: «Il Sutra del Nirvana afferma: “Tutti i tipi di sofferenze che le persone sperimentano in vari modi, comprese le mie, sono i dolori del Budda. E comunque tutti i dolori dell’umanità sono i dolori di Nichiren”» (Rimostranza al Bodhisattva Hachiman, Gosho Zenshu, p. 587).
Si sta riferendo allo stesso voto che fu altrettanto fondamentale per Shakyamuni: la liberazione di tutta l’umanità dalla sofferenza.
Dalla sua fondazione, la Soka Gakkai ha sempre cercato di tradurre concretamente in azione lo spirito fondamentale del Buddismo mahayana nella società moderna. Nel corso dei millenni, a partire da Shakyamuni, attraverso T’ien-t’ai fino a Nichiren, i contenuti di quelli che in precedenza ho definito come i tre livelli della redenzione hanno subito notevoli cambiamenti. Oggi siamo di fronte al compito di ridefinire completamente il ruolo del Buddismo.
Nel mondo attuale assistiamo a un processo di globalizzazione che ci richiede di considerare la Terra come un’unica entità. Le relazioni economiche, politiche e culturali sono così strettamente e profondamente interconnesse che la preoccupazione non riguarda più la sopravvivenza di singole nazioni o gruppi etnici ma dell’umanità nel suo insieme. Le numerose questioni – di varia natura e di vasta portata – come quelle degli armamenti atomici o dei diritti umani, ci impongono di accettare la grande diversità delle nazioni, delle culture e delle religioni e di trovare la via per una società umana armoniosa e pacifica, adesso e nel futuro. Per citare un altro tema: il sistema ecologico della terra è sull’orlo del collasso su scala globale e questa è una sfida completamente nuova per tutte le religioni. Inoltre siamo di fronte a problemi totalmente sconosciuti che emergono dagli sviluppi più recenti nelle bio e neuro tecnologie e nell’ingegneria genetica che presentano a loro volta un nuovo insieme di quesiti da risolvere per la religione. Non solo il Buddismo, ma tutte le religioni tradizionali sono davanti al problema di come affrontare questo nuovo compito. Mi sembra che, nell’attuale situazione mondiale, quella che viene chiamata in causa è la stessa ragion d’essere della religione.
Spero che queste considerazioni sulla visione buddista della redenzione possano servire da stimolo per ulteriori discussioni e contribuire all’approfondimento della comprensione reciproca.
Buddismo e Società n.106 – settembre ottobre 2004
Il Buddismo di Nichiren e l'empowerment-Articolo di Yoichi Kawada
Il processo di empowerment buddista è l’acquisizione della saggezza del Budda, contenuta nella nona coscienza, ossia la comprensione dell’interrelazione e dell’interdipendenza di tutti i fenomeni. Questa “illuminazione” opera una trasformazione di tutti gli altri livelli di coscienza dell’individuo e porta ad agire in maniera compassionevole nei confronti degli altri.
Questo testo è stato presentato il 26 agosto 1999 nel corso dell’American Psychological Association Convention di Boston, USA ed è stato pubblicato sulla rivista Living Buddhism del settembre 2001.
Nichiren, vissuto nel XIII secolo in Giappone, è il maestro buddista ai cui insegnamenti si ispirano le attività della Soka Gakkai Internazionale. In questo articolo vorrei esplorare le aree di contatto fra il Buddismo di Nichiren e il concetto di empowerment.
Nichiren aveva una profonda conoscenza della storia intellettuale del Buddismo. Tale comprensione derivava dallo studio dei sutra che raccolgono gli insegnamenti di Shakyamuni e attingeva alle teorie e alle esegesi degli studiosi indiani Nagarjuna (fra il II e il III secolo d.C.) e Vasubandhu (V secolo d.C.), alla scuola cinese del Buddismo di T’ien-t’ai e a quella del giapponese Saicho (VIII secolo d.C.). Quindi, nel trattare l’empowerment, inizierò dall’esplorare i punti di contatto fra la psicologia occidentale moderna e la teoria delle “otto coscienze” elaborata da Nagarjuna e Vasubandhu, e poi ripresa e sviluppata da T’ien-t’ai e da Nichiren.
È stato lo storico Arnold Toynbee ad asserire che le due grandi scoperte del secolo scorso sono state la teoria della relatività nel campo della fisica e la scoperta dell’inconscio nel campo della psicologia. Egli ha inoltre sottolineato che la scoperta dell’inconscio ci rivela che ogni individuo racchiude in sé di fatto un cosmo, un universo.
Il merito della scoperta dell’inconscio nella psicologia occidentale va a Freud, i cui lavori sono stati seguiti da quelli di Adler, Jung, Maslow e altri, che hanno notevolmente ampliato il nostro campo di esplorazione della psiche.
Circa 2.500 anni fa in oriente, Shakyamuni – meglio conosciuto come il Budda – adattò creativamente e rimaneggiò l’antica filosofia delle Upanishad sviluppando una sua filosofia.
Il suo risveglio, avvenuto mentre si trovava in meditazione sotto l’albero di bodhi, può essere considerato un evento originario, un momento critico, nella psicologia orientale. Questo risveglio ebbe inizio con la percezione del proprio inconscio e si estese fino a illuminare il vasto cosmo della psiche.
Tale esplorazione del suo mondo interiore, del cosmo interiore, andò oltre il livello individuale e, approfondendosi, arrivò a includere tutto il genere umano. Egli continuò a esplorare le frontiere dell’individualità, dall’essenza comune a tutti gli esseri viventi fino a quelle zone profonde dove il sé si fonde con la Terra, col sistema solare e con l’universo intero. Alla fine si risvegliò alla saggezza fondamentale della vita, la vita dell’universo stesso, che dà origine a tutti i fenomeni che si evolvono in armoniosa unità con il cosmo psichico.
In seguito i praticanti buddisti avrebbero chiamato “natura di Budda” la forza vitale alla quale Shakyamuni si era risvegliato. Avrebbero esplorato i mezzi e le diverse pratiche attraverso le quali tutte le persone possono manifestare l’immensa energia, dignità e saggezza di questo stato vitale: in altre parole, metodi di self-empowerment.
I tre livelli della coscienza
Vorrei qui delineare brevemente il principio delle otto coscienze, che rappresenta un’importante base della psicologia buddista.
La parola che viene tradotta con “coscienza” deriva dal sanscrito vijñana, e sta a indicare una vasta gamma di attività che include la sensazione, la cognizione, il sentimento e il pensiero cosciente. Vijñana può essere pensato in riferimento all’intero cosmo della psiche.
Secondo gli insegnamenti della scuola Yogacara, vijñana comprende tre livelli: 1) i cinque sensi e la coscienza vigile; 2) la coscienza mano; 3) la coscienza alaya, considerata il nucleo centrale o luogo principale delle attività psichiche. In altre parole, il contenuto del livello di coscienza alaya si rende evidente, e quindi manifesto, nelle attività del livello della coscienza mano, così come nei cinque organi di senso e nella coscienza vigile. A loro volta, le attività dei livelli più superficiali vengono registrate profondamente nella coscienza alaya. Esiste dunque un’interazione costante e intima fra i diversi livelli di coscienza.
È importante chiarire, a questo punto, che la coscienza alaya non dovrebbe essere intesa soltanto in senso ontologico, semplicemente in quanto esistente, ma anche come qualcosa che racchiude una dimensione cognitiva e persino etica.
I livelli di coscienza mano e alaya hanno molti punti in comune con il concetto di inconscio individuale e collettivo della psicologia junghiana.
Prendiamo innanzitutto in considerazione la coscienza mano, che da un lato emerge dalla coscienza alaya e dall’altro focalizza su di essa la sua “attenzione”.
In questo senso, il livello di coscienza mano può essere considerato come la sede della più basilare coscienza del sé. Il verbo sanscrito da cui deriva è manas, che significa “pensare” o “considerare”. Dunque la coscienza mano riguarda sempre il pensiero, la riflessione, potremmo dire l’oggettivazione della coscienza alaya dell’individuo, che viene percepita come qualcosa di unico e di isolato dal resto. È per via di questo forte attaccamento o adesione a una coscienza alaya oggettivata che la coscienza mano genera un senso del sé limitato e isolato, che nel Buddismo si definisce “piccolo io”.
Quando la coscienza mano funziona in questa maniera genera una serie di potenti illusioni che si manifestano negli altri, più immediati, livelli di percezione e di coscienza, sotto forma di attaccamento e di orgoglio nei confronti del proprio senso di sé separato. L’illusione che la coscienza alaya oggettivata sia il proprio vero io si identifica con l’oscurità fondamentale, l’allontanamento dalla verità della interrelazione tra tutti gli esseri. Ed è proprio il senso di isolamento e di separazione del proprio io dagli altri che genera le discriminazioni, l’arroganza distruttiva e l’egoismo.
Il piccolo io è profondamente insicuro, e oscilla fra un senso di superiorità e un senso di inferiorità nei confronti degli altri; cercando di raggiungere il proprio appagamento nuoce o ferisce inconsapevolmente gli altri. Quando la coscienza mano è piena di illusioni riguardo la natura dell’io si genera un’ulteriore serie di illusioni, che l’antico Buddismo si adoperò a definire, numerare e classificare, ma sulle quali sorvoleremo per motivi di tempo. Ci limiteremo a dire che la coscienza mano opera per creare un forte senso di separazione fra sé e le altre persone, generando tendenze discriminatorie verso coloro che vengono percepiti come “gli altri”.
Le caratteristiche della coscienza alaya
Nel Trimisika-vijnapti Vasubandhu attribuisce le seguenti caratteristiche alla coscienza alaya. Innanzitutto, non è oscurata dalle illusioni ed è moralmente neutra, ovvero, è ugualmente predisposta a ricevere l’impronta karmica di cause sia negative che positive. In secondo luogo, è estremamente dinamica: il suo fluire può essere paragonato a quello di un fiume in piena. In sanscrito la parola alaya significa “immagazzinare”, ed è qui che le cause latenti, spesso descritte metaforicamente come semi karmici, si depositano.
Il karma è, naturalmente, un concetto basilare del Buddismo. Secondo questo concetto i nostri pensieri, parole e azioni (siano essi appartenenti alla parte conscia o inconscia del livello mano) esercitano invariabilmente un’influenza che viene impressa o registrata nel livello più profondo della nostra vita: la coscienza alaya. Quando incontrano le condizioni per potersi esprimere, queste cause latenti, o semi karmici, divengono manifeste come funzioni della coscienza mano o altri livelli di coscienza più superficiali.
Tali semi karmici possono essere positivi o negativi. Le cause latenti positive si manifestano in funzioni psicologiche positive come fiducia, nonviolenza, autocontrollo, compassione e saggezza. Le cause latenti negative si manifestano sotto varie forme di illusioni e di comportamenti distruttivi. In questo senso il funzionamento della coscienza alaya deve intendersi precedente rispetto a quello delle illusioni, poiché non viene macchiato o influenzato da queste. Resta neutro e ugualmente ricettivo a ogni altro tipo di impronta karmica.
Come già menzionato, la coscienza alaya interagisce costantemente e intimamente con altri livelli di coscienza, come la coscienza mano, la coscienza vigile e le funzioni sensoriali. Non è una realtà o un’entità separata: sarebbe più corretto considerarla come una corrente vitale che fluisce ininterrottamente. È questa mancanza di staticità, questa fluidità, che consente di trasformare il suo contenuto, e di conseguenza il funzionamento degli altri livelli di coscienza.
La trasformazione della coscienza e l’ottenimento della saggezza
L’idea di trasformare la coscienza e di ottenere la saggezza è centrale nella psicologia buddista e forse rappresenta il contributo più diretto del Buddismo al concetto di self-empowerment.
Gli otto livelli di coscienza citati sopra vennero descritti dalla scuola indiana Yogacara. Furono poi le scuole T’ien-t’ai e Hua-yen (Kegon) in Cina a scoprire una nona coscienza, la coscienza amala, incontaminata, che supporta e abbraccia tutte le funzioni della coscienza alaya sottostante.
Riprendendo quelle spiegazioni delle nove coscienze, Nichiren descrive diversi tipi di saggezza che si manifestano a ogni livello di coscienza. La coscienza amala manifesta la saggezza di comprendere che siamo tutt’uno con l’energia vitale cosmica. Questa è la saggezza fondamentale dell’universo vivente, manifestando la quale diventiamo capaci di trasformare il funzionamento degli altri livelli di coscienza, inclusa la coscienza alaya, dove risiedono le cause karmiche profonde. Tale trasformazione è l’obiettivo della psicologia buddista e della pratica buddista, che include la ricerca dell’altruistica via del bodhisattva.
La pratica buddista imprime i semi di cause positive nella coscienza alaya. Maggiori e più forti sono tali cause, maggiore sarà la trasformazione del contenuto della coscienza alaya. Quando la coscienza alaya viene trasformata, brilla della luce di una saggezza che può essere paragonata a un grande specchio che riflette perfettamente il vero aspetto di tutti i fenomeni. Questa è la saggezza dell’interdipendenza, la saggezza di percepire e di comprendere che, al livello più profondo, siamo tutti interrelati e interdipendenti.
Quando la coscienza alaya viene trasformata in questa maniera, fa sorgere nella coscienza mano la saggezza di percepire tutte le cose nella giusta misura. In altre parole, la coscienza manonon funziona più come il luogo di una coscienza fondamentalmente discriminatoria, ma è in grado di percepire la sua “propria” coscienza alaya come anch’essa parte di una energia vitale cosmica che si evolve creativamente. A quel punto la coscienza mano cessa di generare l’immagine di un “io” falsamente separato e in profondo conflitto ontologico con gli altri.
Il superamento della tendenza, profondamente radicata, di oggettivare e di aggrapparsi alla coscienza alaya consente all’individuo di superare i sentimenti di paura e di angoscia riguardo alla morte fisica. Questi vengono sostituiti dalla profonda consapevolezza che la coscienza alaya è un flusso vitale che si manifesta ripetutamente in cicli di vita e di morte, flusso allo stesso tempo sorretto e contenuto dalla vitalità fondamentale e dalla saggezza inerenti all’universo, ovvero dalla nona coscienza o coscienza amala. La morte viene così vista come il ciclico decadimento dell’abilità di sostenere il buon funzionamento della coscienza mano, della coscienza vigile e degli organi di senso. Alla morte dell’individuo queste funzioni diventano latenti all’interno della coscienza alaya, la quale però non si estingue, ma mantiene la continuità del flusso vitale durante il corso dei cicli di vita e di morte.
Quando si superano le profonde illusioni che riguardano la natura dell’io e della sua esistenza, la coscienza mano può funzionare come deposito di cause positive come la fiducia, l’autocontrollo e la compassione.
La trasformazione degli strati più profondi della coscienza influisce sul funzionamento della cognizione e della percezione, localizzate nella coscienza vigile e nell’apparato sensoriale. Queste vengono permeate da una propria forma di saggezza, che comprende la saggezza di controllare liberamente le funzioni dei sensi e di agire nella maniera più efficace per avanzare nella propria vita e sostenere gli altri nella stessa impresa.
Una persona che lotta costantemente per ottenere questo tipo di trasformazione profonda di tutti i livelli di coscienza, e che cerca di aiutare gli altri a fare lo stesso, è chiamata bodhisattva.
Il movimento della SGI e la via del bodhisattva
Nel Buddismo di Nichiren, la pratica fondamentale consiste nella recitazione del mantra Nam-myoho-renge-kyo davanti al mandala iscritto da Nichiren con lo scopo di consentire a tutte le persone di manifestare la saggezza profonda della nona coscienza o coscienza amala. In questa maniera cerchiamo di trasformare la coscienza e ottenere la saggezza, cerchiamo di risvegliare la natura di Budda che è una cosa sola con l’energia vitale dell’universo e di consolidare un io da bodhisattva.
Nichiren identifica le quattro virtù del bodhisattva con il vero io, l’eternità, la purezza e la gioia.
La virtù del vero io potrebbe essere intesa come l’esperienza di una libertà in espansione e di speranza, derivanti dal senso di unione con l’energia vitale dell’universo. L’eternità indica la creatività inerente alla vita dell’universo, che porta a un costante rinnovamento e rivitalizzazione: è la capacità di superare ogni ostacolo. La purezza è la funzione della vita cosmica di pulire l’egoismo restrittivo che sporca e distorce l’io. Infine, la gioia è la qualità dell’auto-realizzazione, uno stato vitale di estrema fiducia e serenità basate sull’identificazione di sé con la vita universale.
Nichiren asserisce che il vero bodhisattva manifesta l’intera gamma di queste quattro virtù. Sono queste virtù che rendono il bodhisattva capace di trasformare le circostanze negative in occasioni di crescita e di creazione di valore. È per questa ragione che il bodhisattva non cerca di evitare le difficoltà e le sfide della vita, e non si tira indietro di fronte a esse, ma preferisce piuttosto viverle, conoscerle e affrontarle a testa alta.
Secondo Nichiren, il beneficio che deriva dalla recitazione di Nam-myoho-renge-kyo è la trasformazione delle inevitabili sofferenze della vita – quelle che il Buddismo chiama “le quattro sofferenze” di nascita, vecchiaia, malattia e morte – nelle quattro virtù di vero io, eternità, purezza e gioia. Il bodhisattva, trasformando queste esperienze, così spesso causa di grandi sofferenze, nell’opportunità di svilupparsi e di avanzare, ispira gli altri a seguire lo stesso sentiero che porta a “trasformare la coscienza e ottenere saggezza”.
Attraverso un coinvolgimento attivo a favore degli altri possiamo continuamente rafforzare e approfondire questo io da bodhisattva, in uno sforzo che non è limitato al raggiungimento della felicità personale, ma che comporta un impegno profondo di realizzare la pace, sia per l’umanità che per l’intera biosfera.
L’attività della Soka Gakkai Internazionale per la realizzazione di un movimento contemporaneo della via del bodhisattva si basa sugli sforzi di singoli individui di trasformare il proprio cosmo psichico interiore. Manifestando saggezza in tutti i livelli di coscienza e incoraggiando lo sviluppo di tale saggezza nella propria famiglia, nella propria comunità e nella società, cerchiamo di superare le illusioni che danno origine a una tristemente nota serie di mali personali e sociali: dal senso di incapacità di agire che affligge così tante persone, ai conflitti all’interno della società e fra le diverse società, sino alla distruzione dell’ecosistema. Anche se il sentiero del bodhisattva potrebbe apparire come un approccio troppo graduale, noi siamo fiduciosi del fatto che in realtà rappresenti una trasformazione fondamentale, che ha il potere di cambiare al meglio la vita sia degli individui che di tutta l’umanità. per cui i Budda si avvalgono del potere degli espedienti”» (Op. cit., pp. 79-80).
Buddismo e Società n.99 – luglio agosto 2003
Nichiren Daishonin e il suo tempo-Intervista a Silvio Vita
 Docente di religioni e filosofie dell’Asia orientale all’Istituto Universitario Orientale di Napoli dal 1992, Silvio Vita è stato ricercatore presso l’Università di Roma dal 1986. La sua formazione si è svolta soprattutto in Giappone, all’Università di Kyoto, dove è stato per cinque anni specializzandosi sulla storia del Buddismo in Giappone e in Cina. Poi ha seguito un corso di dottorato a Princeton, negli USA. Il suo campo di ricerca è il Buddismo medievale in Cina e in Giappone. Si è occupato molto della storia del canone buddista, cioè della collezione canonica delle scritture, che ha avuto un’evoluzione molto complessa che coincide con lo sviluppo storico del Buddismo in Asia Orientale. Ha approfondito anche le tradizioni Chan e Zen.
Docente di religioni e filosofie dell’Asia orientale all’Istituto Universitario Orientale di Napoli dal 1992, Silvio Vita è stato ricercatore presso l’Università di Roma dal 1986. La sua formazione si è svolta soprattutto in Giappone, all’Università di Kyoto, dove è stato per cinque anni specializzandosi sulla storia del Buddismo in Giappone e in Cina. Poi ha seguito un corso di dottorato a Princeton, negli USA. Il suo campo di ricerca è il Buddismo medievale in Cina e in Giappone. Si è occupato molto della storia del canone buddista, cioè della collezione canonica delle scritture, che ha avuto un’evoluzione molto complessa che coincide con lo sviluppo storico del Buddismo in Asia Orientale. Ha approfondito anche le tradizioni Chan e Zen. Sta per essere pubblicata in italiano una sua traduzione del Sutra del Loto dalla versione cinese di Kumarajiva e sta lavorando a una traduzione dello Heke monogatari, una delle opere più importanti della letteratura giapponese medievale di ispirazione buddista.
Dalla metà di marzo 2001 sarà il direttore della Scuola Italiana di Studi sull’Asia Orientale (Italian School of East Asian Studies), un istituto di ricerca gestito congiuntamente dal Ministero degli Affari Esteri, dall’Istituto Universitario Orientale di Napoli e dall’Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente (Is.I.A.O.), che ha sede a Kyoto e dalla fine del 2000 condivide lo stesso edificio della sezione di Kyoto dell’École française d’extrême orient.
Quest’ultima si occupa della compilazione dello Hôbôgirin, una monumentale enciclopedia del Buddismo basata sulle fonti cinesi e giapponesi, iniziata negli anni Venti dal grande orientalista francese Silvain Lévy. Nella sede, divisa a metà tra i due istituti, è stata sistemata la biblioteca di Étienne Lamotte, il noto studioso belga della storia e delle dottrine del Buddismo.
Riformatore attento e determinato, animato dallo scopo di chiarire i motivi e trovare i rimedi ai mali della sua epoca, Nichiren rivolge il suo messaggio sia al Giappone medievale del 1200 che al mondo contemporaneo. Abbiamo chiesto al professor Silvio Vita, tra i principali esperti in Italia di Buddismo medievale cinese e giapponese, di approfondire alcuni aspetti dell’insegnamento del fondatore della scuola buddista cui fa riferimento la Soka Gakkai.
Dal suo punto di vista di studioso, come può descriverci la figura di Nichiren nel Giappone del 1200?
Si tratta di una delle figure più forti e importanti nella storia del Buddismo giapponese, in particolare del Buddismo medievale. L’epoca in cui visse, nota come epoca di Kamakura, è in Giappone un periodo di transizione, sia dal punto di vista della storia civile e culturale, sia dal punto di vista della storia religiosa. Proprio per questo tratto caratteristico, il Buddismo del periodo di Kamakura è stato sovente etichettato in passato come un Buddismo nuovo, più tipicamente giapponese. Al di là del problema di stabilire se questa etichetta sia più o meno corretta, è importante individuare qui la presenza di una frattura con la tradizione precedente.
In questa frattura si inseriscono vari personaggi. Tra questi Nichiren spicca per la sua personalità, per il fatto che con il suo messaggio religioso, più che tendere a fondare una nuova “setta” vuole tornare alle origini della tradizione buddista, che in Giappone, per antonomasia, era rappresentata dal Buddismo Tendai.
Il Buddismo Tendai ha una lunghissima storia, che affonda le sue radici in Cina, e ha al centro della sua teoria esegetica delle scritture il Sutra del Loto, considerato nell’ottica mahayana il depositario del messaggio ultimo, più vero e più elevato del Budda Shakyamuni.
Nichiren, in chiave polemica soprattutto agli inizi, rileva come sia necessario ritornare alla centralità di questa scrittura, facendo notare come il Buddismo Tendai si fosse di fatto allontanato dalla sua direzione originaria. In particolare l’oggetto delle sue critiche è quello che nella letteratura specialistica occidentale viene chiamato “l’esoterismo buddista”, cioè quel tipo di Buddismo più tardo, dal punto di vista indiano, che divenne popolare in Cina e in Giappone a partire dal IX secolo e che penetra totalmente la tradizione Tendai. Come scuola indipendente esso è generalmente noto come Shingon, ma molte caratteristiche di questa tradizione penetrano a tutti i livelli nella scuola Tendai. La posizione di Nichiren si delinea dunque sia nella sua polemica contro la tradizione esoterica sia contro le nuove vie di salvezza che sono di attualità al suo tempo.
In questo periodo, che molte scritture buddiste definiscono epoca ultima della Legge, nascono molte nuove correnti religiose?
In quest’epoca il centro politico e culturale si sposta da Kyoto alla parte orientale del Giappone, nella città di Kamakura, la sede del governo degli shogun Hojo, alla cui corte vengono accolte una serie di dottrine, vie di salvezza, che in qualche modo costituiscono una novità. Tra queste vi sono le scuole Zen, tendenzialmente Rinzai – anche se lo Zen Soto ha tentato in vari modi degli approcci con il governo di Kamakura senza mai riuscire a penetrare, rimanendo nelle campagne, tra i monti, fino quasi all’epoca moderna. E poi le scuole amidiste, le scuole devozionali incentrate sul culto di Amida, che raccoglievano la popolarità e il favore delle masse.
Sullo sfondo di questa fioritura religiosa vi era la coscienza – e questo è ben presente anche nella predicazione di Nichiren – di vivere in un’epoca di declino, in cui gli insegnamenti del Budda si andavano perdendo, nella quale le forme tradizionali di pratica non erano più valide. La dottrina del declino della Legge è una caratteristica del Buddismo medievale in Giappone, e questa crisi sembrava confermata anche negli eventi storici. Proprio in relazione a Nichiren bisogna infatti ricordare i tentativi di invasione da parte dei mongoli, che egli avrebbe profetizzato e anzi indica come una sorta di punizione nei confronti dei governanti di allora. Vi erano complessivamente molti dati che sembravano confermare la pericolosità dell’epoca in cui ci si trovava a vivere.
Ma qual è la soluzione che propone Nichiren? Un ritorno alla pratica del Sutra del Loto. Il Sutra del Loto si offre, e se ne parla a più riprese nel testo, come mezzo di salvezza di per sé. Nichiren identifica se stesso con la reincarnazione del bodhisattva Jogyo, o Pratica costante, che doveva avere la funzione di far diffondere questa scrittura. Scrittura che aveva il potere di portare il praticante di nuovo in illo tempore, renderlo cioè contemporaneo della predicazione del Budda Shakyamuni.
La studiosa Beatrice Lane Suzuki, all’interno della classificazione tra scuole tariki – devozionali, che consideravano la salvezza come una sorta di grazia “divina” – e jiriki – basate sull’autoriforma – assimila il Buddismo di Nichiren alle scuole amidiste per la similitudine della recitazione del mantra, ponendoli entrambi all’interno del primo filone. Lei cosa ne pensa?
La distinzione tariki-jiriki veniva spesso usata in passato. La Suzuki scrive negli anni Trenta ed è influenzata dalle interpretazioni correnti in Giappone ai suoi tempi. Volendo classificare le scuole che si rifanno a Nichiren, io non so fino a che punto si possano definire tariki. Il tipo di pratica, che in effetti sembra simile al Nembutsu, l’invocazione del Budda Amida, è in realtà un tratto culturale dell’epoca, non riguarda solo Nichiren o gli amidisti, vi sono altri movimenti religiosi, anche ad esempio all’interno dello Shingon, che tendono a sposare la teoria che le pratiche complicate non sono fatte per l’umanità attuale e che quindi bisogna avere a disposizione qualcosa di particolarmente “facile”. E ognuno propone una sua ricetta. In quest’ottica possiamo leggere l’adozione da parte di Nichiren della recitazione del titolo e del testo del Sutra del Loto, metodo che peraltro non è legato soltanto all’epoca ma in qualche modo si rifà a una tradizione precedente, in origine cinese e forse anche indiana.
Del resto, il fatto che il titolo di una scrittura sacra avesse una potenza evocatrice è un concetto che troviamo spesso nella storia del Buddismo in tutte le culture. Forse questo è un tratto che accomuna le scuole amidiste e quelle di Nichiren. Però non c’è affatto nella dottrina di Nichiren la concezione dell’assoluta impotenza dell’individuo e quindi la necessità di un abbandono totale all’essere salvifico, all’intervento di Amida dopo la morte, come nelle scuole della Terra Pura. Anzi, nel Buddismo di Nichiren c’è la convinzione che attraverso un processo di disciplina interiore si possa vivere l’insegnamento di Shakyamuni secondo il Sutra del Loto. Una differenza che lo distingue profondamente dalle scuole amidiste.
Come mai Nichiren viene considerato dagli storici, anche attuali, una figura scomoda, intransigente, dai tratti violenti?
Indubbiamente c’è un tratto di intransigenza dottrinale. Non ci sono altri esempi, nella storia religiosa, di personaggi che si sono posti in maniera così decisa anche nei confronti dell’autorità civile. Un atteggiamento che ha creato non pochi problemi a Nichiren: l’aver ammonito i governanti, cosa che nella cultura dell’epoca era considerata molto sconveniente, l’aver sottolineato la poca purezza dottrinaria della scuola Tendai e delle scuole amidiste. Tutto ciò lo ha esposto ad attacchi anche violenti da parte di comunità di monaci e dei signori che le proteggevano. Le vicende della sua vita sono abbastanza note: agguati, imboscate, due volte in esilio e via dicendo. E alla fine, come spesso succedeva nel Giappone medievale, l’aver trovato un’autorità che lo proteggesse lo ha messo al riparo da ulteriori persecuzioni o scontri.
Questo carattere di intransigenza si ritrova anche in alcuni filoni della storia delle comunità che a lui si sono rifatte nei secoli successivi. Forse il caso più estremo sono le comunità Nichiren che sotto il dominio Tokugawa, nel XVII-XVIII secolo, affermavano di non volere aver niente a che fare con l’autorità costituita, non accettando nemmeno il supporto economico del governo. Ciò ha contribuito a creare un’immagine non direi di personaggio violento ma sicuramente di persona, di insegnamento intransigente rispetto ad altre scuole.
Per quanto riguarda invece il problema della violenza in generale, questo è un tratto culturale della società dell’epoca. Nella società medievale giapponese era diffusa anche tra i monaci buddisti l’abitudine a menar le mani, a scontrarsi. C’erano delle vere e proprie enclavi, una specie di stati semiindipendenti retti da comunità di monaci. Erano i cosiddetti ikki, delle forme di autogoverno generate da sollevazioni che davano luogo a territori in cui ci si autogovernava, dove la comunità ecclesiastica o religiosa aveva il potere. Non si tratta però dell’epoca di Kamakura ma di un periodo più tardo. C’erano delle zone rette dalle scuole della Terra Pura e altre dalla Hokke shû, la scuola del Sutra del Loto, che faceva riferimento agli insegnamenti di Nichiren. Non che la Hokke shû o le scuole amidiste fossero particolarmente violente, ma si tratta di un’epoca in cui i metodi violenti erano all’ordine del giorno. Non dimentichiamo comunque che, in nessuna epoca passata, la violenza è mai arrivata ai livelli raggiunti in epoca moderna, dalla rivoluzione francese in poi.
Generalmente il Buddismo viene considerato una religione pacifista.
In fondo tutte le religioni lo sono e non lo sono. Il Buddismo non predica la violenza, certo, ma non è neanche vero che nel corso dei secoli i buddisti siano stati particolarmente teneri, o più pacifisti di altre tradizioni religiose. Hanno combattuto guerre, hanno sostenuto guerre, sono andati in guerra, si sono combattuti tra loro.
Si dice però che il Buddismo non abbia mai generato guerre di religione.
Certo, però di persecuzioni ne ha generate abbondantemente, in Cina soprattutto. In Giappone, in realtà, grandi guerre non se ne sono mai fatte, almeno nei confronti di altre nazioni, anche perché era tecnicamente difficile farle. Non ci sono state guerre di religione in senso stretto, che avessero cioè l’obiettivo di far diventare buddisti degli altri, però guerre tra istituzioni religiose diverse sì. E c’è stato anche il sostegno di monaci buddisti alle guerre. In tutte le operazioni militari che nel corso della prima parte del Novecento hanno compiuto in Cina e altrove, i giapponesi hanno potuto contare sul sostegno indubbio di parte del clero. In India non sappiamo bene, ma dalle testimonianze archeologiche si trovano resti di monasteri bruciati da altre comunità buddiste della città accanto. Insomma non metterei troppo un’aureola di santità rispetto alle vicende storiche, ma bisogna vedere queste vicende in modo molto disincantato. Secondo me è profondamente sbagliato giudicare con il metro della morale di questo secolo vicende che appartengono al passato remoto.
Quello che conta è la coscienza di coloro che nel mondo contemporaneo si professano buddisti, come vivono il problema del pacifismo, che in realtà è un tema del nostro secolo.
Ma torniamo a Nichiren, che ha scritto pochissimi trattati dottrinali, esponendo i suoi insegnamenti soprattutto attraverso lettere ai discepoli.
Nichiren è stato addirittura considerato un modello di questo genere letterario. Il fatto che abbia scelto questa forma particolare di esposizione della dottrina, quella della lettera, è dovuto alle circostanze della sua vita. La forma del trattato scolastico ha un senso nel caso in cui la carriera monastica di un individuo si svolga all’interno di una struttura costituita. Questo non è stato il caso di Nichiren. Lui, più che utilizzare la chiosa del testo, ha sempre avuto l’esigenza di convincere, spiegare. E lo ha fatto nella forma di piccoli trattati e soprattutto di lettere mandate ai discepoli e sostenitori.
Oppure in forma di trattato polemico, come il Risshô ankoku ron, che può comunque rientrare nel medesimo genere di letteratura che ha come obiettivo la predicazione, la spiegazione, diretta in questo caso agli shogun Hojo.
Aveva anche un grande rispetto per le donne, molte infatti erano sue discepole.
Il rispetto per le donne è un tema importante nel Buddismo giapponese, importante e scottante allo stesso tempo. Se le donne abbiano o meno la possibilità di raggiungere lo stato di Budda, conseguire l’Illuminazione, è una questione antica, risale al Buddismo indiano. Si disquisiva se lo potessero fare trasformandosi in uomini oppure no, come in alcuni passi famosi delle scritture. E anche qui Nichiren si inserisce bene, lasciando un messaggio che ha veramente le sue radici nell’epoca in cui visse.
Il problema della salvezza era centrale: se fosse o meno destinata a tutti, comprese le donne e quei personaggi, che venivano chiamati akunin, i quali per il tipo di attività che svolgevano venivano automaticamente a porsi fuori da ogni possibilità di salvezza. Erano coloro che avevano a che fare con l’uccisione di animali.
Come la stessa famiglia di Nichiren, che era figlio di pescatori?
Certo. Questo aspetto personale e familiare lo spingeva ancora di più a porsi il problema di quanto dovesse essere vasto il campo delle persone, donne comprese, che avevano la possibilità di giungere all’Illuminazione.
Può parlarci dell’influenza del Sutra del Loto in India, Cina e Giappone?
Il Sutra del Loto è la scrittura buddista più rappresentativa del Buddismo dell’Asia orientale. Sulla situazione di questa scrittura in India sappiamo ben poco, come sappiamo ben poco riguardo a tutto ciò che ha a che fare con il Buddismo indiano. È un problema di fonti, di documenti. L’unica documentazione in nostro possesso è molto recente ed è di carattere archeologico.
C’è il Canone pali.
Però il Canone pali non è antichissimo. È un prodotto tardo della cultura buddista indiana. Paradossalmente sono molto più antichi testi in lingua cinese, sutra mahayana e non, tradotti in cinese in epoche più antiche. Il Sutra del Loto è stato tradotto a varie riprese: sicuramente il testo che è diventato canonico, anche per le sue caratteristiche estetiche, risale al V secolo ed è la traduzione di Kumarajiva, una delle figure centrali nella storia delle traduzioni delle scritture in cinese. Per inciso, bisogna sottolineare che è erroneo parlare di “traduzione di Kumarajiva”, perché la traduzione non veniva affidata solo a un individuo ma era un processo molto ritualizzato tra un gruppo di persone, in genere organizzato da qualche corte imperiale, in cui erano presenti monaci indiani o centroasiatici, letterati cinesi, funzionari di corte, dove la funzione del traduttore era quella di supervisore. In ogni caso il Sutra del Loto diventa canonico nell’Asia cinese e giapponese sicuramente con Kumarajiva, e acquisisce definitivamente questa autorità nell’ambito del Buddismo T’ien-t’ai.
Il Buddismo Tendai è una pietra miliare nella diffusione del Sutra del Loto?
Certamente. Infatti nella storia del Buddismo cinese, dopo qualche secolo di traduzioni di testi che rendevano disponibili in lingua cinese scritture che appartenevano a epoche e a filoni dottrinari diversi, e che a volte nei contenuti sembravano contraddittorie, ci si pose il problema di capire o di dare un ordine a tutto ciò. Cercando di spiegare – poiché per convenzione retorica le scritture stesse si presentano tutte come parola del Budda – dal punto di vista esegetico perché da una parte si afferma una cosa e dall’altra quella opposta. Di fronte a questo importantissimo problema religioso, nella Cina del VI-VII secolo si produssero dei veri e propri monumenti esegetici, dei complessi sistemi che organizzavano le varie scritture, classificandole e motivando le apparenti contraddizioni attribuendo le differenze a diversi momenti della vita del Budda o a predicazioni indirizzate a diversi gruppi di persone.
Oltre alla costruzione teorica T’ien-t’ai o Tendai ne esistevano altre, e in tutte il Sutra del Loto aveva un posto molto importante, proprio per il suo messaggio salvifico universale che aveva fin dal primo momento attirato l’interesse religioso e spirituale dei cinesi. Era considerato l’insegnamento definitivo del Budda Shakyamuni. Nella costruzione Tendai, che poi venne accettata soprattutto in Giappone, il Sutra del Loto è messo all’apice di questa scala gerarchica di scritture e questo lo ha posto di conseguenza anche al centro del Buddismo giapponese da una certa epoca in poi.
Si può affermare che il Buddismo Tendai, dall’inizio del IX secolo, coincide esattamente con le basi teoriche del Buddismo giapponese, sia nella versione che conosciamo noi, basata sull’esegesi e sulla capacità di racchiudere in sé tutta la tradizione buddista precedente, sia nella sua versione che definirei magico-rituale, cioè quella influenzata e penetrata dalle forme dell’esoterismo buddista. Questi due aspetti della scuola Tendai hanno costituito la base teorica di tutto il Buddismo giapponese fino a epoche abbastanza recenti. Non è un caso che dalla scuola Tendai siano nate tutte le scuole devozionali, compresa la scuola di Nichiren, che si ricollega alla parte centrale di questa dottrina. Anche le scuole della Terra Pura sono state formate all’inizio da monaci Tendai, che si sono poi distaccati sostenendo che l’epoca in cui si viveva era tanto terribile da potersi affidare soltanto alla grande compassione di Amida. Ma il culto del Budda Amithabba o Amida era già presente all’interno del pantheon Tendai, che comprendeva un numero infinito di pratiche. Anche i primi monaci Zen che andarono in Cina per cercare di avere un contatto diretto con i rappresentanti di questa tradizione erano venuti a conoscenza di questo insegnamento all’interno della scuola Tendai.
In definitiva, si può dire che il Sutra del Loto contenga tutta una serie di idee e di concetti, come quello della salvezza universaleo della natura di Budda comune a tutti gli esseri, che diventano una specificità non solo del Buddismo giapponese ma anche di forme devozionali di altro genere, come ad esempio il culto di Kannon, il cui fondamento scritturale si trova nel Sutra del Loto, tanto è vero che il capitolo omonimo viene diffuso addirittura come scrittura indipendente e sta alla base delle forme devozionali rivolte a questo bodhisattva.
Perché in Occidente l’insegnamento di Nichiren molte volte non è stato considerato Buddismo? Perché non viene riconosciuto il suo retroterra dottrinale?
Nella storia della presentazione del pensiero buddista in Occidente possono essere individuati due canali. Uno proviene dall’India, dagli studiosi occidentali che nell’Ottocento scoprono il sanscrito nell’ottica di una riscoperta delle radici indoeuropee della nostra cultura. Essi scoprono così anche il Buddismo, che viene presentato come una sorta di religione atea, che non ha bisogno di dèi, nell’ambito di una polemica religiosa che opponeva la cultura positivista dell’Ottocento alla Chiesa.
L’altro canale invece non è intellettuale, e non viene presentato attraverso libri che scrivono professori universitari dopo aver letto dei testi, ma è un insegnamento testimoniato direttamente dai rappresentanti di una cultura buddista vivente. Questo filone ha come intermediario il Giappone, indubbiamente anche qui per motivi storici. Infatti il Giappone, tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, era l’unica nazione asiatica che si poteva porre su un piano di quasi parità con le nazioni europee e aveva quindi accesso alle platee occidentali. E qui sta il punto: in questo canale non si è inserito alcun personaggio giapponese che fosse in qualche modo affiliato alla figura di Nichiren. Le scuole buddiste giapponesi più reattive alla cultura intellettuale europea nella seconda metà dell’Ottocento sono state infatti quelle della Terra Pura e i rappresentanti dello Zen, in particolare Shaku Soen, che è stato uno dei rappresentanti giapponesi al grande parlamento delle religioni di Chicago nel 1890, e che ha poi mandato Suzuki Daisetsu in America e in Europa.
Invece i rappresentanti delle scuole amidiste in quell’epoca hanno mandato studiosi a formarsi nelle università europee. Uno famoso è Anezaki (meglio conosciuto come Anesaki) Masaharu, che ha studiato a Oxford e che era di ascendenza Jodo shinshu, e tanti altri. Tutti loro hanno costruito l’immagine del Buddismo giapponese agli occhi dell’Europa. Tra Ottocento e Novecento le scuole che si rifacevano a Nichiren sono invece rimaste un po’ chiuse in ambito giapponese, e quindi non si sono fatte conoscere. Inoltre sin dall’epoca di Nichiren sia lo Zen che le scuole della Terra Pura erano state oggetto di feroci critiche nel corso dei secoli, e quindi avevano una visione estremamente negativa di questo insegnamento, e lo presentavano così all’Occidente.
Queste sono le ragioni storiche. Ma adesso si ha una visione più equilibrata e concreta del panorama del Buddismo giapponese. Se si deve parlare di eterodossia, nei confronti del Buddismo sino-indiano, allora questo vale per qualsiasi forma di Buddismo giapponese. È chiaro che un pensiero religioso, dovendosi adattare a un contesto culturale, deve assumere delle caratteristiche peculiari.
Perché il Buddismo oggi in Giappone viene chiamato la religione dei funerali?
Quando alla fine del secolo scorso ci si cominciò a confrontare con le nazioni occidentali, venne messa in luce la diversità delle forme di aggregazione religiosa in Giappone da quelle della tradizione giudaico cristiana. La definizione di “religione dei funerali” è stata data proprio dai giapponesi: il termine è sôshiki bukkyô, e lo hanno inventato i sociologi e gli storici delle religioni per descrivere la religiosità della popolazione giapponese nelle statistiche presentate dai governi giapponesi nei consessi internazionali.
In Giappone c’è stato un fenomeno che non riguarda tanto la storia religiosa quanto quella istituzionale e dei rapporti con la diffusione del Cristianesimo. A partire dagli inizi del XVII secolo, gli shogun Tokugawa espulsero i missionari e perseguitarono ferocemente i cristiani. Questo è un fatto storico appurato. Per controllare la popolazione, per evitare che si convertisse, a un certo punto emanarono una serie di editti che obbligavano chiunque a registrarsi presso un tempio. Tutti i templi avevano cioè la funzione di uffici dell’anagrafe, un po’ come succedeva per le nostre chiese. Quindi a partire dal 1700 tutti dovevano dichiarare di appartenere a un determinato tempio. Solo in rari casi era una adesione di carattere religioso individuale, era più che altro un fatto che coinvolgeva la comunità locale. Se in un certo paese il tempio del villaggio era della scuola Shingon, allora gli abitanti erano Shingon. Questa situazione è stata poi lasciata in eredità al secolo scorso e a questo. Perciò quando si chiede a un giapponese a quale scuola appartenga, la sua risposta non deriva da una scelta religiosa o da una conoscenza particolare, ma dal fatto che quella è la tradizione di famiglia, perché lì si vanno a fare i funerali. Tutto ciò non ha niente a che vedere con un’adesione di carattere spirituale, non c’entra assolutamente nulla con la scelta religiosa. Per questo si dice che il Buddismo giapponese è la religione dei funerali.
L’adesione volontaria a una dottrina o a un’altra ha preso, dal secolo scorso in poi, altri canali. Che possono essere ad esempio le scuole di tipo laico che si sono sviluppate in Giappone nel corso del Novecento, o i tantissimi nuovi movimenti religiosi, alcuni di carattere sincretico, che sono sorti anch’essi nell’ultimo secolo. Un’altra definizione che viene data al Giappone è quella di supermercato delle religioni. C’è una scelta tale che non trova riscontro in nessun’altra cultura contemporanea.
Per tradizione poi, da una certa epoca in poi, è invalso l’uso del matrimonio nel santuario shintoista. È un fenomeno molto recente, nato nel primo decennio di questo secolo. In Giappone tradizionalmente il matrimonio era un atto amministrativo, non aveva nessuna componente religiosa. Però con l’apertura all’occidente ci si è accorti che nella tradizione europea c’era questo aspetto e allora, in occasione delle nozze dell’imperatore Taisho, si è studiato un modo per avere una riedizione giapponese del matrimonio religioso. E ci si è inventati quasi lo shinzen kekkon, il matrimonio davanti all’altare degli dèi, che poi è diventato la norma.
Ma comunque il fatto che il matrimonio fosse un momento di passaggio, senza alcuna sanzione spirituale o religiosa, è rimasto nella mentalità dei giapponesi. Inoltre, come è diventato popolare il matrimonio shinto, così sta diventando popolare sposarsi in chiesa, ma è una festa, che nella maggior parte dei casi non ha nessun’altra componente di tipo religioso.
Quando parlava di scuole laiche, a quali si riferiva?
Mi riferivo a organizzazioni del tipo della Soka Gakkai o della Rissho kosei kai, che sono le più importanti soprattutto in termini numerici e quindi di penetrazione nella società, ma che non sono le uniche. Vi sono anche scuole laiche legate a una tradizione monastica, o altre che non hanno l’importanza sociale di quelle che abbiamo appena citato e che si ispirano ad altre tradizioni più antiche, buddiste e non, ad esempio di ascendenza shinto. Si tratta di gruppi di persone che si organizzano per praticare una certa disciplina spirituale al di fuori delle tradizioni precedenti, ossia non incentrandola sulla condizione di monaco. Anche se l’aspetto laico del Buddismo in Giappone ha una tradizione abbastanza antica.
Che incidenza ha nel Buddismo la figura dei laici?
L’immagine del Buddismo come una religione tipicamente monastica ci deriva dalla scuola che definiamo “anglo-pali”, quel tipo di Buddismo basato sulla tradizione theravada che è stato presentato in occidente nell’Ottocento e che è molto incentrato, anche nelle società attuali che lo vivono, sulla condizione di monaco. Invece la tradizione mahayana, e comunque la tradizione indiana del nord e quella cinese, ha sempre avuto una componente laica fortissima. I laici hanno fatto parte a tutti gli effetti della comunità buddista sia come supporto che come oggetto di attenzione da parte del monaco. L’istituzione buddista, più che rappresentare un monastero nel senso proprio del termine, cioè un luogo di reclusione, aveva il ruolo di tempio, di centro della comunità, di luogo dove si dovevano soddisfare le esigenze religiose non solo di chi dedicava la propria vita alla pratica monacale ma anche delle persone che vivevano attorno. A testimonianza dell’importanza dei laici nella vita religiosa buddista, non solo in Giappone ma anche in India e in Cina, in un certo filone della letteratura mahayana la figura del laico viene addirittura idealizzata e presentata come quella del saggio per antonomasia, di colui che può insegnare addirittura ai monaci. La figura del bodhisattva, in realtà, in sé è modellata su quella del principe, non su quella del monaco. Non dobbiamo quindi aspettare il Giappone del Novecento per scoprire i laici nel Buddismo.
Dal suo punto di vista di studioso, qual è il legame della Soka Gakkai con Nichiren?
La Soka Gakkai ha sempre tenuto a presentarsi non come un nuovo movimento religioso ma come depositaria di una tradizione antica che si rifà alle dottrine di Nichiren. Un modo per vivere questa tradizione in una cultura moderna e profondamente cambiata rispetto alle condizioni del Giappone medievale, con una penetrazione nella società di notevole rilevanza. Con scelte sofferte che ha dovuto fare, soprattutto in Giappone: mi riferisco in particolare al complesso problema dei rapporti tra organizzazione religiosa, per quanto laica, e attività politica, in particolare quella del Komeito, il partito politico originariamente collegato alla Soka Gakkai. Negli ultimi anni si è un po’ allentato il legame molto stretto che esisteva tra le due organizzazioni: recentemente il Komeito ha svolto il suo ruolo politico con maggiore indipendenza e anche con maggiore spregiudicatezza rispetto alle sue posizioni passate.
Comunque sia, la Soka Gakkai è stata l’organizzazione che ha portato il messaggio di Nichiren alla portata di tutti, e lo ha diffuso in tutto il mondo.
Buddismo e Società n.85 – marzo aprile 2001
